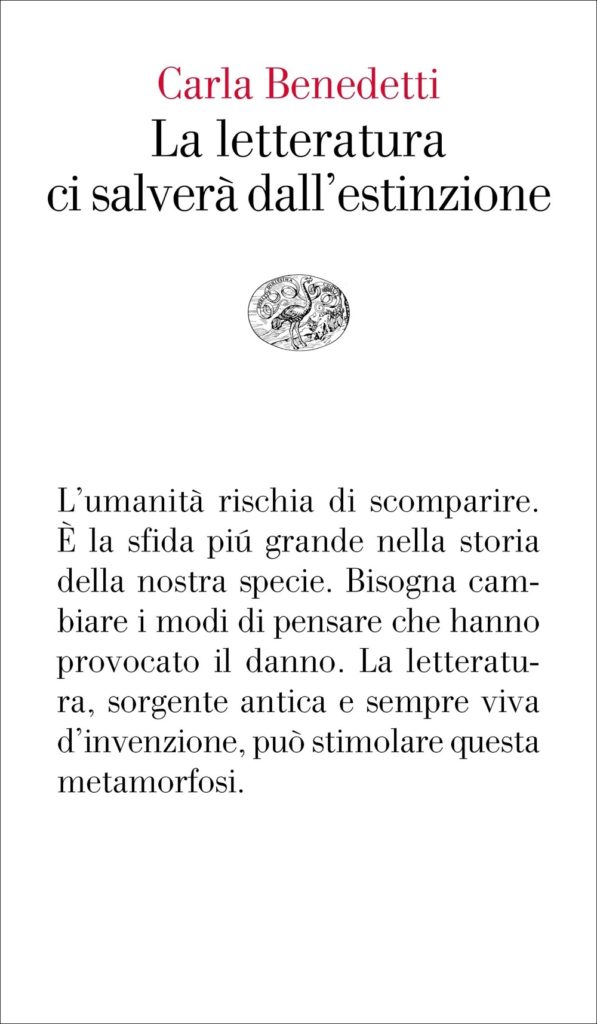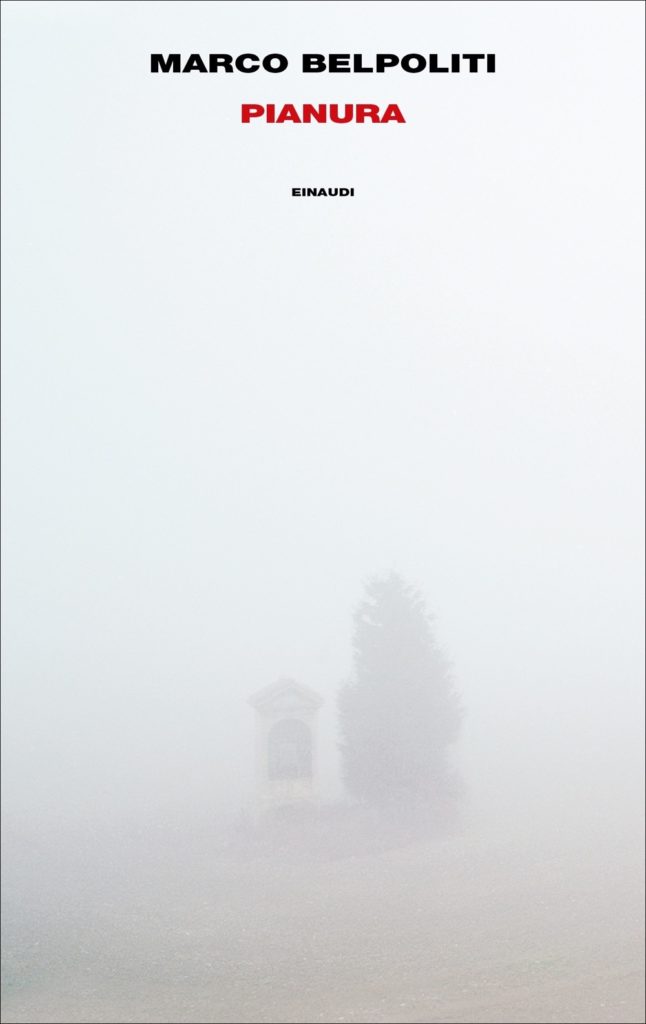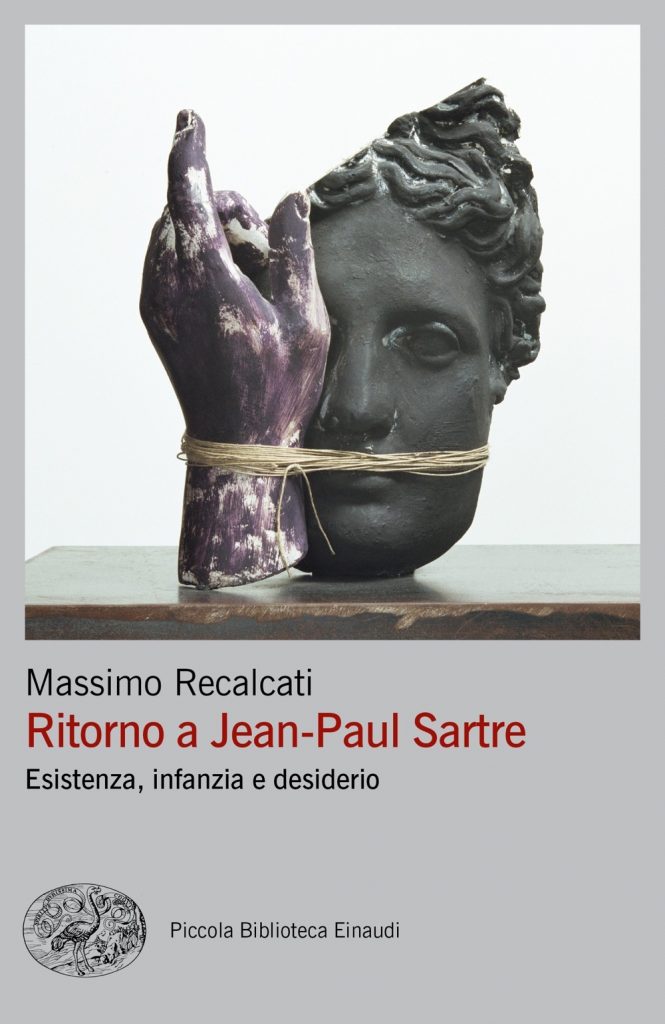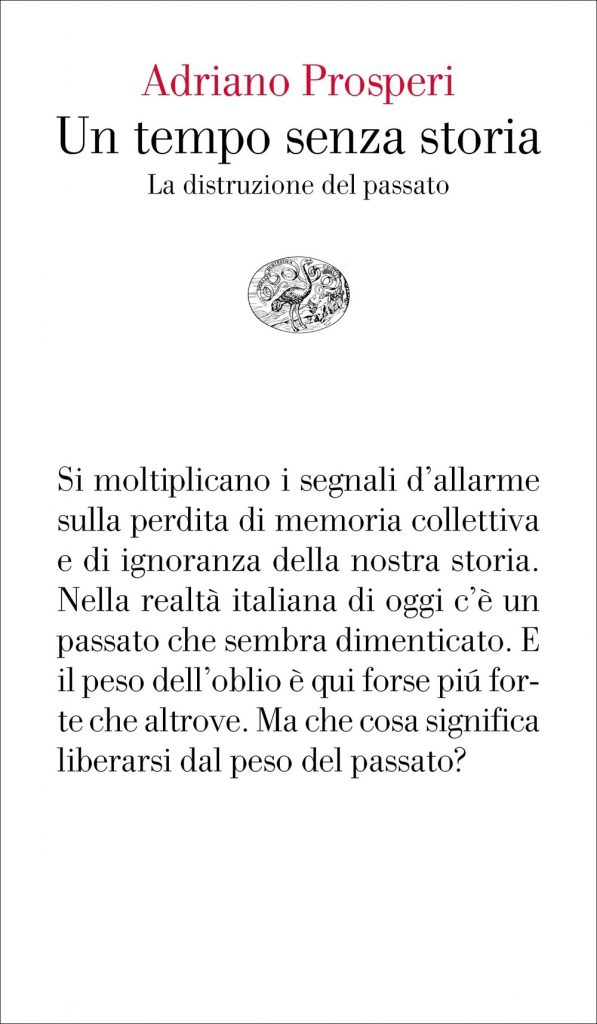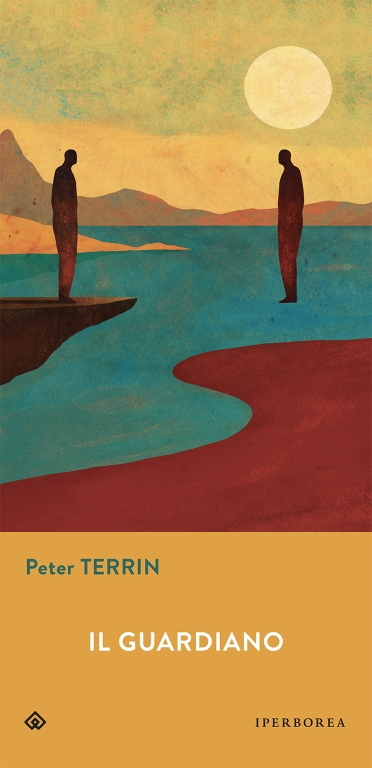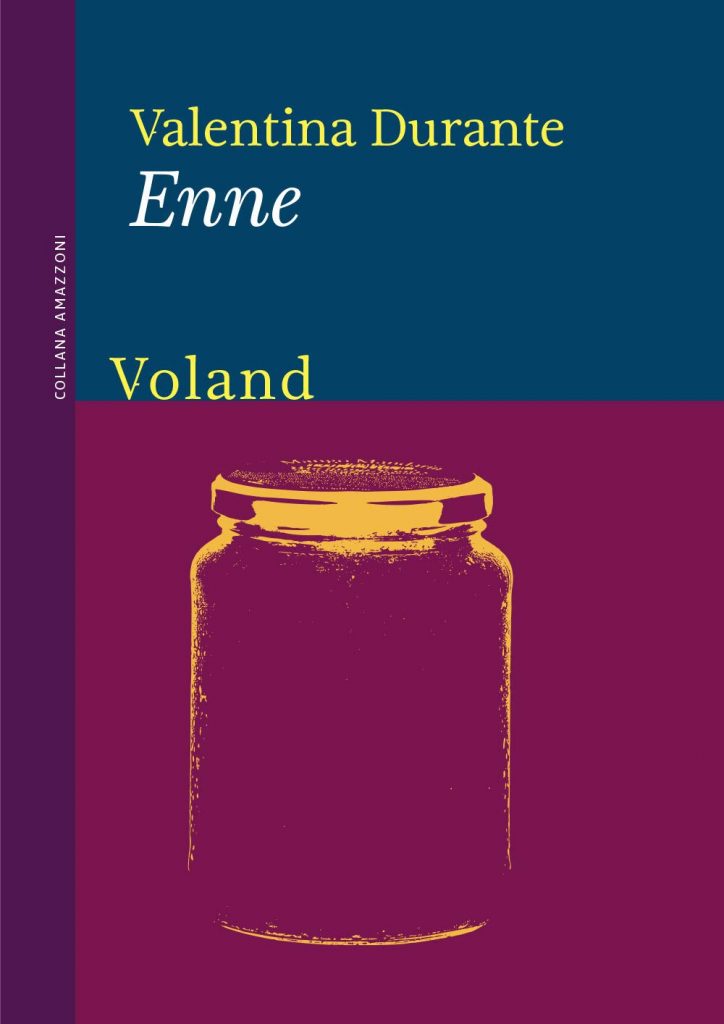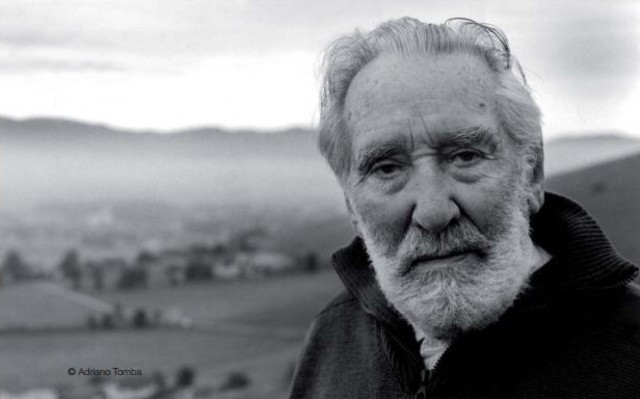Elisabetta Abignente, Rami nel tempo. Memorie di famiglia e romanzo contemporaneo, Donzelli 2021
“Quel che possiamo fare per coloro che ci hanno preceduto è ricordarne i nomi e raccontarne le vite”. Ma non si tratta solo di loro. Quelli che scrivono della propria famiglia lo fanno “per capire sé stessi attraverso uno studio anatomico della cellula della società che li ha generati” – “nella consapevolezza che una personalità si forma in continuità e in opposizione a chi, sulla linea generativa la precede e la segue” – e insieme per “guardare alla storia collettiva di una comunità, di un paese, di un popolo”. Lontane dal ripiegamento intimistico, come dal narcisismo che si può annidare nella nostalgia, scrivendo “memorie di famiglia” autori fra loro diversi hanno messo al mondo romanzi intramontabili, componenti essenziali del nostro patrimonio culturale: da Lessico famigliare dei Natalia Ginzburg alla trilogia del Labirinto del mondo di Marguerite Yourcenar, dai Buddenbrook di Thomas Mann a Cent’anni di solitudine di Gabriel Garcia Marquez, da Gli anni di Annie Ernaux fino al recente, possiamo aggiungere, “ritratto di una famiglia esperta in autodistruzione” in cui consiste – secondo la definizione dell’autore stesso – Il libro delle case di Andrea Bajani (ne parliamo qui). Romanzi diversi, segnati da una mix a proporzione variabile fra testimonianza fedele e libera finzionalità, a seconda che la storia riguardi i tempo recenti della famiglia, facendo quindi della memoria personale dell’autore la fonte principale, o risalga invece nel tempo di diverse generazioni come avviene nelle saghe, in cui chi scrive si fa storico e persino archivista e nel contempo non può che lasciare spazio alla propria immaginazione letteraria.
Continua a leggere L’imperativo genealogico