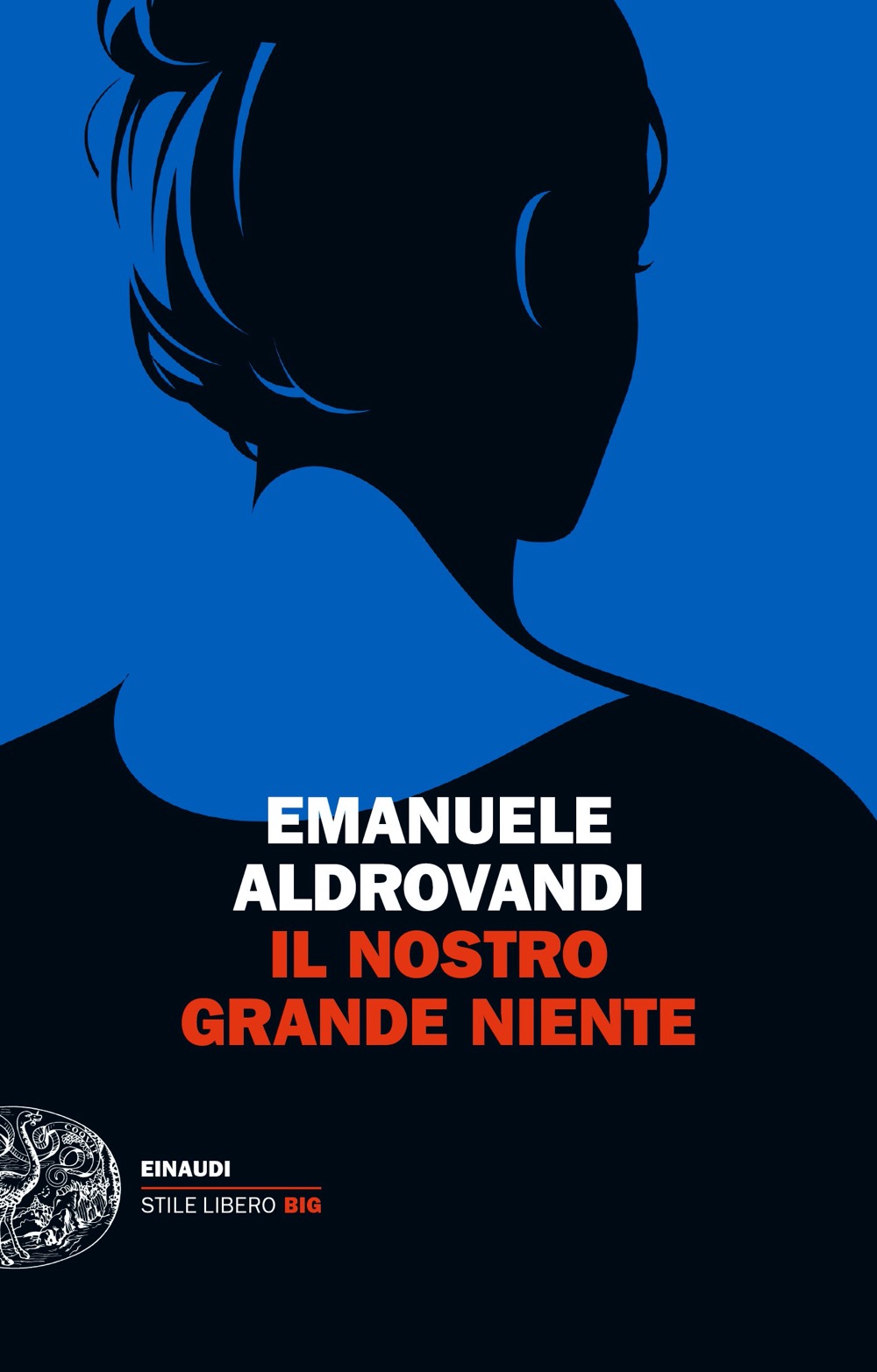
Emanuele Aldrovandi, Il nostro grande niente, Einaudi 2024 (pp. 200, euro 17)
La classica fantasticheria di continuare a vedere che cosa succede una volta che non si è più: sintomo dell’impossibilità di pensare davvero la propria morte, secondo la psicanalisi; occasione di un racconto leggero e intenso per l’autore, che all’indomani dell’incidente stradale che l’ha ucciso si aggira nella propria casa prendendo atto che le sue cose gli sono sopravvissute: “Sul bordo del lavandino è ancora appoggiata la tazza del latte (…). Il computer è aperto sul tavolo, esattamente dove l’ho lasciato. Bottiglia dell’acqua da un lato e pacchetto di grissini alle olive dall’altro, resti di una mattina passata a scrivere e sgranocchiare.” E oltre le cose, le persone ovviamente.
La compagna innanzitutto, che avrebbe dovuto sposare pochi giorni dopo. La vede mentre per la prima volta si stende nel loro letto da sola e si chiede dove sarà lui, ora, ma non solo la vede, le parla anche: “io non sono da nessuna parte e questo è un vero peccato. Sarebbe bello se una volta morti si potesse uscire da sé stessi per sedersi qualche minuto nel cinema deserto in cui è stata proiettata la propria vita. Almeno per guardare i titoli di coda e farsi le classiche domande che ci si fa alla fine dei film. Mi è piaciuto? Di cosa parlava? Quali erano i personaggi più importanti? Ha avuto un qualche senso?”. (Fantasie inevitabili per l’autore, queste, essendo lui anche regista e autore per il teatro e il cinema).
Il tempo trascorre, anche se lui non c’è più: “Oggi c’è stato il funerale. Il sacerdote era lo stesso che avrebbe dovuto sposarci”. Il racconto procede, sempre in seconda persona, ed è a lei che si rivolge, attribuendole i pensieri che immagina stia facendo e non solo: anche le risposte che lei potrebbe dargli. La leggerezza sorridente del resoconto di questi colloqui sa coniugarsi con il rimpianto della compagna, stimolato ad ogni momento dai ricordi più banali, come quelli dei film visti insieme. Dopo mesi lei soffre ancora: “ti sforzi di pensare ai momenti in cui litigavamo ma anche quello non funziona, perché ti mancano anche i nostri litigi”. Quando sembrerebbe profilarsi un passo significativo oltre il lutto (“ieri sera sei andata a letto con un tuo ex”), lei pensa bene di entrare nel computer dello scomparso e vi trova la lunga lettera che lui le aveva scritto, ma non inviato, il giorno del previsto matrimonio: è la storia del loro amore, che culmina in una scoperta fondamentale per lui, che si era iscritto a filosofia per vedere se qualcuno avesse trovato un senso della vita: “mi sento in grado di affrontare l’assurdità del tutto, perché almeno non la sto affrontando da solo, ma con te. E vorrei che domani celebrassimo questo, insieme”.
Il racconto conferma via via la propria originalità: l’elaborazione di un lutto narrata non dal sopravvissuto ma dallo scomparso.
Anche dopo il matrimonio con un nuovo compagno, lei continua a sentire l’assenza del primo amore (“non è più la mancanza tagliente dell’inizio e non è neanche il dolore della perdita. Una vaga malinconia”), ma questo non le impedisce di vivere la propria vita, di avere due figli, di realizzare la propria carriera nell’editoria (anche se “all’aumentare dell’appagamento corrisponde un progressivo calo dell’entusiasmo”), di andare avanti anche dopo che è andata in pensione ed è rimasta vedova (ma “da quando tuo marito è morto, tiri avanti senza pensare troppo al futuro. Hai sofferto molto, ma ormai sei abituata a soffrire”): il racconto ha preso la piega della storia di una vita, di una vita come le altre, di tutte le vite, pervase da “quella malinconia che deriva dalla consapevolezza che la parte migliore ormai è passata”.

Non è invece pacificato l’animo del protagonista, incapace di prendere atto che “si esiste un po’, poi si muore e si sparisce, è ‘normale’”: è l’inaccettabilità di questa normalità, lo scandalo rappresentato dal fatto che il mondo continuerà senza di noi, il tema della seconda parte, un confronto senza vie di fuga con il sentimento della caducità che per il convalescente avvolge luoghi, cose, persone e ne incrina la rassicurante familiarità, dilagando nella visione tragica di Salomone, probabile autore del Qoelet. Senonché, aggiunge il nostro con un’ironia sempre più messa alla prova, “duemila anni dopo, mi sentivo esattamente come lui. Solo con meno sapienza e senza essere re d’Israele in Gerusalemme”. Se dovesse descrivere la sua vita, infatti, non vi vedrebbe che “una serie di tentativi di sconfiggere la morte; fare, andare, godere leggere, studiare (…) tutto nella speranza di trovare un appiglio a cui aggrapparmi, per non sprofondare in quel baratro che mi sono sempre sentito sotto il piedi”. Anche il loro amore, a dispetto di quanto aveva scritto in quella lettera alla vigilia del loro matrimonio, non era che uno di questi tentativi, e “adesso non funziona più”: è così che mi sento. Irrimediabilmente solo, nell’affrontare qualcosa di inaffrontabile”, ma ciononostante deciso a non lasciarsi scappare anche questa “vanità delle vanità” che, come tutto, è anche il loro amore.
Non andrà così: finirà, il loro amore. Ma loro sopravvivranno entrambi.
Questo testo compare anche nel sito della nuova libreria Rinascita di Brescia, alle cui attività culturali Carlo Simoni collabora.
