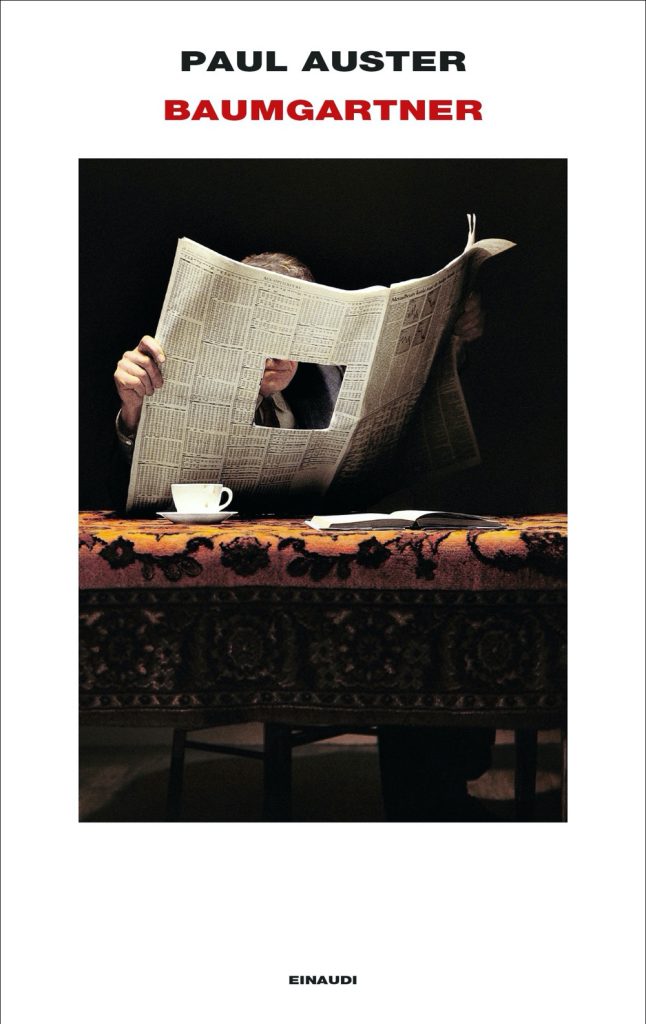
Paul Auster, Baumgartner, Einaudi 2023 (pp. 160, euro 17.50)
Una “radiosa attenzione”, “la potenza di una personalità luminosa, vitalità umana in tutto il suo vibrante splendore che si sprigiona dall’interno verso l’esterno in un balletto serrato e complesso fra ragione e sentimento”: ecco “la cosa che aveva Anna”, la moglie che l’ha lasciato da qualche anno, “prigioniero del suo presente”, lui come chiunque viva, “dal momento in cui nasce fino al giorno in cui muore”. Ma il professor Baumgartner, per quanto solitario, non ha perso interesse per gli altri, i pochi che la sua quotidianità gli fa incontrare, né si piange addosso, per quanto abbia momenti in cui il rimpianto lo aggredisce e, di fatto, si senta “un moncone umano, un mezzo uomo che ha perso la metà di se stesso che lo rendeva intero”.
Ma “le persone muoiono. Muoiono giovani, muoiono vecchie e muoiono a cinquantotto anni”, come Anna: “Mi manca, tutto qui”, riconosce Baumgartner nello sforzo di comprendere il proprio dolore, di non lasciarsene sopraffare: “Era l’unica persona al mondo che io abbia mai amato, e ora devo trovare un modo per continuare a vivere senza di lei”.
È la storia di un dolore, che Auster ci racconta, seguendo nei suoi passi incerti e spesso contraddittori quel “lavoro del lutto” su cui abbiamo letto recentemente i saggi di Massimo Recalcati, La luce delle stelle morte. Saggio su lutto e nostalgia, e di Claire Marin, La fine degli amori e altri adii che trasformano la nostra vita (in queste note, rispettivamente nel marzo e nell’ottobre scorsi). Ma questo è un romanzo: l’evoluzione dei sentimenti dell’uomo che ne è protagonista è lenta, fa tutt’uno con i suoi gesti quotidiani, ha una verosimiglianza che ci rende partecipi di un’esperienza, anche se non è la nostra.
Dopo alcuni mesi in cui “era quasi diventato irriconoscibile ai propri occhi” e “aveva affrontato le giornate a tentoni”, passano anni in cui il protagonista si direbbe essersi ripreso, ma è soltanto apparenza: “Baumgartner si emoziona ancora, ama ancora, desidera ancora, vuole ancora vivere, ma nell’intimo è morto. Sono dieci anni che lo sa, e sono dieci anni che fa il possibile per ignorarlo”. Poi, dei banali incidenti quotidiani – quelli da cui prende le mosse il racconto: una scottatura in cucina, qualche botta per una caduta per le scale di casa – si rende conto “di non aver fatto che allontanarla e aggrapparsi a lei nello stesso tempo, liberando la casa da ogni sua traccia ma mantenendo intatta la stanza dove lavorava”, dove le sue cose, le cose che erano sue e le sono sopravvissute, continuano ad occupare il posto che lei gli aveva dato ad esempio: “si era reso conto di aver combinato un gran pasticcio. Vivere è provare dolore, si era detto, e vivere con la paura del dolore significa non voler vivere”
Decide di scrivere un “saggio sulla sindrome dell’arto fantasma, che ha cominciato a chiamare sindrome della persona fantasma via via che le corrispondenze metaforiche gli sono sembrate sempre più evidenti”: come l’arto amputato, “La persona che non c’è più era attaccata a un’altra persona viva, e se siamo quelli che continuano a vivere, scopriremo che la nostra parte amputata, la nostra parte fantasma, può essere ancora fonte di un dolore profondo, indegno. A volte certi rimedi possono alleviare i sintomi, ma la cura definitiva non esiste” (“le cicatrici psichiche – ci ricordava Recalcati –, sebbene restino invisibili, sono perennemente vive” e nessuna elaborazione del lutto può eliminare un “resto” di dolore).
Come in ogni romanzo che si rispetti, un evento giunge a segnare una svolta, e si tratta di un sogno: Anna gli telefona, gli dice che “loro due e tutti gli altri materialisti sbagliavano a credere che non esiste un aldilà”, ma si sbagliano anche quelli che ci credono, perché l’aldilà è solo un “Grande Nulla”, dove “non si entra in contatto con nessun altro defunto” e si vive “in un paradossale stato di coscienza della non-esistenza”, ma in compenso “tra i vivi e i morti c’è un legame (…) il vivo può mantenere il morto in una specie di limbo provvisorio fra la vita e la non-vita, ma quando muore anche il vivo, allora è la fine”. È lui, insomma, lui che la pensa ancora, a tenerla in questa condizione. Baumgartner ha vissuto il suo sogno “come un’esperienza reale”, “è stato trasformato dalla storia che si è raccontato nel sogno”: “chi può dire che non ci sia un po’ di verità? Non una verità scientifica (…), ma una verità emotiva, che è alla fine l’unica cosa che conta”. Anche per lui, studioso e docente “che ha passato la vita nel regno del concreto” ed ha ora scoperto “quella che può essere presa per religione da un uomo che non è religioso e non crede in niente all’infuori del dovere di fare buone domande sul significato di essere vivi, pur sapendo che non sarà mai in grado di trovare delle risposte”. Adesso sì, Baumgartner può davvero cambiare, sentendosi “sempre più sicuro di sé mentre continua ad attraversare il vasto prato interiore che gli si stende davanti. (…) ha acquistato simultaneamente una nuova lucidità mentale e una rinnovata fiducia nell’avvenire (…). In fondo ha settant’anni e non è più tempo di incertezze”. Va in pensione, “senza andare in esilio perpetuo”, continuerà a partecipare alla vita culturale, ha già il progetto di un nuovo libro, c’è una donna nella sua vita e ora si sente libero di amarla, non ha tempo da perdere, non sa quanto gliene resta.

Le cose non andranno come il protagonista sperava, eppure il romanzo va oltre la sua vicenda dolorosa grazie ad ampie digressioni storiche sulla sua famiglia (e le peripezie che dall’Europa orientale l’hanno portata in America) ma soprattutto alle continue notazioni tratte da una quotidianità sempre letta con autoironia: quello che era sembrato – e di fatto è – un romanzo sui nodi essenziali dell’esistenza è anche una narrazione leggera, brillante, colma di humour e di una finezza di analisi dei sentimenti che tanto più sorprendono essendo l’opera di un uomo di settantasette anni, da alcuni mesi gravemente malato, che ha dichiarato di non poter escludere che questo sia il suo ultimo romanzo, una sorta di “lascito testamentario”.
Questo testo compare anche nel sito della nuova libreria Rinascita di Brescia, alle cui attività culturali Carlo Simoni collabora.
