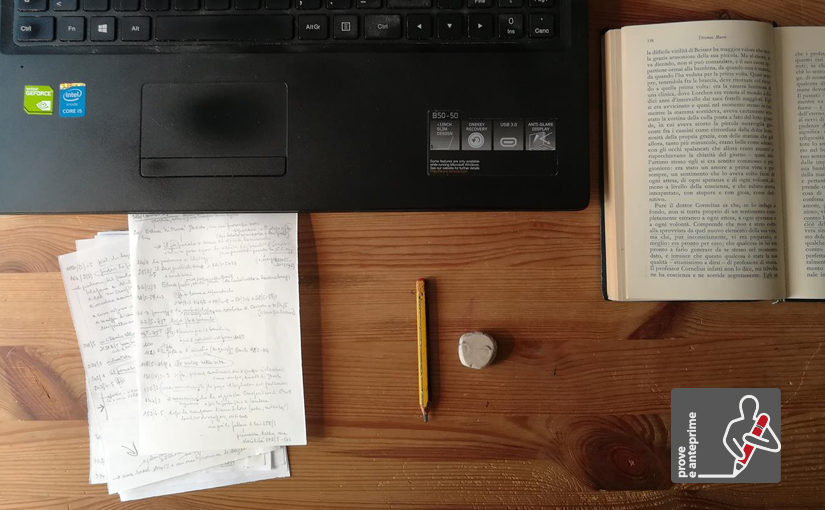* Questo racconto è comparso, insieme a quelli di Enrico Mirani, Massimo Tedeschi e Marcello Zane, in Di passioni e di guerre. Fonti storiche e racconti d’autore (Brescia, liberedizioni, 2017).
Era festa a Brescia. San Faustino, patrono della città. Ma non era per la fiera che c’ero tornato, anche se da bresciano qual ero mi ricordavo lo zucchero filato che da bambino mio padre mi comprava alle bancarelle della sagra. Al giornale avevo proposto di dire qualcosa su quel 15 febbraio del ’19: era il giorno in cui la stampa socialista riacquistava cittadinanza in una città ancora considerata in zona di guerra, anche se il confine era ormai lontano ed erano passati più di tre mesi dall’armistizio. L’Avanti, il giornale per cui da quasi vent’anni lavoravo, non circolava ancora, a Brescia. Lo si trovava a Mantova, a Verona, ma qui no. E quel giorno tornava a uscire invece, dopo la sospensione di quattro anni imposta con la guerra, la Brescia Nuova, il foglio dei socialisti bresciani.
La festa era doppia perciò, lì al Circolo Ferrovieri, a due passi dalla Tempini e dalla Togni, di fronte alle case di Campo Fiera. Voci, canti, fumo e aroma di caldarroste mi avvolsero quando entrai. Le biline e il mandolato erano arrivati fin lì, e anche le trombette che vendevano alla fiera. Tutti alzavano la voce per farsi capire, e il vino faceva il resto. Vino e altro. Un tale mi mise in mano un bicchiere di vermut. Vermut americano, disse: bevilo, io lavoro alla Ferrol e lo so. Disinfetta l’intestino meglio di tutti gli intrugli dei dottori: la spagnola non la prendi con questo. Garantito.
Guardandomi attorno mi colpì un ometto accalorato nella discussione. Era seduto a un tavolo con degli altri. Smilzo, e tanto piccolo da non toccare il pavimento coi piedi. Un corpo da ragazzo, anche se il volto dimostrava una trentina d’anni. Il bicchiere di vino che aveva davanti non l’aveva ancora toccato, preso com’era a spiegare, a persuadere il suo uditorio. Mi avvicinai. Stava dicendo che il Senato andava abolito, il suffragio universale doveva essere esteso alle donne, e la politica estera sottratta al potere del governo e affidata al parlamento: era chiaro, stava illustrando la nostra piattaforma d’azione. Il Partito l’aveva approvata da poco dando la direttiva di discuterne in tutte le sezioni. E questo compagno non perdeva l’occasione: parlava e indicava col dito la prima pagina del giornale che teneva sul tavolo. Accanto alla sedia ne aveva una pila, da distribuire lì al Circolo. Da come parlava compresi che era dei metallurgici: non si poteva accettare che, con la disoccupazione che il passaggio dall’industria di guerra all’industria di pace stava già provocando, gli industriali se ne fregassero delle liste dell’ufficio di collocamento che pure avevano riconosciuto. Ma andava più in là: le 48 ore settimanali non erano una richiesta solo dei metallurgici, era un diritto anche dei ferrovieri. Occorre andare di pari passo, noi e voi, diceva convinto agli altri tre; noi della Camera del Lavoro la otterremo questa riduzione di orario, così come un aumento di paga uguale per tutti! Nella Commissione interna, qui alla Tempini, abbiamo già presentato un memoriale e queste cose sono al punto numero uno!
Sì, era l’uomo che cercavo: operaio metallurgico, le mani lo dicevano, ma anche militante sindacale. Una chiacchierata con lui e l’articolo per il giornale era fatto. E poi, mi sembrava di averlo già visto quel compagno: la sua fisionomia, il suo modo di guardare dritto negli occhi la persona con cui stava parlando… Quando due dei ferrovieri si alzarono mi sedetti al tavolo. Lui mi porse una copia della Brescia Nuova e mi chiese da dove venivo. Fu in quel momento, quando si rivolse a me, che lo riconobbi: noi ci siamo già incontrati, gli dissi.
Oh, possibile: in fabbrica, al sindacato ne incontro tanti…
No, io ti ho incontrato… 19 anni fa.
Ma figurati. 19 anni fa era il 1900! Ero un bambino…
Proprio così, un bambino.
Ma tu chi sei?
Lavoro all’Avanti, a Milano. Giusto da 19 anni.
Ah, bene: allora possiamo…
Ma sono di Brescia, e prima ho lavorato alla Brescia Nuova: pochi mesi, stavo imparando il mestiere, avevo vent’anni allora, quando c’è stato l’ammutinamento, come lo chiamarono i giornali borghesi.
Mi guardò diffidente: di cosa parli?
Di quello che è successo appena dopo Natale all’Istituto Derelitti.
Si è alzato, e poi si è riseduto. Ha finalmente bevuto un po’ del suo vino.
E che cosa vuoi da me? Non sarai venuto a Brescia per riesumare storie del genere…
No, è per scrivere qualcosa sulla ripresa del vostro giornale…
Be’, allora parliamo di quello. Lo vedi qui? Resurrezione, è il primo articolo e…
Anche la Brescia Nuova, allora, dedicò un articolo a quei fatti, lo interruppi.
Già, bell’articolo…
Non lo scrissi io, ma il mio capo, il giornalista cui mi avevano affidato per imparare il mestiere.
Ah, bel maestro, non c’è che dire!
Sono d’accordo con te, io avevo scritto altro sul processo, me l’aveva fatto fare lui, ma quando l’ha letto mi ha detto che era impubblicabile e l’ha rifatto.
Perché? tu cos’avevi scritto?
Che la questione non era stata solo la cattiva qualità del vitto, prima di tutto.
Ha cambiato espressione. Era interessato adesso.
E’ vero. Non era quella, non solo quella perlomeno, la questione… Ma tu, lo sai com’erano andate le cose?
Sono stato all’Istituto quando ormai tutto era finito, ma poi ho assistito al processo.
Ah, dunque sai com’è andata davvero, in tribunale! Conta…
Prima vorrei che mi raccontassi tu quel che era successo, dall’inizio…
Be’, si fa presto, ma qui… Andiamo fuori, camminiamo un po’.
Passammo Porta San Giovanni e prendemmo per via Gioco del Pallone. Mi accorsi che dovevo andar piano: ogni passo dei miei, che pure non sono un gigante, era due dei suoi. Girò per il centro: si incontravano ancora famiglie e gruppi che tornavano dalla fiera, ma erano gli ultimi. Il campanile delle Grazie stava suonando le sette.
Non so se lo fece di proposito, ma ci ritrovammo in via Santa Chiara. Il Pio Istituto Derelitti era là all’epoca dei fatti. Solo qualche anno dopo si sarebbe spostato fuori Porta Pile, in un edificio tutto suo, dov’è ancora. Ma allora no, era al numero 50 di via Santa Chiara, il portone davanti al quale ci eravamo fermati. Era lì che erano successi quei fatti.
Ci sei stato, dicevi: che cosa ricordi?
Erano le sei di sera, era già scuro: nel cortile c’erano carabinieri e questurini. Ci hanno fermato che eravamo ancora sul portone, sembrava stesse per succedere qualcosa. E infatti poco dopo abbiamo visto fra due ali di questurini avanzare otto ragazzi, in fila. Ci sono passati davanti. Li hanno portati via. Allora siamo entrati e il mio capo si è messo a parlare col direttore, lo conosceva…
Lo conosceva? mi interruppe sorpreso Giacomo, prendendo un altro sorso di vino.
Mi parve proprio di sì, si salutarono come due che si conoscono da tempo.
Ma non è possibile: quello era un servo dei preti, un leccapiedi dei padroni, una spia, che non faceva altro che darsi da fare per la sua carriera, culo e camicia col sindaco e colla sua manica di clericali, che riceveva in casa sua, sera sì sera no. Perché lui aveva un appartamento qui dentro, in questo stesso palazzo in cui c’era l’Istituto, e Franchino ci raccontava tutto quello che succedeva dal direttore, in ufficio e anche in casa…
Franchino?
Sì, uno di noi, era dei mezzani lui, aveva dodici anni: l’aveva preso in casa la moglie del direttore come tuttofare. Perché non veniva dalla strada, Franchino. Era capitato lì solo perché suo padre era morto, e la madre si era risposata con uno che si era portato dietro una figlia e di ragazzi per casa non ne voleva, e in quattro e quattr’otto aveva trovato il modo di far passare Franchino per l’attentatore alla virtù di sua figlia, e anche peggio, tanto da convincere, o costringere, la moglie a denunciare il figlio e a farlo finire ai Derelitti, anche se era un ragazzo ammodo. E dunque: Franchino ci teneva al corrente di tutto quel che sentiva dal direttore. Anche in quei giorni… Ma questo viene dopo. Ti ho interrotto: stavi dicendo che il tuo capo ha saputo qualcosa da quel bel personaggio…
Sì, ha saputo che quegli otto li portavano in carcere e sarebbero stati processati già l’indomani. Ed è stato lì che ti ho visto. Prima non ti avevo notato. Eri in fondo al cortile insieme ad altri ragazzi. Eri il più piccolo… Sembravi sul punto di piangere, ma si vedeva che stringevi i denti. Avevi un’espressione di rabbia che colpiva in quella faccina da bambino: ci siamo guardati per un attimo, poi qualcuno ha suonato un fischietto e siete andati via.
Già, in refettorio: ci fecero fare cena in anticipo, quel giorno…
Ma prima cos’era successo? cos’avevi visto? come si era arrivati a quel punto?
E’ sembrato tornare a quella sera, a quei giorni. Ci siamo rimessi a camminare. Ha aperto bocca solo quando siamo arrivati in piazza della Loggia: occorre partire da un po’ prima, ha detto. E siamo andati giù per i portici. Lui che raccontava, a voce bassa, guardando dritto davanti a sé.
Continua la lettura nel pdf: