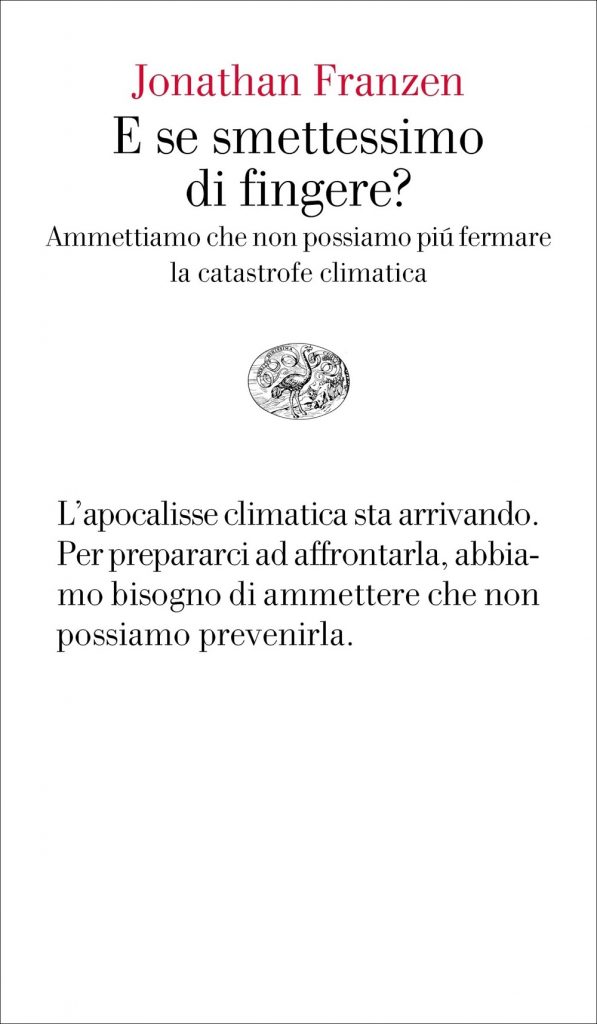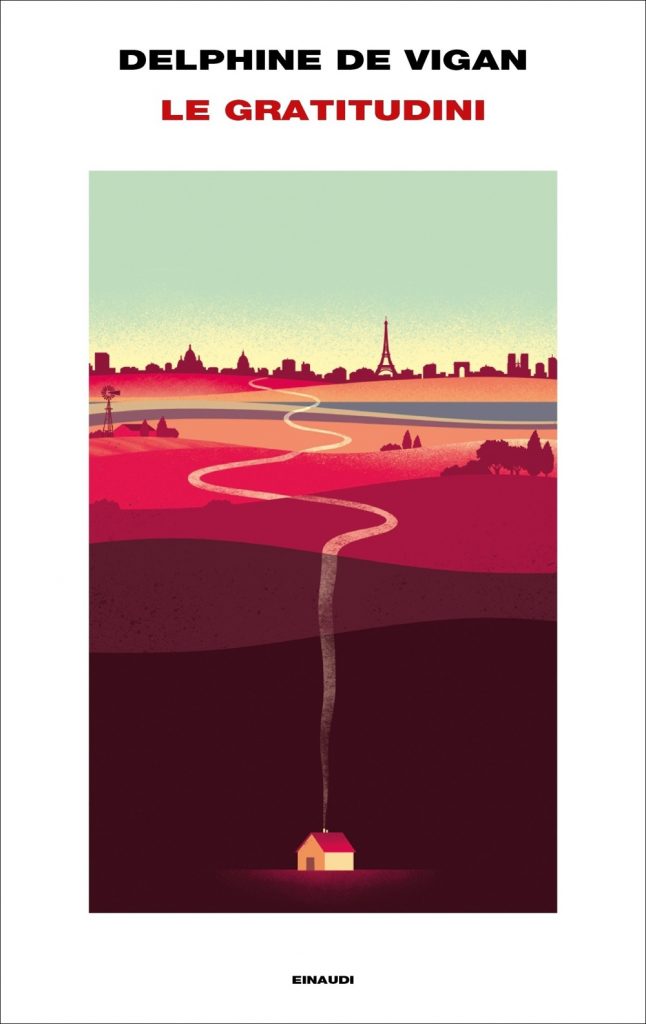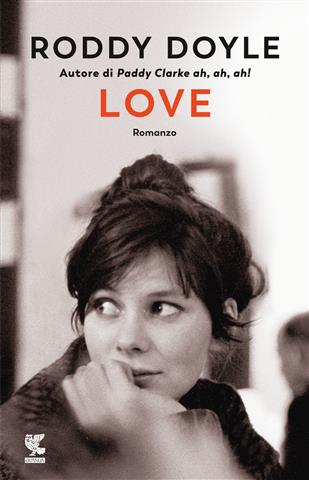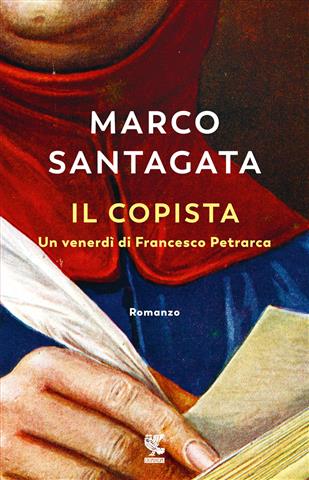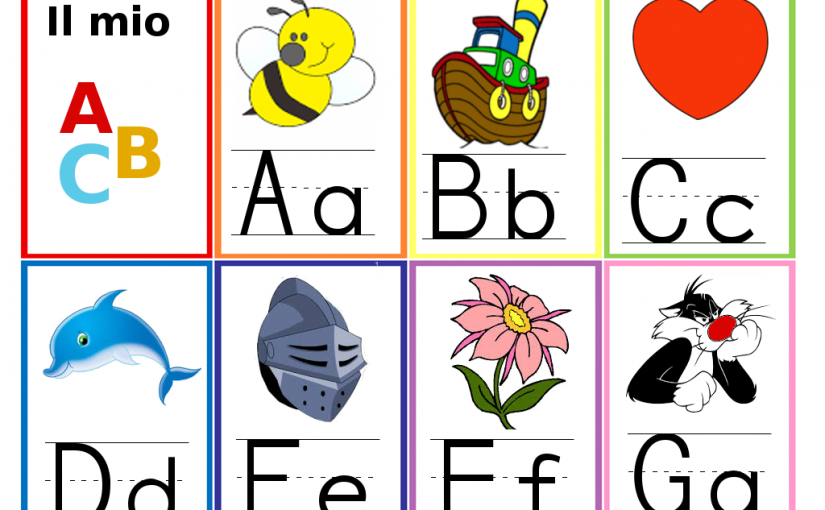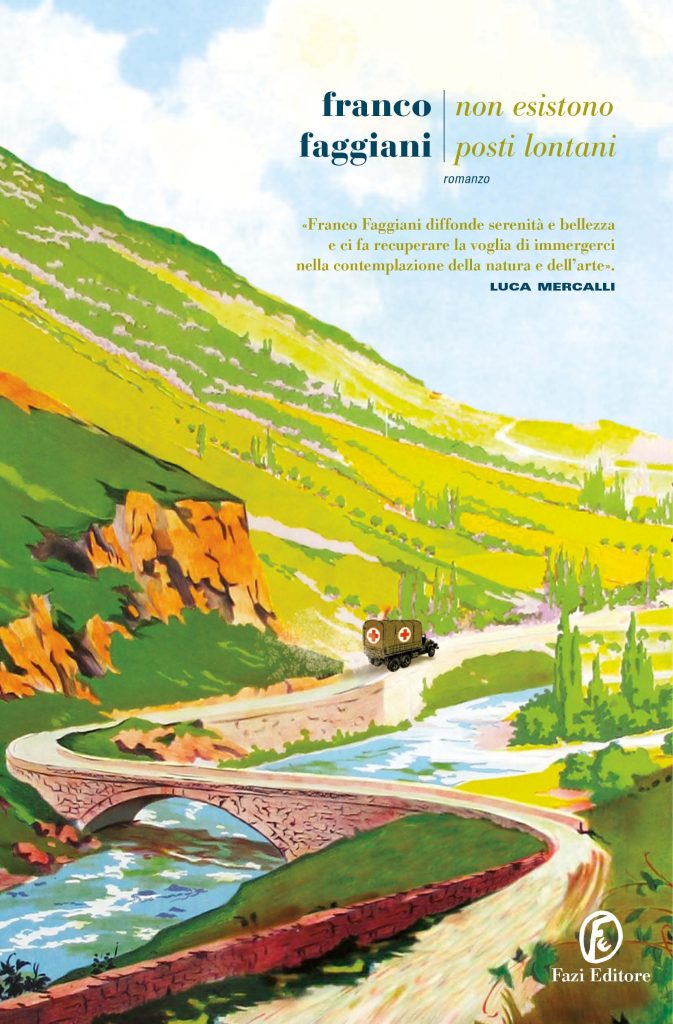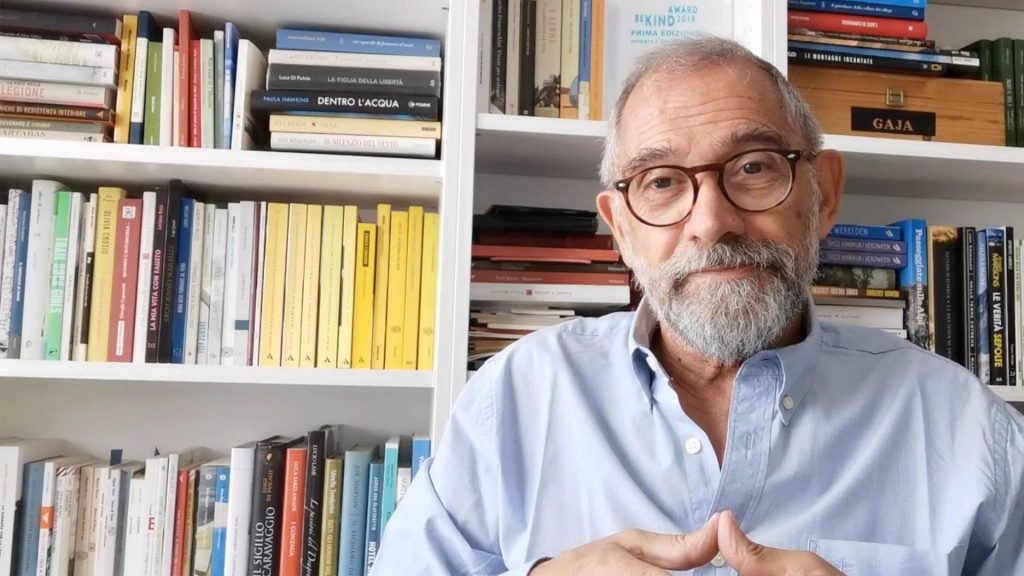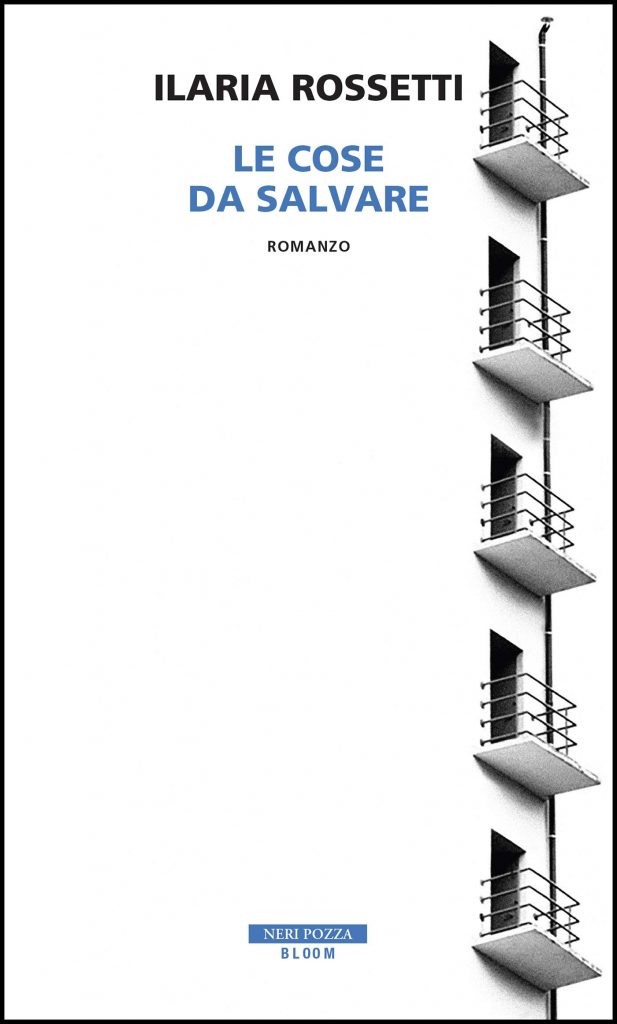
Ilaria Rossetti, Le cose da salvare, Guanda 2020 (pp. 201, euro 17)
Due storie: quella di un ex professore di scuola media, da anni solo, abitante di un condominio risparmiato per un soffio dal crollo del ponte di Genova, e quella di un altro pensionato, non toccato direttamente dalla tragedia del ponte ma da un’altra, privata: la morte della moglie. A tenerle insieme una trentenne, da poco assunta da un giornale locale. Primo incarico: intervistare il professore che ostinatamente ha rifiutato di lasciare il suo appartamento. Perché? Vengono alla mente quel vecchio che non voleva lasciare la sua casa a Curon, alla vigilia della costruzione del bacino idroelettrico (quello del campanile che spunta dall’acqua: ce ne ha raccontato Marco Balzano un paio d’anni fa (Resto qui, Einaudi 2018, in queste note il 15 aprile 2018), ma qualcosa di molto simile pare sia avvenuto anche dalle nostre parti, quando venne realizzato l’invaso della Valvestino all’inizio degli anni Sessanta. Delle ragioni di Gabriele Maestrale però sappiamo di più, grazie a Petra, la giornalista, che poco a poco ne ottiene la fiducia e comincia a prender nota di ciò che l’uomo ha vissuto, sin dal momento del crollo del ponte, perché è allora che ha deciso, quando ha sentito il suo appartamento “scricchiolare” fra i “blocchi di cemento armato precipitati tutt’intorno”: “Gabriele capisce che forse crollerà” anche la sua casa, che “se ne deve andare il prima possibile”. “Ma – ecco il punto – quali sono le cose da salvare?”, da portarsi via nella fuga? Ebbene, lui “Non riesce a decidere quali sono le cose da salvare”, e dunque resta, bloccato dalla constatazione di “quanta vita c’è nelle nostre stanze”. Ossia del fatto che le cose non sono solo cose: le abbiamo incorporate nella nostra vita senza accorgerci, se non alla fine, o in casi estremi come questo, che loro hanno incorporato noi e chi ci stava vicino (è lo stesso tema che abbiamo incontrato nel libro di Massimo Mantellini recentemente letto (Dieci splendidi oggetti morti, Einaudi 2020, in queste note lo scorso 18 ottobre).

E intanto, Petra si divide fra la storia dell’“Eremita del ponte” – come il giornale, con la solita stereotipata ricerca di sensazionalismo, lo definirà – e quella intima, lontana dalla cronaca, di suo padre, raggiunto dalla donna che era stata il suo primo amore a una settimana soltanto dalla morte della moglie. Le due storie crescono, si arricchiscono di significati che via via superano le circostanze in cui sono nate, e si complicano: nel palazzo pericolante non vive solo il professore, ma anche due clandestine eritree, madre e figlia, e l’arrivo di Vanda, l’antica fiamma del vedovo, non è stato dettato solo dal rimpianto, ma da una precisa volontà… Una trama avvincente, dunque, percorsa da quell’intercalare – le cose da salvare – che conosce sempre nuove modulazioni, fino a farsi metafora della scelta inevitabile che la finitudine della vita impone. Sono il passare del tempo e il riconoscimento, struggente e insieme sereno, a suo modo, della limitatezza dell’esistenza, a rappresentare il fulcro della narrazione. Lo avevamo potuto presentire, del resto, fin dagli esergo posti in apertura, dal primo soprattutto, di Cristina Campo: “Ho tante cose da dire! Quasi direi da salvare: tutta la tragica bellezza di ciò che è passato in noi e vicino a noi – cose che io sola sento di aver visto e sentito fino alla sofferenza e che assolutamente non devono morire”.
Questo testo compare anche nel sito della nuova libreria Rinascita di Brescia, alle cui attività culturali Carlo Simoni collabora.