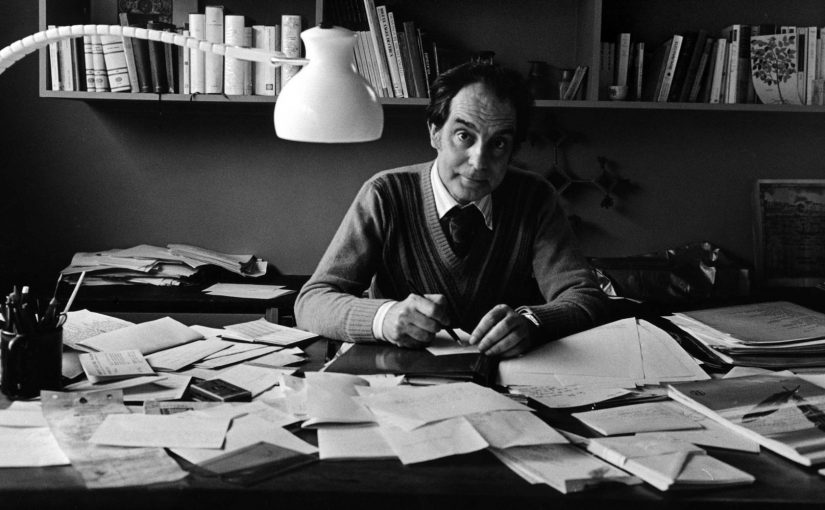“L’equivoco per cui uno scrittore sia necessariamente anche un intellettuale è figlio dell’altro-ieri della storia letteraria (dell’engagement, dell’impegno di stampo secondo novecentesco etc.). Ciò non toglie che uno scrittore possa essere anche un intellettuale, ma i due campi, pur confinanti, non si sovrappongono. Quando un artista interpreta il mondo lo fa senza ridurlo a categorie ideologiche – quelle cui, giocoforza, ricorre un intellettuale impegnato – ma abolendo il concetto stesso di categorie e di ideologie. La sua prospettiva rispetto, a esempio, un conflitto bellico di scala internazionale, non è quella verticale della geopolitica, ma quella radente, orizzontale, del viandante, dell’uomo che cammina. (…) E l’opera ci mostra, per questo, della realtà, una verità ben più duratura di qualsiasi analisi obbiettiva”. (Stefano Gallerani)
Carlo Simoni
Giancarlo Consonni, ‘Il desiderio di infinito’
Commento a Carlo Simoni, Quei monti azzurri
(Milano, 28 gennaio 2020)

Tra i documenti conservati a Recanati sono presenti dei quaderni di Paolina Leopardi che, per volontà degli eredi, non sono accessibili al pubblico. È forse da lì, dal desiderio di forzare quel segreto, che a Carlo Simoni è venuta l’idea di inventare un diario tenuto dalla sorella del grande poeta. Il risultato è un romanzo storico in forma diaristica: consistente in quanto in quel quaderno si immagina si sia venuto depositando nel periodo che va dal luglio 1817 al novembre 1819. Scandito mensilmente, il romanzo presenta quattro interruzioni corrispondenti all’ottobre 1817, al febbraio e al maggio 1818 e all’ottobre 1819, in cui si ipotizza che Paolina non metta mano al diario. Il libro si compone così di 24 capitoli, corrispondenti ad altrettanti mesi.
L’arco temporale non è scelto a caso: va dall’avvio dello Zibaldone per concludersi poco dopo la composizione de L’infinito. Si tratta di un passaggio cruciale anche per la vita di Paolina: corrisponde grosso modo al periodo che, per lei, va dai 17 ai 19 anni, quando, sul «limitare/ di gioventù», si manifesta «il primissimo fiore della vita».
Simoni attiva fin da subito un doppio sguardo: quello di Paolina e quello su Paolina. Nel fissare sulla pagina ogni evento, piccolo o rilevante, che interessa la vita dell’amatissimo fratello, l’autrice immaginaria del diario si trasforma nella figura alata di un osservatore/messaggero. Per suo tramite il lettore è immerso nello spazio domestico di casa Leopardi e nei suoi ancoraggi esterni (il borgo, la campagna, i luoghi delle passeggiate consentite ai soli figli maschi); ma soprattutto è “gettato” (per usare la nota espressione di Maurice Merleau-Ponty) nelle relazioni interne al nucleo familiare, regolate dall’ambizione, mista a frustrazione, del padre Monaldo e dalle chiusure bigotte e maniacali della madre Adelaide Antici. La ferma certezza di Adelaide che l’isolamento nell’universo domestico sia, tanto più per la figlia, la via salvifica dalle tentazioni mondane si salda alla convinzione di Monaldo che tutto ciò che può nutrire lo spirito possa essere ritrovato nella grande biblioteca da lui messa insieme con tenacia e passione. Orientamenti ossificati che si traducono in una chiusura possessiva nei confronti della prole (sette figli, di cui due morti in tenera età).
Il diario registra un succedersi serrato di eventi spesso minimi e apparentemente insignificanti, ma anche passaggi cruciali nella vita di Giacomo: lo stabilirsi di rapporti epistolari con Pietro Giordani, la morte di Teresa Fattorini (stroncata a vent’anni, nel settembre del 1918, dalla tubercolosi: a lei dieci anni dopo il poeta dedicherà il Canto A Silvia), l’esplodere della passione amorosa per Geltrude Cassi e, soprattutto, il suo incontro con la poesia, non solo da studioso ma da poeta.
Da subito si delineano alcuni fili conduttori che, intrecciandosi, imprimono alle memorie apocrife la vis narrativa di un romanzo. Il motivo preminente è la condizione d’isolamento in cui sono costretti Giacomo, Carlo e Paolina (i tre fratelli maggiori di casa Leopardi, nati a poco più di un anno di distanza l’uno dall’altro): una condizione che, ben presto, è da loro vissuta come una clausura. Il diario/romanzo dà conto, in un crescendo, della sofferenza che prende corpo e che culmina nel tentativo di fuga di Giacomo, miseramente fallito.
Con tocco leggero e sapiente, Simoni non manca di inserire qua e là elementi che preannunciano il dramma. Così, a evocare la prigionia, nelle prime pagine del diario sono richiamati i piccoli volatili – un canarino, un fringuello, un passero solitario –, regalati, uno dopo l’altro, ai figli del padrone dal cocchiere di casa Leopardi, Giuseppe Fattorini, padre di Teresa, alias Silvia. Anche il confronto che Paolina istituisce fra la sua condizione e quella di Teresa evoca la comparazione tra l’essere in gabbia e il poter volare in libertà.
Alla tenaglia possessiva dei genitori si oppone, come può, la resistenza che, ciascuno a suo modo, oppongono i tre fratelli. Il trio è rinsaldato da un grande affetto e da un’intesa che si spinge fino alla complicità; ma, a complicare i rapporti, interviene ben presto la disuguale caratura intellettuale: l’emergere della personalità di Giacomo introduce disparità che, anche senza volerlo, portano a ridurre il fratello e la sorella a ruoli “di spalla”: di confidenti, di allievi, di copisti e, sempre, di ammiratori. Da cui l’insorgere inevitabile di inclusioni ed esclusioni.
La più colpita dalle esclusioni è, manco a dirlo, la sorella, verso la quale i fratelli, a cominciare dal maggiore, tendono a replicare l’atteggiamento protettivo dei genitori. Ma Simoni sa complicare il quadro facendo intravedere un rapporto carsico fra Paolina e Giacomo: un legame basato sul mutuo cercarsi e riconoscersi simili: nel profondo dell’animo e nella sofferenza che vi si va accumulando. L’autore porta in superficie il legame in un paio di episodi: il soccorso amorevole di Paolina al fratello intirizzito da un acquazzone e l’abbraccio tra i due con cui si conclude il romanzo. Ma Simoni fa in modo che tutto il diario apocrifo sia percorso incessantemente da sguardi, cenni, mezze parole, accensioni, silenzi, scoperte, incomprensioni, precipitazioni, incantamenti, piccole e grandi disperazioni: tumulti e tremori, fatti di tutto e di niente, dove apparenze e sommovimenti profondi si saldano in una tensione restituita con grande finezza.
Carlo Simoni ha fatto rivivere nei suoi romanzi personalità come Gustav Klimt, Thomas Mann e Walter Benjamin, misurandosi con sfide da far tremare i polsi. Ma qui, nel dare vita a Paolina Leopardi, è alla sua prova più ardua. E il risultato è ancor più convincente. La sua Pilla è del tutto credibile: il ritratto a tutto tondo di un’adolescente alle soglie della giovinezza a cui è riservato un doppio destino crudele: quello di reclusa (costantemente in bilico tra il finire in un convento e l’andare in sposa a un marito che spetta ad altri scegliere) e quello di una persona a cui la sorte ha negato la bellezza fisica. Un dramma, quest’ultimo, esaltato, per contrasto, dall’essere la bellezza un riferimento cardinale per i tre fratelli, forse la più intima trama che li lega; quando invece, scrive la Paolina di Simoni, «i più» «solo vedono […] e considerano, e son capaci d’amare» «l’esteriore sembiante», «ché l’anima per bella che possa essere, non si dà a vedere…» (p. 55).
Nel 1821 (ovvero due anni dopo la chiusura del diario immaginario), nella canzone Nelle nozze della sorella Paolina – il matrimonio con Pier Andrea Peroli di Sant’Angelo in Vado, com’è noto, non andato in porto –, il poeta oserà parlare di «beltade onnipossente». Se nella formula c’è un nucleo di verità – da Giacomo direttamente sperimentato nell’invaghimento per Geltrude –, è altrettanto vero che non meno «onnipossente» può essere l’assenza di bellezza fisica, per gli effetti devastanti che può avere soprattutto per chi è «nel fior degli anni». Nella confessione/riflessione che Paolina fa sulla propria condizione – dalla ‘scoperta’ del proprio corpo fino all’autoritratto impietoso, ulteriormente ribadito dalla consapevolezza che quel corpo non ha «conosciuto le mutazioni leggiadre che fan d’una fanciulla una donna» (p. 81) – il diario apocrifo raggiunge alcuni dei suoi momenti vertiginosi.
Con l’invenzione del diario, Simoni mette in campo un efficacissimo espediente narrativo: il lettore può avvicinare gli accadimenti che interessano Giacomo per quanto è consentito a Paolina. E questo, mentre rende ancor più credibile la fictio, consente all’autore di condividere con il lettore una consapevolezza implicita: il centro attorno a cui gravita la narrazione – lo svolgersi, in quei 28 mesi, della vita di Giacomo Leopardi e di ciò che matura nel suo intimo – è intuito, fatto oggetto di assidue congetture e, qua e là, persino intravisto, come si trattasse di apparizioni: di materia incandescente che però resta per lo più inaccessibile. Viene così in chiaro, tra le valenze del romanzo, anche quella filosofica. Un modo ulteriore di porsi in simbiosi con il protagonista.
Se avesse fatto ricorso alla descrizione diretta dei personaggi e degli eventi, difficilmente l’autore avrebbe conseguito un risultato altrettanto efficace. Grazie invece alla modalità adottata – una forma mediata di scrittura, che si spinge fino a un raffinato esercizio di stile che allude all’italiano cólto d’inizio Ottocento – ha potuto implicare il mistero e gestire con sapienza narrativa i disvelamenti.
A sospingere il farsi del romanzo sono, in tutta evidenza, la curiosità, il desiderio e la dedizione, nutriti da un’ammirazione sconfinati. Che sono di Paolina Leopardi – e, in filigrana, di Carlo Simoni – ma che finiscono per confondersi con quelli dei lettori che amano l’opera di Leopardi. Mentre l’acribia dello storico – è da lì che Simoni proviene – assicura solidi ancoraggi alla narrazione, ogni inezia che si deposita sulla pagina alimenta lo sviluppo di una sinfonia fatta insieme di minime vibrazioni e di un movimento largo e avvolgente, dove il tema principale lascia, qui e là, spazio a temi secondari non meno avvincenti. Finendo per identificarsi, almeno in parte, con Paolina, il lettore viene così immerso nella materia incandescente della vita.
Allo stesso tempo, poiché Giacomo, almeno secondo Simoni, non consente alla sorella (implicata per lo più come copista) di leggere tutto ciò che la sua penna fissa sulla carta, e ancor meno di condividere fino in fondo tormenti e passioni, si viene a creare una situazione che rasenta il paradosso per cui il lettore può “vedere” connessioni tra gli accadimenti e gli scritti (in varia forma) di Giacomo Leopardi che a Paolina non sono accessibili ma che pure sono innescate/suggerite dalle “sue” stesse parole. Grazie a questo, e ad altri accorgimenti, in chi legge all’immedesimazione si affianca la distanza. In tal modo l’io narrante assume ancor più lo spessore di personaggio: l’“autrice del diario” è la deuteragonista, non inferiore, quanto a valenza umana e a sottigliezza di sguardo, del protagonista, il grande, immenso Giacomo Leopardi.
Si forma così un trio – Paolina, Carlo Simoni e il singolo lettore – che dà al testo una forte connotazione teatrale.
Il passaggio sulle scene del diario/monologo comporterebbe un ovvio intervento di adattamento, ma è, mi sembra, già chiaramente delineato. Il culmine del romanzo è la scoperta furtiva di Pilla del manoscritto de L’infinito. A ben vedere il diario apocrifo non è che una lunga premessa a questo evento. Se il commento “in diretta” di Paolina Leopardi tocca punti altissimi, l’intero libro sembra pensato per favorire l’avvicinamento del significato di questa lirica, dove l’ansia di libertà, e la sofferenza che l’accompagna, si sublimano nell’incanto e nel desiderio di un abbraccio cosmico.
“Bisogna guardare con perplessità o sconforto alle illusioni degli scriventi…”
“Bisogna guardare con perplessità o sconforto alle illusioni degli scriventi [altra cosa dagli scrittori, secondo la distinzione introdotta dalla Morante] e dei leggenti (spesso molto simili e vicini tra loro, a volte e sempre più spesso la stessa persona) (…) bisogna guardare alla scrittura e alla lettura come a ‘droghe’ non poi così secondarie, grazie alle quali si può diventare certamente più intelligenti ma anche, e pericolosamente, più acquiescenti all’andamento del mondo così come lo guidano i potenti, diventandone passivamente complici (…) Se il verbo non si fa carne, cioè presenza e intervento nella storia per renderla migliore, per riscattarne la tragedia, è grande il rischio che rimanga inerte chiacchiera, ciarla, evasione. E, a ben guardare, colpa”. (Goffredo Fofi)
La famiglia dell’architetto e altri animali

Lia Piano, Planimetria di una famiglia felice, Bompiani 2019 (euro 15, pp. 158)
Oltre al cognome, quel planimetria nel titolo mette sull’avviso: non si tratta di un’omonimia. L’Autrice è figlia di Renzo Piano, e fra i meriti del romanzo c’è anche quello di darci un suggestivo ritratto dell’architetto da giovane. Quanto al titolo, è ovviamente Tolstoj a venire in mente, e il famoso incipit di Anna Karenina: contraddetto, si direbbe, in questo caso. Anche le famiglie felici sono felici a loro modo, questa di sicuro. Anche se ad un’altra famiglia è inevitabile pensare: quella di Gerald Durrell. Anche nella famiglia Piano si muove infatti una donna tuttofare di estrazione popolana e saggezza nativa; l’ultimogenito è il narratore e deve fare i conti con i fratelli maggiori (“Essere la più piccola di una famiglia numerosa significa arrivare quando l’esperienza ha già operato la sua lenta erosione sulle certezze. Quando due più due non fa più quattro”); gli animali occupano un posto di tutto rispetto, che siano cani (quatto) o galline (cinquanta), come quelle per cui il geniale architetto, per altro quotidianamente assorbito dalla costruzione di una barca, concepisce l’idea di un pollaio la cui progettazione sarà partecipata, aperta al contributo di ciascuno dei familiari, nessuno escluso. Nel frattempo, la planimetria di questa casa – sulle cui porte, coerentemente con la comune ispirazione libertaria, campeggia la scritta “Vietato vietare” – evolve in conseguenza del delinearsi delle attitudini e degli hobby fra loro diversi che gli abitanti via via coltivano. Tanto intensamente da non aver tempo da perdere con quel che accade fuori dalla casa: “Maria – la bambinaia cuoca cameriera – fu incaricata di tenere i rapporti tra noi e il mondo, e farci un riassunto di cosa capitava là fuori”. Un romanzo divertente, scritto con spirito, con un finale esplosivo… di cui non è il caso di dire qui.

Questo testo compare anche nel sito della nuova libreria Rinascita di Brescia, alle cui attività culturali Carlo Simoni collabora.
“La scrittura, per come la vedo io, non è un esercizio di ego…”
“La scrittura, per come la vedo io, non è un esercizio di ego. È più simile alla costruzione di un mandala. Annullare se stessi e il mondo costruendone uno più nitido ma fittizio, il cui scopo è essere spazzato via da un colpo di mano. Lo stesso vale per la lettura. Il lettore troppo legato al suo io non riuscirà mai a godere appieno di un libro”. (Luca D’Andrea)
Una battaglia persa che vale la pena di continuare
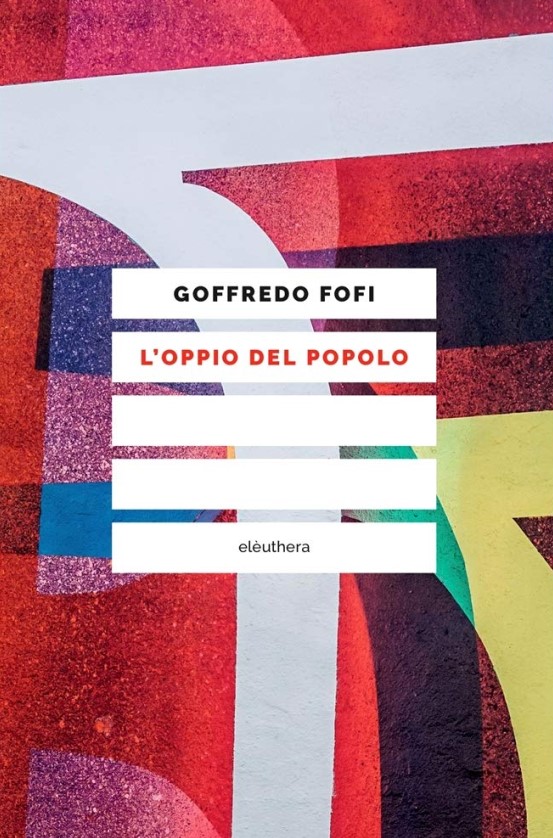
Goffredo Fofi, L’ oppio del popolo, Elèuthera 2019 (pp. 166, euro 16)
“Per uno come me – conclude l’autopresentazione che è anche un rapida autobiografia intellettuale ad apertura del libro – e magari più intelligente e meno sconcertato di me, la cultura appare oggi come un campo di battaglia ancora possibile, ma fuori da ogni illusione di vittoria e partendo dalla constatazione, per cominciare, di quanto sia stato facile per il potere servirsi della cultura (…) cambiando di segno alla sua storia e illudendo milioni di persone che di cultura vivono di una sua forza ancora liberatoria, non evasiva e perfino necessaria. Facendone facilmente dei complici della manipolazione, del dominio”. È la sintesi del discorso, con un’appendice decisiva, su quel che occorre fare ma non tutti possono: “È un lavoro, ancora una volta, di cui devono farsi carico minoranze salde nelle loro persuasioni, convinte della necessità e dell’urgenza dell’azione, nauseate dalle compromissioni universitarie e affini, dalla lotofaga insipienza dei predicanti e idealizzanti, degli accettanti”.
Se il pensiero, a quel richiamo a minoranze convinte e rigorose, va a un altro recente pamphlet, quello di Gustavo Zagrebelsky (Mai più senza maestri, Il Mulino 2019), la critica spietata che passa in rassegna i diversi settori e aspetti della cultura sembra evocare i toni perentori, non di rado sarcastici, del romanzo di Francesco Pecoraro (Lo stradone, Ponte alle Grazie 2019).
Il bilancio pesantemente dello stato delle cose è infatti anche qui decisamente negativo: “Scrivo queste pagine con apprensione, convinto della loro inutilità, per dovere di testimonianza e nella speranza di convincere qualche giovane lettore della gravità della situazione che stiamo attraversando e della ignobiltà delle proposte che gli adulti vanno facendo, chiedendogli di diffidare anche dei miei discorsi”.
Il discorso che da questi presupposti si sviluppa dimostra come l’identificazione di un nuovo oppio del popolo nella cultura – intesa in tutte le forme assunte, a partire dagli anni Ottanta soprattutto: dall’informazione, oggi detta comunicazione, all’arte e alla letteratura, dal teatro al cinema, dall’editoria alle altre branche dell’industria culturale (festival compresi), dalla scuola al volontariato nelle variegate forme del terzo settore – non sia il frutto di quell’ “esasperazione personale” che pure l’autore ammette, ma di un’analisi dettagliata che non solo la vastità dei riferimenti ma anche lo stile adottato – fatto di giudizi inappellabili e riprese frequenti ma sempre pertinenti e di un tono che unisce l’invettiva alla considerazione scettica – non consentono di rendere in una nota di lettura.

Ognuno può trovare in queste pagine argomenti che lo toccano da vicino. Chi si prova a scrivere, ad esempio, si troverà a riflettere sulla necessità di “guardare con perplessità o sconforto alle illusioni degli scriventi – altra cosa dagli scrittori, secondo la distinzione introdotta dalla Morante – e dei leggenti (spesso molto simili e vicini tra loro, a volte e sempre più spesso la stessa persona) e dunque sull’opportunità di “guardare alla scrittura e alla lettura come a ‘droghe’ non poi così secondarie, grazie alle quali si può diventare certamente più intelligenti ma anche, e pericolosamente, più acquiescenti all’andamento del mondo così come lo guidano i potenti, diventandone passivamente complici”. Perché “Se il verbo non si fa carne, cioè presenza e intervento nella storia per renderla migliore, per riscattarne la tragedia, è grande il rischio che rimanga inerte chiacchiera, ciarla, evasione. E, a ben guadare, colpa”. Ma più in generale, a trovare in questo libro motivi di inquietudine e ragioni di autoesame sono – siamo – tutti coloro che in tesi come quelle espresse da Fofi in varia misura si riconoscono senza per questo avvertire, tuttavia, la necessità indilazionabile di cercare un sbocco pratico, politico, collettivo alle loro convinzioni. A tutti costoro l’autore rivolge un invito preciso, anche se non certo declinabile in soluzioni specifiche: “diamoci scopi adeguati ai bisogni del tempo in cui viviamo, ai bisogni di questo tempo. Se non lo facciamo, siamo semplicemente dei complici e dei vili. Magari intelligenti, magari bravissimi, (…) teste che scrivono e dicono cose di grande interesse e perfino utili, ma indifferenti”, nella sostanza. Non distinguibili da coloro che “Non credono più in nessuna possibilità di contrastare la china, anche se sanno che è una china mortale. Si accontentano di quel che passa quel che chiamano Storia” e “Finché dura, riescono persino a trarre da questo una sorta di drogata felicità”.
Questo testo compare anche nel sito della nuova libreria Rinascita di Brescia, alle cui attività culturali Carlo Simoni collabora.
“Non forbire, non limitare troppo…”
“Non forbire, non limitare troppo, sii sgraziato e audace. La brevità è sorella del talento”. (Anton Čecov)
Il piacere di narrare di un grande scrittore

Marina Paino, Il Barone e il Viaggiatore e altri studi su Italo Calvino, Marsilio 2019 (pp. 199, euro 13)
Per i numerosi cultori dell’opera di Italo Calvino la pubblicazione di un libro sul loro autore prediletto è sempre un’occasione per tornare a scoprire punti di vista nuovi, da condividere o con i quali misurarsi comunque. In molti casi, il Calvino che in questi studi si ritrova risulta una figura stilizzata, se non ridotta allo scrittore più interessato ai meccanismi dello scrivere che al piacere del narrare, ed è appunto a riequilibrare questa tendenza critica che arriva questa rilettura del Barone rampante e di Se una notte d’inverno un viaggiatore, i due romanzi più lunghi di Calvino, tanto lontani per impostazione narrativa – tradizionale il primo, sperimentale il secondo – quanto accostabili per l’“impronta volutamente coinvolgente” e soprattutto per la scelta di raccontare “vite di personaggi in qualche modo sovrapponibili a quella dell’autore”: in due sensi. Innanzitutto perché vi si possono rintracciare riferimenti autobiografici, anche se non espliciti, ma connotati da un’indubbia importanza esistenziale per l’autore; in secondo luogo, perché vi traspare una “passionalità” che si rivela nelle “più riuscite rappresentazioni dell’amore e dell’eros che Calvino abbia mai affidato ai suoi libri”. Se è soprattutto nel Viaggiatore che si possono leggere i diversi aspetti dell’esperienza di scrittore, di “uomo di casa editrice” e, certamente, anche di “teorico della letteratura” – perennemente attratto da Le mille e una notte, luogo della “basilare e partecipata sovrapposizione tra l’esistenza e la fruizione di storie” –, è nel Barone che non solo è facile scorgere in Cosimo una “proiezione” dell’autore, ma è anche possibile ripercorrere allusioni alla propria vicenda personale e “velate riscritture del (suo) romanzo familiare”. È questa la traccia di ricerca che si segnala per un’originalità e un’acutezza di sguardo che raramente si riscontra in altri saggi sull’opera di Calvino. Senza nulla togliere alle “Tre letture per il Viaggiatore”, che costituiscono la seconda parte del libro, né ai tre studi raccolti nell’Appendice, infatti, è nella prima parte – dedicata al Barone rampante – che ritroviamo una rilettura per alcuni versi sorprendente. A partire da “un passo poi non confluito nell’edizione del libro, nel quale Biagio, il narratore, richiama un tratto della personalità del fratello: “una componente di rimorso per aver sottratto la sua vita all’immediata comunanza con gli uomini”, altra faccia del suo ininterrotto tentativo di “conquistare un equilibrio tra l’arbitrio ingiustificabile della sua volontà di star sugli alberi e una giustificazione sociale”. Al di là dell’eco della vicenda di Calvino, con il coinvolgimento diretto nell’attività di partito comunista – e più in generale in quella “lunga dialettica fra ‘militanza’ e ‘fantastico’” richiamata da un altro autorevole lettore: il Carlo Ossola di Italo Calvino. L’invisibile e il suo dove (Vita e pensiero 2016), – è proprio in posizioni come questa, nella loro mai risolta complessità – o contraddittorietà, se si preferisce – che risiede uno dei motivi per cui lo scrittore resta attuale, testimone di un modo d’essere che non ha certo perduto le sue ragioni politiche e culturali e, più in generale, esistenziali. Ragioni riassumibili nella convinzione che “per essere con gli altri, la sola via (è) d’essere separato dagli altri”.

La sensibilità dell’autrice si evidenzia tuttavia soprattutto laddove ci accompagna a riconsiderare il rapporto di Cosimo con il padre da un lato e la madre dall’altro e, parallelamente, quello di Calvino con i propri genitori, e dunque la passione agronomica e botanica che li aveva contraddistinti, le loro scelte di vita: “eredità genitoriali che lo scrittore sembra abbracciare e da cui sembra allo stesso tempo prendere le distanze”, e che nel romanzo articola nella figura di un figlio che metaforicamente fa propria la passione per la natura del padre reale – nel mentre lascia su uno sfondo “inconcludente e macchiettistico” il genitore romanzesco – e rivela invece una vicinanza profonda e sostanziale con quella madre che, da Generalessa austera e distaccata, diventa fulcro di “una storia d’amore riscoperto”, lasciando emergere un’insospettata convergenza fra la determinazione del figlio a rispettare fino all’ultimo il suo stile di vita e il costume della madre reale, per la quale “il giardino, il volontario confino, la passione che si trasforma in dovere” erano state le costanti di una vita.
Questo testo compare anche nel sito della nuova libreria Rinascita di Brescia, alle cui attività culturali Carlo Simoni collabora.
“[Ho letto] Una considerazione di Wittgenstein…”
“[Ho letto] Una considerazione di Wittgenstein, secondo cui egli pensava con la penna e non con la testa, nel senso che la scrittura disvela un sapere di cui non si è consapevoli a priori”. (Maurizio Balsamo)
Una vita lacerata in un paese spezzato in due

Viola Ardone, Il treno dei bambini, Einaudi 2019 (pp. 239, euro 17,50)
“Siamo i bimbi del Mezzogiorno. La solidarietà e l’amore degli emiliani dimostra che non esistono Nord e Sud, esiste l’Italia”: è la scritta che compare in una foto ricordo di un fatto poco noto. Nel 1946, il Partito Comunista organizza il trasferimento e il soggiorno di un anno di bambini del Sud presso famiglie emiliane per toglierli dalla miseria che appena dopo la guerra si è fatta laggiù ancora più drammatica.
Questo il fatto. Ma è innanzitutto il linguaggio adottato a farne materia di romanzo. Il linguaggio e chi lo parla: è di uno di quei bambini, Amerigo, il punto di vista da cui la storia viene narrata, a partire dal tragitto che lui e la madre fanno per andare a sentire dell’inaspettata opportunità: “Mia mamma avanti e io appresso. Per dentro ai vicoli dei Quartieri spagnoli mia mamma cammina veloce: ogni passo, due miei. Scarpa sana: un punto; scarpa bucata: perdo un punto. Senza scarpe: zero punti. Scarpe nuove: stella premio. Io scarpe mie non ne ho avute mai…”.
La madre Antonietta, che vive di espedienti e di scambi di favori con un malavitoso, chiusa nel suo realismo disperato; Maddalena, l’attivista che organizza il viaggio superando la diffidenza della donna; e poi altre donne, lassù in Emilia: Derna, l’affidataria, un’altra attivista, e la cugina Rosa, nella cui casa Amerigo passerà la maggior parte del tempo fra i figli di lei (Rivo, Luzio e Nario): il romanzo mette in scena figure, di donne soprattutto, delineate con pochi tratti, ma che nel corso della vicenda acquisiranno sostanza e fisionomie inconfondibili, destinate a fissarsi nella memoria del lettore.

È là, lontano da casa, che Amerigo, oltre che poter calzare scarpe decenti, conoscerà la musica, e la vocazione che ne farà un musicista, un giorno, ma intanto, passato il periodo stabilito, deve tornare: superata la paura con cui era partito (indotta da voci come quella che li avrebbero portati in Russia, lui e gli altri) e lo spaesamento dei primi tempi, è poi il dover tornare a confrontarsi con lo squallore senza speranza del basso dove la madre ha continuato a vivere e della bottega di calzolaio – ancora le scarpe… – in cui il bambino sarà messo a lavorare a imporsi, a suscitare l’impressione di essere spezzati in due metà. Non più là, ma neanche qui, come un tempo. E allora la fuga, il ritorno al Nord, e una vita che andrà per la sua strada e solo molti anni dopo riporterà il protagonista a Napoli, dove la madre è appena morta, ma la città non lo accoglie, né come un “turista” né come “uno che appartiene alla città”: “Forse – conclude Amerigo – sarò sempre solo questo: uno che è andato via”.
Avevamo già conosciuto sentimenti simili di irrecuperabile lacerazione, nell’Arminuta di Donatella Di Pietrantonio, ma è il pathos de La storia di Elsa Morante a risuonare via via in queste pagine.
Questo testo compare anche nel sito della nuova libreria Rinascita di Brescia, alle cui attività culturali Carlo Simoni collabora.
“Tutto quello che uno scrittore fa di diverso dallo scrivere…”
“Tutto quello che uno scrittore fa di diverso dallo scrivere è un tradimento dell’essere scrittori. Non lo si dovrebbe mai fare. Però la gente soffre. E allora tu sei davanti a un dilemma: proteggere la tua professione, o proteggere quelle persone che sono silenziose, senza voce e non hanno mezzi? Io ho cercato di fare tutte e due le cose. E tuttavia penso di avere commesso un crimine contro il mio mestiere, cioè contro il fatto di essere uno scrittore”. (Ahmet Altan)
La realtà e il racconto

Janne Teller, È la mia storia, Feltrinelli 2019 (pp. 130, euro 14)
Il riferimento è esplicito: il Mann che fa valere le sue ragioni a proposito dei Buddenbrook, “un libro che viene sempre tirato in ballo in ogni processo scandalistico – scriveva in Bilse e io, nel 1906 –, per il motivo che i suoi personaggi s’ispirano in parte a persone reali”, quando dev’essere chiaro che “La realtà che un poeta utilizza per i suoi fini può ben essere il suo mondo quotidiano, le sue persone più vicine e care (…) ciò nondimeno esiste per lui – e dovrebbe esistere per il mondo! – una differenza abissale tra la realtà e la sua costruzione poetica: la differenza essenziale, cioè, che separa il mondo della realtà da quello dell’arte”.
Non è un grande scrittore a porsi il problema, in questo romanzo, bensì l’editore di un autore che grande non è, ma di sicuro incontrerà il favore del pubblico in un mondo come quello di oggi in cui “i media sono tutto, e l’assenza di scrupoli dello scrittore sembra fatta apposta per la luce dei riflettori”.
Eppure il problema si pone, tanto più che è il tema del discorso che il protagonista deve pronunciare l’indomani mattina: “Si ha il diritto di rendere pubblica una storia che ci è stata raccontata in modo confidenziale solo perché ci si è presi la briga di cambiare i nomi? Trasformare la realtà in narrativa dà carta bianca?”, si chiede, e la riposta che trova sembra quietarlo: “L’arte non è la realtà – sosterrà –. L’artista attinge dalla realtà per creare una riflessione narrativa sulla realtà”.

Ma la questione si complica: il passato non passa, perché possiamo sopravvivere a quello che ci fanno gli altri, non a quello che noi facciamo a loro. Non solo non passa per la donna che è stata da lui poche ore prima, diffidandolo dal pubblicare il romanzo che ha sul tavolo essendo che quella è la sua storia, ma coinvolge di fatto anche l’editore. Nel suo studio, alle prese con la stesura del discorso di cui leggiamo via via le argomentazioni, il problema di coscienza rappresentato dalla decisione se pubblicare o no quel romanzo deborda in un riesame complessivo della sua vita, della sua carriera, del suo matrimonio e delle sue molte relazioni parallele. La sua esistenza ha finito col trovare, di fatto, un termine di confronto ineludibile nella certezza morale di quella donna che si ritiene illegittimamente chiamata in causa dal romanzo. La scrittura di Teller restituisce il ritmo spezzato di un flusso di coscienza che torna continuamente su un dilemma inestricabile, si contraddice, rettifica, crede di aver trovato la soluzione per poi vederla sfarinarsi e tornare quindi ad arrovellarsi daccapo: “I Buddenbrook sarebbe un romanzo peggiore se la famiglia protagonista non fosse riconoscibile? Se i fatti narrati non si svolgessero a Lubecca, ma ad Amburgo?”.
Questo testo compare anche nel sito della nuova libreria Rinascita di Brescia, alle cui attività culturali Carlo Simoni collabora.
La pazienza e il mistero

Patrik Svensson, Nel segno dell’anguilla, Guanda 2019 (pp. 275, euro 18)
L’esistenza misteriosa, e per certi versi ascetica, dell’anguilla è al centro del discorso, ma si intreccia, a capitoli alterni, dall’inizio alla fine, con un altro enigma, naturale quanto insondabile: quello del rapporto fra un padre e un figlio. È anche un romanzo di formazione, questo romanzo-saggio che sa incrociare la storia degli anni in cui i due hanno pescato insieme anguille e la progressiva comprensione – ad opera di filosofi, naturalisti, scienziati – dell’esistenza di questi animali longevi e ostinati, solitari e impavidi, che continuano attraverso i secoli, i millenni, il loro peregrinare fra il Mar dei Sargassi e i fiumi europei, fra l’acqua salata e l’acqua dolce per poi tornare a riprodursi, e morire – ma la faccenda non è tuttora chiara – nella prima. Un viaggio che questi pesci – a lungo non considerati tali – hanno continuato imperturbabili di fronte alle guerre che hanno scosso il mondo come alla curiosità umana. Un tempo lento, circolare, che sembra in qualche modo imporsi a chi con le anguille ha a che fare, perché pescarle non tollera la fretta: “La pazienza era il primo requisito che bisognava avere. Dovevi donare all’anguilla il tuo tempo”. E stare zitti: “Quando eravamo giù al torrente, non mi ricordo che parlassimo d’altro se non di anguille e del modo migliore per catturarle. O meglio, non mi ricordo proprio che parlassimo. Forse perché in effetti non lo facevamo mai. Forse perché ci trovavamo in un luogo dove il bisogno di parlare era limitato, un luogo che per sua natura poteva essere meglio apprezzato in silenzio. (…)

Bisognava stare zitti per diventare una parte del tutto”. Anche se lei, l’anguilla, restava sempre al di là: “Ogni volta che pescavamo un’anguilla, la guardavo negli occhi, cercando di cogliere un frammento di quello che aveva visto. Ma nessuna ricambiò mai il mio sguardo.” Ma neanche quello indagatore degli studiosi. “Gli uomini che nel corso dei secoli hanno considerato il dilemma dell’anguilla un problema da risolvere – passando da una domanda all’altra: è un pesce? è sessuata? perché quel lunghissimo ritorno al luogo d’origine per riprodursi? – sono sempre stati fedeli, in modo quasi amorevole, anche all’enigma stesso”. Il che non significa che “l’uomo, prima o poi, troverà una risposta. Basta dargli tempo”. Non fosse che “il problema è che per l’anguilla il tempo sta per scadere”, e “l’ultimo interrogativo, il più urgente, che riguarda l’anguilla” è ormai un altro: “perché sta morendo?”. Diversi, e fra loro intrecciati, i fattori – tutti umani – di un’estinzione imminente, “che trascende il normale progresso dell’evoluzione e della vita”, e non si lascia contrastare da misure risolutive: l’anguilla, a differenza del salmone, non si è mai riusciti ad allevarla, a farla riprodurre in cattività. Mentre “Il processo in atto corre incredibilmente veloce” e la sua portata è ormai riconosciuta: “se per le precedenti estinzioni di massa – cinque – si parlava di eventi che avvennero in milioni di anni, adesso si parla di secoli, ma ciò che rende l’odierne estinzione di massa davvero unica è che per la prima volta nella storia c’è un responsabile vivente”. Che pure ha convissuto a lungo con l’anguilla pur pescandola e cibandosene, come per anni hanno fatto quel padre e il figlio che “nel segno dell’anguilla” ha costruito il suo rapporto con il mondo, il suo incanto, i suoi misteri.
Questo testo compare anche nel sito della nuova libreria Rinascita di Brescia, alle cui attività culturali Carlo Simoni collabora.
“Si pensa che da grandi emozioni nascano…”
“Si pensa che da grandi emozioni nascano anche grandi poesie. La maggior parte delle persone non va mai oltre questo equivoco”. (Cees Nooteboom)
Far pace con il tempo che passa

Fabio Geda, Una domenica, Einaudi 2019 (pp. 192, euro 16)
“Aveva sessantasette anni ed era vedovo da otto mesi, durante i quali aveva scoperto di aver prestato nel corso della vita più attenzione alle cose urgenti che a quelle importanti; ma a tale proposito, oramai, non c’era molto che potesse fare, se non dimostrare a se stesso e ai figli di saper attraversare il resto del tempo distinguendo con maggiore consapevolezza le une dalle altre”: nel ritratto del pensionato ex ingegnere di ponti per lunghi periodi lontano dalla famiglia ci sono già la storia e il suo significato. Riempire la casa vuota invitando a pranzo, una domenica, la figlia maggiore con la sua famiglia, cucinando lui come aveva sempre fatto la moglie. La figlia che sta più vicino – Biella, non troppo distante da Torino. Il figlio è lontano, l’altra figlia sta a Roma: Giulia, la voce narrante. Figli lontani, vedovi soli: il protagonista ma anche la donna che incontra ai giardini a sorvegliare il figlio, skater spericolato, dopo che il pranzo è andato a monte, per un piccolo incidente di una delle nipoti. E allora, tutte quelle buone cose preparate come a rievocare la tradizione familiare ravvivando una tavola ormai deserta? Di qui l’invito a Elena e al figlio Gaston. Un gesto gratuito, e a suo modo necessario.
Come in tutti i romanzi migliori, fra i personaggi se ne aggira uno senza volto, muto, pervasivo: il Tempo. Il tempo passato che emana dall’agenda di ricette compilata dalla moglie morta, il tempo di quando i figli erano bambini, il tempo che si porta via la vita e ci mette di fronte al fatto che “invecchiando si perdono molte cose. Soprattutto cose che non sapevamo di avere.” Ma c’è il tempo presente a far valere i suoi diritti, e ad offrire opportunità, sempre che le si sappia cogliere. Con l’umiltà che il vecchio ingegnere sa mostrare: ascoltando Elena, giocando con Gaston, recuperando – senza mea culpa, ma con una lucida consapevolezza di quel che è stato – il rapporto con Giulia che, come accade in ogni famiglia, era stata quella che aveva subito il peso maggiore della distanza del padre, avvertita anche dai fratelli, e dalla madre forse, ma fattasi in lei motivo di allontanamento dal genitore. Un allontanamento che cederà tuttavia a “una nuova complicità” con il padre, che “nulla (toglie) alle incomprensioni del passato”, ma le rende più “gestibili”. Perché – e l’osservazione si fa qui messaggio che, per il lettore, ben si accorda con il Natale imminente – “Non si (tratta) di cancellare o dimenticare: ma di perdonare”, godendo di quello che occorre saper riconoscere: “un tempo nuovo”.

E dunque tutto si risolverà, perché i personaggi sanno rispondere a una “comune voglia di racconto”, di condivisione delle vicende vissute e del tempo nel quale si sono svolte e rivivono. Nel racconto, appunto. Un racconto, questo di Geda, nel quale – ha notato Ida Bozzi su La lettura dello scorso 15 settembre – l’autore “non si limita a mettere in campo la classica struttura con l’intreccio principale e i flashback”, ma lascia emergere “un terzo tempo, successivo al pranzo raccontato e a quello dei ricordi evocati, un tempo nuovo che può esistere perché l’invito a pranzo c’è stato” e in seguito Giulia ha potuto conoscere Elena che gliene ha raccontato. È nel tempo della narrazione che tensioni e distanze trovano composizione e insieme un luogo nel quale consistere: la casa, che dopo la morte del padre i figli non si sentono di vendere perché è “Un luogo in cui tornare di tanto in tanto. Per dialogare con il tempo che passa e cercare di farci pace.”
Questo testo compare anche nel sito della nuova libreria Rinascita di Brescia, alle cui attività culturali Carlo Simoni collabora.
“Io non sono uno di quei cattivi scrittori…”
“Io non sono uno di quei cattivi scrittori che dicono di scrivere solo per se stessi. C’è una sola cosa che si scrive per se stesso, ed è la lista della spesa. E quando hai comperato le cose che dovevi, puoi distruggerla. (…) Ogni altra cosa che scrivi, la scrivi per dire qualcosa a qualcuno”. (Umberto Eco)
Leggere: un “raccoglimento laico”
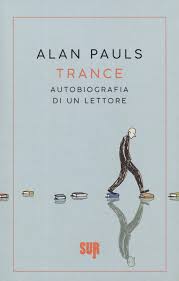
Alan Pauls, Trance. Autobiografia di un lettore, Sur 2019 (pp. 136, euro 12)
Il protagonista è un lettore molto forte, ma è un po’ tutti coloro che leggono molto.
La trance del titolo è quella cui la lettura può dar luogo quando sembra che “il mondo sia sparito con tutto dentro, compreso tutto ciò che (si) ama tranne quello che (si) sta leggendo”: anche il proprio corpo passa in secondo piano ed è questa “la prova più irrefutabile dell’intensità della trance in cui cade chi legge (…): solo ripiegamento e oblio, l’indifferenza quasi zen in cui la lettura avvolge chi legge, disattivando tutte le funzioni che potrebbero cospirare contro l’esclusività dell’esperienza”.
L’autobiografia del sottotitolo – organizzata in brani disposti in ordine alfabetico – parte proprio da qui: dal fastidio, dall’incubo anzi che l’interruzione rappresentava già per il lettore bambino, lettore precoce tanto da imitare l’atto del leggere ancor prima di saperlo fare, e arriva alle riflessioni del lettore attempato sulle pagine da lui variamente chiosate e sottolineate, prova di una dedizione durata l’intera vita. “Quando torna ai libri più vecchi che ha – infatti –, quelli più segnati dalla sua mania di sottolineare, ha l’impressione di trovarsi fra le mani non un libro ma due: uno, il libro in sé, originale, intatto; l’altro (…) (che) narra la sua storia di lettore”.
Tra uno e l’altro capo, osservazioni su che cos’è leggere tanto penetranti e originali – spesso assonanti con quelle lette in Una meravigliosa solitudine. L’arte di leggere nell’Europa moderna di Lina Bolzoni (Einaudi 2019) – che vale la pena di seguirle pur attraverso riferimenti culturali che sfuggono spesso al lettore medio italiano.

Osservazioni che ci vengono proposte fin dalla esplicitazione iniziale dello scopo del libro (o “glossario”, come Pauls preferisce chiamarlo): “Dichiarare il debito incommensurabile che lo scrivere (compulsione strategica) ha con il leggere (quel vizio gratuito, benefico, generoso)”. Sempre che la lettura sia vera lettura, consapevole che “in tutto ciò che è scritto c’è sempre qualcosa di non scritto”, che cogliere il senso di un testo non è come centrare un bersaglio perché il senso è “qualcosa che non esiste prima”, ma è “qualcosa che nasce e si fa e si disfa nell’incontro fra un testo e un desiderio di leggere”. È allora che nasce una reciprocità che dà sostanza alla lettura e le conferisce la sua “ingenuità provocatoria”, la tranquilla rivendicazione del proprio anacronismo di attività che impone continuità e concatenamento “in uno stato di cose in cui moneta corrente sono la simultaneità e il montaggio”, che chiede una dedizione esclusiva che contrasta radicalmente il multitasking imperante.
Un elogio del leggere, dunque, che non ignora tuttavia la nota obiezione: leggere finisce con l’essere uno stratagemma per non vivere, una pratica di fuga dal mondo. Un argomento con cui Pauls si misura ripetutamente, per arrivare a una conclusione difficilmente contestabile: “Si legge per vivere quanto per evitare di vivere; si legge per sapere che cos’è vivere e come vivere; si legge per fuggire dalla vita e immaginare una vita possibile”. Si legge dovunque e comunque, come i lettori “rilassati” di Steve McCurry, colti in quel loro “raccoglimento laico” che sa resistere a guerre, miseria, catastrofi naturali. Loro, e tutti quanti leggono davvero, fedeli al “modello di ciò che ogni lettura dovrebbe essere: una pratica (un’etica) della fiducia”.
Questo testo compare anche nel sito della nuova libreria Rinascita di Brescia, alle cui attività culturali Carlo Simoni collabora.
“Io, stare tanto tempo senza scrivere neanche un libro…”
“Io, stare tanto tempo senza scrivere neanche un libro, non so come dire, sì, avevo due libri che dovevano uscire, ma li avevo finiti di scrivere più di un anno prima, era più di un anno che non scrivevo un libro nuovo e a star tanto tempo senza scrivere niente, mi sentivo in colpa. Per quello, credo, avevo bisogno di cominciare una cosa”. (Paolo Nori)
I retroscena della Mille Miglia

Massimo Tedeschi, La maledizione del numero 55. Un’indagine del commissario Sartori da Salò, La nave di Teseo 2019 (pp. 176, euro 16)
Da narratore seriale ormai consumato – e approdato con questo romanzo a una casa editrice prestigiosa – l’autore sa da subito mettere a suo agio il lettore, sia quello che per la prima volta incontra il commissario Italico (Italo, più comunemente) Sartori e nei cenni che lo inquadrano trova i riferimenti necessari per dargli un volto e una personalità inconfondibile, sia quello che riconosce il personaggio avendolo seguito nelle indagini precedenti e prova un’impressione di familiarità nel ritrovare il caffè Impero dove lui fa sosta ogni mattina per bere il suo latte macchiato, il cane Argo che lo accoglie affettuoso, la villa che si intravede dall’altra parte del golfo, a Portese, e calamita lo sguardo del commissario evocando in lui brividi di desiderio ma anche, in questo caso, l’inquietudine che travaglia gli amanti tormentati da un disaccordo di cui non sanno prevedere gli esiti. Già, perché la bella – e agiata, quanto generosa – vedova Anna Arquati, altra vecchia conoscenza, intende partecipare alla Milla Miglia che si sta per disputare, suscitando la preoccupazione, ma soprattutto la gelosia di Sartori, che già se la immagina attorniata da una schiera di ammiratori.
Ma Salò è solo uno dei luoghi lacustri che fanno da cornice alla vicenda: sono l’intero Garda bresciano da Sirmione a Limone – questa la giurisdizione del commissario –, il suo paesaggio, le sue atmosfere diverse secondo la stagione ad accompagnarci nella lettura, a darle un sapore che sembra fare dei romanzi di Tedeschi i capitoli di un’unica storia che si snoda attorno a un lago ora radioso ora grigio e nebbioso ma sempre capace di suggestioni inimitabili.
La velocità, mito dominante dell’epoca, non si concretizza questa volta negli idrovolanti del Reparto Alta velocità – come nell’Ultimo record – manelle rombanti automobili della Mille Miglia del 1936, di poco seguente alle esequie del poeta del Vittoriale, figura simbolo di quel mito e presenza ricorrente nelle avventure del nostro commissario, fin da Carta rossa, il primo romanzo. Sartori non ha tuttavia tempo di seguire i frenetici preparativi della gara. Ha altro da pensare: dalla morte apparentemente accidentale di uno dei piloti francesi iscritti alla corsa e del suo meccanico all’assassinio di una maga, la famosa Nefertari, al secolo Luigina Stroppa, alle cui capacità medianiche ricorrevano i più disparati personaggi dell’ambiente gardesano.

È a Brescia che l’indagine conduce Sartori, nello studio del patron della corsa, Renzo Castagneto, e proprio dal dialogo fra i due – vero pezzo di bravura per realismo e vivacità, insieme alla descrizione di Piazza Vittoria alla vigilia della gara: sembra oggi, non fosse per la presenza del Bigio… – verrà il sospetto circa le cause effettive dell’incidente mortale. Nelle miserie dell’ambiente borghese della Riviera si dovrà invece cercare il movente dell’uccisione dell’indovina, un ambiente che offre all’autore spunti in abbondanza per darci – come nei romanzi precedenti, si pensi a Villa romana con delitto – un quadro dettagliato e impietoso di un mondo le cui doppiezze e meschinità trovavano alimento nel conformismo imposto dal regime.
Questo testo compare anche nel sito della nuova libreria Rinascita di Brescia, alle cui attività culturali Carlo Simoni collabora.
“Non mi sento capace di scrivere…”
“Non mi sento capace di scrivere un io completamente autobiografico (…) Invento personaggi finti che però nutro con tutto ciò che ho dentro”. (Nadia Terranova)
La forma e il volto della città / Fabbriche e graffiti
Un contributo importante all’archeologia industriale
Tag, segni e tracce lasciate nelle Cattedrali del lavoro ormai abbandonate immortalate da Gigi Bellometti.
Ha respirato l’aria della fabbrica, Gigi Bellometti, sin da bambino, nelle officine meccaniche del nonno, e poi da operaio, in gioventù, e in seguito, per una vita – arrivata oggi vicino agli ottanta – attraverso l’impegno a vario titolo prestato nel sindacato.
Un’aria, quella dei capannoni e delle macchine, che si è tuttavia rarefatta a partire dalla fine degli anni ’70 e soprattutto con le grandi ristrutturazioni degli anni ’80, che dopo il tessile investirono il metalmeccanico.
Di qui la consapevolezza che, come la memoria della civiltà contadina in seguito allo spopolamento delle cascine, così anche quella dei luoghi della produzione industriale poteva disperdersi con l’abbandono e il degrado di quelle che si potevano considerare Cattedrali del lavoro. Questo il titolo del grande reportage fotografico con il quale Bellometti ha offerto un contributo importante alla ricerca archeologico-industriale diffusasi in Italia, e a Brescia, sul finire degli anni ’70. Gli stessi in cui – la coincidenza appare in questo caso significativa – apparivano nei ghetti newyorkesi i primi graffiti, manifestazione di quella cultura hip-hop non a caso richiamata in una delle immagini che in anni recenti Bellometti ha scattato fra le rovine delle fabbriche disertate dal lavoro, a Brescia come a Nave e in altri centri della provincia.
Continua a leggere La forma e il volto della città / Fabbriche e graffiti