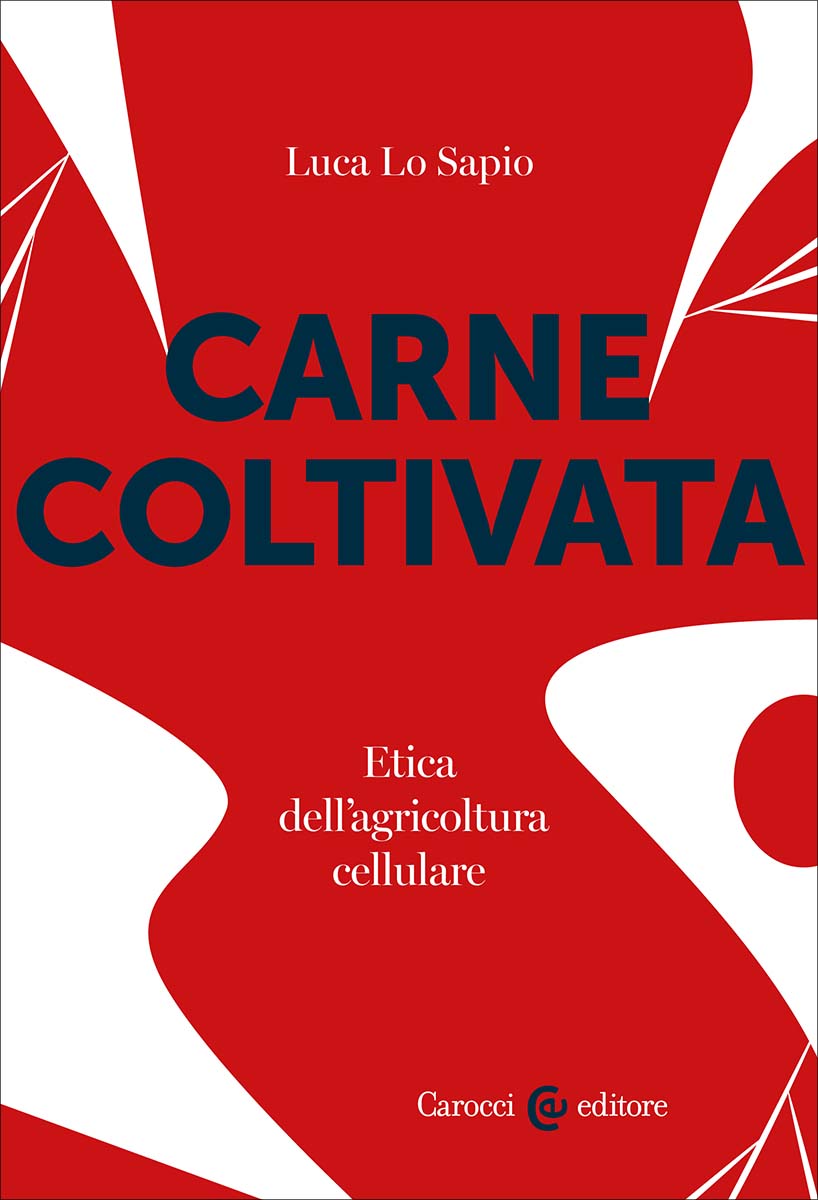
Luca Lo Sapio, Carne coltivata. Etica dell’agricoltura cellulare, Carocci 2024 (pp. 112, euro 13)
Il discorso è chiaro fin dal titolo dell’opera, di tal Charles Patterson, citata nella prima riga: Eternal Treblinka. Our Treatment of Animals and the Olocaust. Viene subito alla mente l’inappellabile sentenza di Adorno: “Auschwitz inizia quando si guarda a un mattatoio e si pensa: sono soltanto animali”. Un libro sui diritti animali dunque? Liberazione animale di Peter Singer è senz’altro un riferimento essenziale per l’autore, così come viene sottolineata l’importanza di riconoscere anche agli animali una vita non solo biologica ma biografica.
Il discorso si arricchisce tuttavia in questo libro di un aggiornamento decisivo a partire dalla novità sostanziale rappresentata dalla possibilità di passare dall’allevamento alla coltura anche in campo animale, riducendo drasticamente l’impatto del modo in cui ci procuriamo la carne non solo sul “benessere animale”, ma anche sull’ambiente e sulla stessa salute degli animali umani.
Soprattutto in un momento in cui è facile prevedere che le scelte europee in materia, già ridimensionate dalla revisione del Green Deal prima delle ultime elezioni, saranno oggetto di ulteriori discussioni, è utile dotarsi di nozioni quali agricoltura cellulare, ossia “l’insieme delle procedure che consentono di ottenere carne da cellule animali e vegetali” (il che esclude la prospettiva di produrre qualcosa di “sintetico”, è bene chiarire), e bioeconomia, “il settore economico che la nuova tecnologia consentirà di avviare”. Al fondo, la possibilità di “avere un’alternativa che eviti il ricorso a cibi derivati dalla sofferenza e dalla morte di miliardi di esseri senzienti”. Detto in altre parole: “se non riusciamo a cambiare il nostro desiderio di carne, forse possiamo cambiare il modo in cui lo soddisfiamo”. Un modo allo studio sin dai primi del ’900, caldeggiato niente meno che da Winston Churchill, conquistato dal sogno di poter mangiare un petto o un’ala di pollo senza dover allevare – e poi ammazzare – un pollo intero. Dal sogno alla realtà: l’anno scorso l’Italia è divenuto il primo paese al mondo a vietare produzione e vendita di carne coltivata. Il che non ha però impedito ma anzi ha incrementato il dibattito, da subito incanalato in una polarizzazione fra pro e contro poco favorevole a richiamare un distinguo fondamentale, consistente nel riconoscimento che “non sono la produzione e il consumo di carne a essere moralmente – oltre che ambientalmente e sanitariamente – problematici, ma la produzione e il consumo di carne ottenuta mediante il sistema dell’agricoltura animale industriale” (per cui, più che chiederci se è giusto mangiar carne, sarebbe opportuno chiederci se è giusto mangiare questa carne). Sull’allevamento industriale intensivo si sofferma con efficacia l’autore, per poi passare al vaglio le possibilità concrete di superamento dell’“ideologia carnista”, prendere in considerazione le “argomentazioni morali sollevate contro l’uso della carne coltivata” e infine analizzare le responsabilità della scelta che grava sui privati cittadini da un lato e su governi e organizzazioni internazionali dall’altro. Il tutto, alla luce dell’adagio di Spinoza: “le azioni umane non vanno derise, compiante o disprezzate ma comprese”. E, una volta comprese, valutate obiettivamente anche per quanto riguarda i loro possibili sviluppi: una volta che si sia adeguatamente sperimentata e convertita a una produzione su scala industriale, ad esempio, la coltivazione di carne “potrà realmente rappresentare una speranza per il futuro o verrà risucchiata da dinamiche di mercato regolate interamente dalla logica del profitto”, con la conseguenza di una sostanziale riduzione delle sue multiformi potenzialità?
Ma l’autore non è né un biologo né un economista. È un filosofo, e come tale pone questioni alle quali nessuno può dichiararsi estraneo. Una per tutte: gli animali vivono in un eterno presente, “non hanno alcuna nozione del tempo”, e dunque non possono “avere alcuna preoccupazione relativa alla propria morte”, dal che deriva che “ucciderli in maniera indolore non è un male”. Senonché, la consequenzialità del ragionamento è facilmente smentita dall’esperienza (e smascherata nella sua malafede), essendo noto che “la maggior parte degli animali allevati nell’agricoltura industriale è capace di comportamenti complessi di natura cooperativa e, pur non avendo capacità linguistiche o un nozione di tempo accostabile a quella umana, nondimeno, con il proprio comportamento, esprime preoccupazioni relative al futuro e mette in atto strategie d’azione per la conservazione della propria vita”. Il fatto è che “quasi mai il consumatore è a conoscenza di che cosa realmente avvenga negli allevamenti industriali” – circostanza discutibile alla luce di film documentari come il recente Food for profit, trasmesso anche in televisione –; inoltre, “la carne viene confezionata in modo da distanziare il prodotto dalla sua origine”, la macellazione, e infine, “il consumo di carne è parte di tradizioni gastronomiche e culturali” che sarebbe inutile ignorare. A meno che, lungi da ogni fiducia che l’introduzione di una nuova tecnica possa cambiare costumi e mentalità sedimentate, si consideri la possibilità di coltivare la carne all’interno di una più generale presa d’atto della necessità di “modificare alcuni tratti della specifica forma di vita che l’uomo occidentale si è dato”.

In conclusione, “l’introduzione della carne coltivata non è di per sé sufficiente” a produrre cambiamenti sostanziali, ma “può aprire a nuove possibilità dello stare al mondo, in cui gli animali non umani non saranno più visti come schiavi dell’uomo destinati al macello ma come alterità alle quali tributare rispetto morale in virtù del loro specifico statuto e della loro utilità in chiave alimentare”, visto che da loro continuerebbe a provenire la materia prima per la produzione di carne. “Utilità che, tuttavia, gli animali non saranno più costretti a pagare al prezzo della propria vita”.
