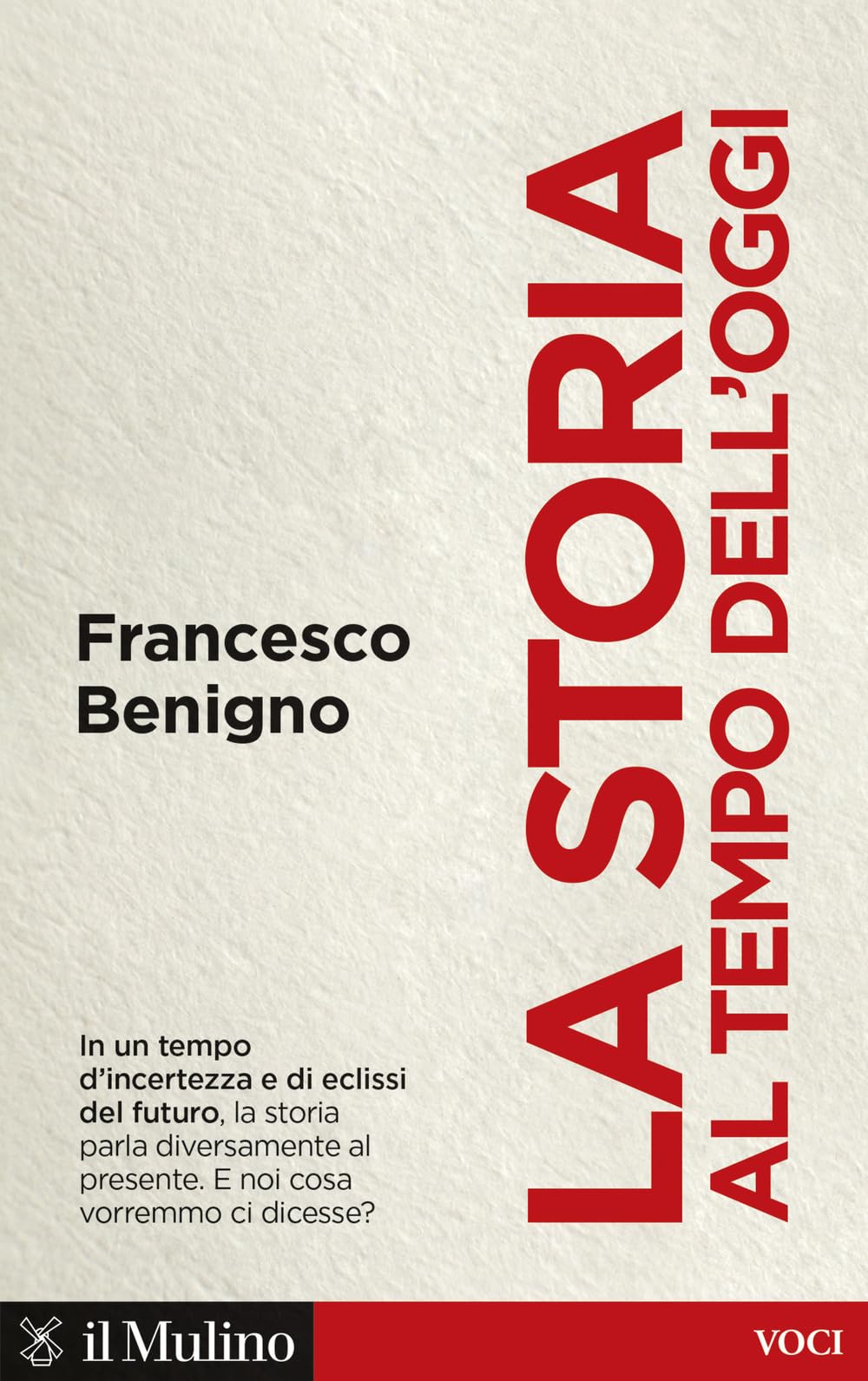
Francesco Benigno, La storia al tempo dell’oggi, il Mulino 2024 (pp. 174, euro 14)
“La storia oggi non sembra più capace di farci leggere il mondo, di spiegarlo”, il “legame tra la contemporaneità, l’ieri e il domani sembra essersi spezzato. Il futuro (…) si è come eclissato (…) gravido di incognite, segnato da una preoccupante incertezza. In breve, passato, presente e futuro si sono come allontanati fra loro”, il che trova riscontro nel fatto che “qualcosa si è rotto nella capacità complessiva di leggere il mondo in divenire (…) la stessa storia si è fatta difficile da capire e interpretare”.
Corrispettivo di questa evoluzione, a livello generale, è la “sensazione di vivere in un mondo a rischio”, aggravata da crisi climatica, pandemie, guerre da un lato, populismi e razzismi dall’altro, mentre “le ideologie politiche si sono disincarnate dai loro tradizionali riferimenti sociali” e “l’asse tra crescita economica, stato assistenziale e progresso civile e democratico (…) si è come scomposto” dando luogo a un diffusa diffidenza nei confronti dello stato, se non a “una malcelata riserva” o addirittura a un’“aperta resistenza”. Ma, più nel profondo, “si è diffusa un’inquietudine nuova, una paura collettiva della morte in società che la morte avevano, se non sconfitto, certo ridimensionato, allungando l’aspettativa di vita di più decenni in meno di mezzo secolo”. Il fatto è che allarme climatico, Covid e guerre “si sono innestati su un processo preesistente di messa in discussione della modernità occidentale”, alimentata dalla “provincializzazione dell’Europa” e dalla crisi dell’“esercizio unipolare del dominio geopolitico” da parte degli Stati Uniti”, così come dall’incrinarsi di quello che “appariva un modello vincente e indiscusso”: “l’insieme interrelato di liberaldemocrazia e di Welfare State che sembrava destinato a prevalere ovunque”. Di qui il disancoramento del passato dal presente e la perdita di prospettiva che legava presente e futuro: è la storicità – modo di guardare ai fatti che accadono e, insieme, di intendere la storia – che è oggi entrata in una fase di ridefinizione nella quale “il presentismo (ha) cambiato il nostro modo di vedere la storia”, “il moderno – con le sue idee cardine di progresso e sviluppo e il correlato politico-ideologico della democrazia – si è fatto antico, e il passato è diventato (…) un paese straniero”, diverso da quello in cui viviamo e quindi, per noi, tendenzialmente ininfluente. Detto in altre parole – quelle di un filosofo, Remo Bodei –, la “Storia” sembra esseri dispersa “in una pluralità di storie scoordinate (con la s minuscola), in vicende personali blandamente collegate a eventi comuni”. Ma anche chi – per formazione culturale o ruolo professionale – nel passato continua a vedere un riferimento imprescindibile non può che vedervi non “il luogo dove tracciare la radici del presente, le ragioni per cui il mondo è com’è”, quanto piuttosto “il luogo delle potenzialità inespresse, dei progetti non realizzati, delle alternative sconfitte, dell’alterità da ciò che ci è familiare”.
Eppure, nonostante la perdita di terreno e l’appannarsi del suo ruolo culturale e civile, la storia, o per meglio dire il suo orizzonte e la sua pratica sembrano aver conosciuto evoluzioni significative e, anche, essersi negli ultimi anni arricchiti di punti di vista nuovi, metodi innovativi, dilatazioni spazio-temporali.
In estrema sintesi, si è innanzitutto assistito al costituirsi di una nuova centralità: il posto che la Rivoluzione francese aveva assunto come termine di riferimento generale è stato occupato dall’Olocausto. Risultato: la contrapposizione oppressori/oppressi ha ceduto il passo a quella di carnefici/vittime e a una narrazione storico-sociale ne è subentrata un’altra di carattere sacrale-tragico, affidata soprattutto ai testimoni. Il tutto sullo sfondo di un generalizzato smarrimento della speranza in una società nuova sino alla tendenziale sostituzione dell’utopia con forme – secondo la definizione di Bauman – di “retrotopia”. Parallelamente, la memoria ha progressivamente conteso lo spazio alla storia sino a determinare – complice la diffusione dei nuovi mezzi di comunicazione di massa – l’affermazione di “una storia memoriale dotata di una superiorità mediatica (…) capace di produrre un’inedita narrazione sociale coinvolgente, una forma di storia poetica”: alla rivoluzione è subentrato il trauma, nell’immaginario storico-sociale, e alla comprensione l’identificazione, con l’esito di produrre in alcuni casi una “storia fai da te”.
I toni e gli argomenti dell’autore non sono quelli di una difesa corporativa degli storici, ma conseguono a una presa d’atto supportata da esempi e considerazioni che mettono in relazione l’evoluzione descritta con la precedente perdita di credibilità in una storia capace di restituire il passato così com’è avvenuto e una conseguente presa di coscienza da parte degli storici: non scienziati dediti a osservare in modo distaccato e obiettivo degli insetti, ma se mai “insetti fra gli insetti” loro stessi. Vocati a produrre non discorsi indiscutibili in quanto puramente oggettivi, ma a costruire narrazioni che, pur distinguendosene per il vincolo rappresentato dalle fonti documentarie, hanno parecchio da spartire con quelle letterarie, e non a caso non si preoccupano più di escludere, o nascondere, la soggettività dello storico stesso, le sue motivazioni, le sue passioni. Non portatori di una verità oggettiva quindi, gli storici, ma dotati delle competenze necessarie a farsi arbitri nelle “guerre della memoria” che connotano la relazione contemporanea con il passato (si pensi al dibattito sulle foibe, ma anche, verrebbe da aggiungere, a quello in corso sui fattori che hanno pesato nell’avvio della guerra in Ucraina…).

Dopo pagine fitte di rimandi alle evoluzioni più recenti dei riferimenti e dei condizionamenti culturali cui va soggetto il lavoro degli storici, la conclusione cui l’autore arriva è che solo “una più articolata visione della natura cangiante e plurale delle identità e il riconoscimento della centralità del conflitto potrebbero “offrirci uno sguardo diverso sul passato, più comprensivo e magari anche capace di cogliere tratti della contemporaneità che ci appaiono oscuri”.
Questo testo compare anche nel sito della nuova libreria Rinascita di Brescia, alle cui attività culturali Carlo Simoni collabora.
