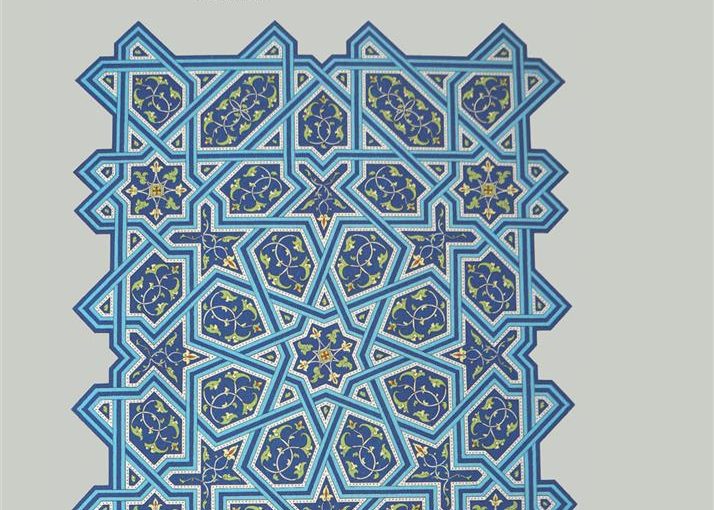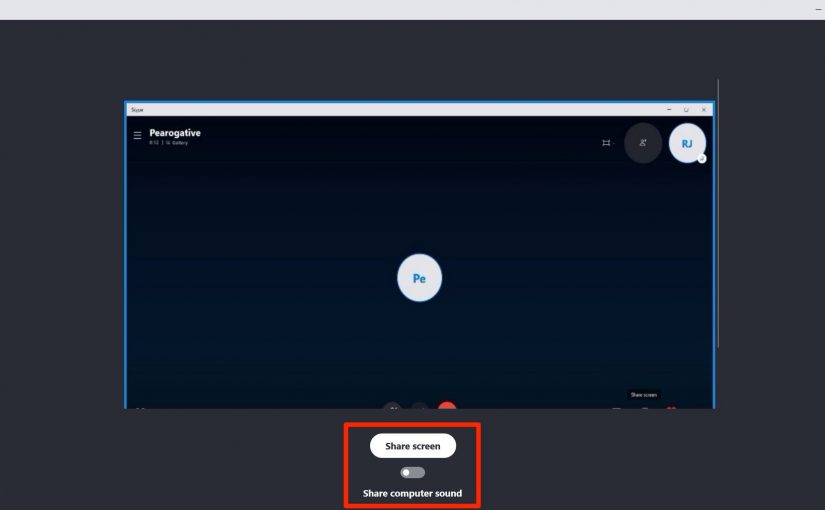Ruderi, solo ruderi coperti di muschio, si dice scrollando le spalle, mentre apre la porta di casa. Odore di chiuso. Il gatto le viene incontro stiracchiandosi. Anche lui ha fame. Croccantini per lui, passato di verdura per lei ascoltando il radiogiornale.
E rieccomi nel pantano della quotidianità.
Silenzio, nessun passo familiare sulle scale, ha quasi nostalgia del puzzo di curry e di aglio dei vecchi vicini indiani, delle loro voci cantilenanti. Li hanno fatti sloggiare tutti, gli immigrati, li hanno pigiati nella periferia sud della città, in casermoni grigi e tristi e il quartiere dei disperati è stato ristrutturato ed è diventato borghese e lustro. Ora ognuno in casa sua e, al massimo, qualche nota di musica classica.
La vita mi è andata liscia, pensa spazzolandosi i denti.
“Sopportabile” ribatte l’ex vicina genovese che le si fa incontro dallo specchio, le sclere gelatinose. “Sicura di non aver vissuto la vita sbagliata?”
“Vecchia megera” urla Maria sputacchiando dentifricio. Vorrebbe schiaffeggiarla, strapparle almeno una ciocca di capelli. “Con che diritto? Non sai nulla di me, di me dopo Genova. E tu? Tu sei stata sposata o sei sempre vissuta sola, sola e orba, con quegli occhi lattiginosi? Sì sono stata felice, per quel che si può, come tutti, felice a tratti, una felicità malinconica.”
Autore: Mariagrazia Fontana
Il glicine della casa all’incrocio
Di un amministratore di condominio non hanno mai pensato di avere bisogno. Tre famiglie in quel palazzo, tutti proprietari, e lei, la sola affittuaria. Si regolano fra loro senza bisogno di formalizzare. Marco Frigerio tiene i conti, è preciso, sicuramente onesto. Non si fa retribuire per quel lavoro, lo fa e basta. Così, la malattia del glicine viene affrontata la prima volta sulle scale, fra il primo e il secondo piano, perché assemblee condominiali non se ne sono mai fatte.
È un glicine storico, più di duecento anni di vita, che orna il palazzo settecentesco all’incrocio fra via Cairoli e via Bassiche. Tre piani più una piccionaia, un enorme terrazzo al primo piano, un giardino d’inverno al secondo. Il glicine sovrasta, o meglio sovrastava, tutta l’area del terrazzo, una piazza d’armi di oltre centocinquanta metri quadrati, e la ricopriva con foglie e fiori che attiravano l’attenzione dei passanti al tempo della fioritura. Spesso qualcuno, all’angolo opposto dell’incrocio, lo rimirava o lo fotografava. Emanava un profumo che fluiva in alto, fino a quella che chiamano “la piccionaia”, dove abita Teresa, la più giovane del palazzo.
La donna che scriveva racconti

Il libro è finito, l’ho letto proprio tutto, fino all’ultima parola dell’ultima riga. Resto in silenzio, con la pagina ancora aperta, perché comincino a depositarsi le parole, per lasciarle scendere, come per una forma di rispetto o di nostalgia che già me ne fa sentire la mancanza. Poi mi alzo e gli cerco un posto, uno scaffale ideale, magari in seconda o terza fila, non importa. Ciò che conta è vicino a quali altri libri trovargli casa. Con chi è imparentata questa scrittrice? In questo caso non ho dubbi: dormirà vicina a Alice Munro e a Joyce Carol Oates.
Ma non è finita qui. Sento di voler scrivere di questo libro. Poche parole, qualche osservazione, magari scimmiottando il tono della Berlin di una che non c’entra con ciò che racconta, come se quel libro non la riguardasse affatto e dunque non riguardasse neppure me che ne sono stata ammaliata al punto da copiare una sua frase paro paro per inserirla in un mio racconto. Perché era perfetta, per onorarla forse.
Ma di lei, su secondorizzonte, ha già detto Simoni perché il libro non è nuovissimo, è uscito nel 2016. Dunque perché richiamare l’attenzione ancora su Lucia Berlin?
Continua a leggere La donna che scriveva raccontiGaleotto fu il libro…
Certo che no, a mio marito non l’ho detto che ogni notte m’incontro con lui e ci passo un paio d’ore. Credo sia una faccenda ben al di là del tollerabile, anche se le attenuanti non mi mancano.
La prima: dormo poco la notte. Non è propriamente insonnia la mia, è che a cena mangio troppo, poi m’addormento, cioè piombo nel sonno di botto, senza gradualità alcuna. È intorno alle due e mezza, tre del mattino al massimo, che lo stomaco mi richiama in vita; allora provo a mettermi seduta, comincio la lotta con la mia laboriosa digestione, nella speranza che il cibo prenda la strada giusta, finché mi arrendo: scendo in cucina a spremere un limone che sciolgo in acqua calda e mi siedo in poltrona.
È allora, quando il nero assorbe il respiro del mondo e le ore si fanno più lunghe, che lui si palesa. Qfwfq si chiama, che più che un nome pare una sigla, un acronimo, eppure è uno di spessore, uno che ha il suo fascino. E ci capisce, le cose le afferra al volo. Sarà per questo che parliamo volentieri per ore, in attesa dell’alba.
La notte scorsa gli ho posto una questione che mi rode da giorni: scrivere una recensione, non una qualunque, la recensione di un libro scritto da un amico. I problemi in questione sono tanti e molto, molto aggrovigliati, aggrovigliati e rischiosi.
In primo luogo avevo giurato di non scrivere più di amici e amiche. Certo, qui scriverei di un libro, non di lui in quanto lui, ma scrittori e libri sono pur sempre la stessa carne, lo stesso sangue. Magari le parole descrivono foglie, erba, alberi, ma lui, lo scrittore, è lì nella linfa, nella fotosintesi clorofilliana, lui è le sue parole scritte.
Scrivere di amici è un azzardo immane, un pericolo che ho corso per ben due volte provocando e riportando ferite. Con le parole non si è mai abbastanza cauti, soprattutto con quelle lievi nell’intenzione, ma magari non abbastanza attente; vanno soppesate, scrutate al dritto e al rovescio e poi rivalutate ancora e, alla fine, forse sarebbe comunque meglio tacerle, concedendosi a una “discrezione intelligente” – come scrive il mio amico – salvando così “la molteplicità di significati che solo ciò che non si traduce in parole può conservare”.
È pur vero che specchiarsi nelle parole dell’altro, scoprirsi in uno sguardo che non è il proprio è navigare in un mare periglioso.
Dunque, recensire l’ultimo libro di Simoni è un azzardo da evitare.
Eppure c’è quel bisogno, quell’attrazione fatale a dire che mi porta ancora sul quel bordo, sul margine del foglio. Dire quello che non ci sta nelle parole.
Vorrei essere in grado di dirlo con i gesti: finito quel libro, Simoni lo avrei abbracciato, l’avrei stretto a me, gli avrei riempito di baci i capelli bianchi, gli avrei fatto scricchiolare le ossa per dire con il corpo ciò che le parole non sanno esprimere. Ma non si fa. Non che fra noi possano esserci fraintendimenti, è che imbustato lui, imbustata io, non è proprio cosa. Da sempre, il nostro essere in presenza, è un “restare sulla soglia della propria anima – come scrive lui – come per tenere aperto uno spiraglio che le parole”, proferite, “finirebbero per ostruire”.
Allora mi resta solo la strada delle parole scritte. In fondo le preferisco anch’io, sono più profonde.
Parlo e Qfwqf intanto mi ascolta, mi guarda di traverso e sogghigna: e dove sta il problema? Scrivi questa recensione, metti in fila qualche parola, accenna pure a me che non mi dispiace e certo non fa male e via – dice sollevando il sopracciglio destro con quel fare sornione alla Humphrey Bogart.
Ma non capisci che parlare di Simoni, del Simoni della Collezione di storie, oltre che espormi a dire di un amico è anche parlare di Calvino? Devo scrivere di un amico che raccoglie il filo di un mio grande amore e ne continua le storie, ti rendi conto del rischio? Perché, in questo libro, Italo e Carlo non li distingui più, leggi Carlo che ha la voce di Italo e ti lasci condurre in avventure fantastiche e incredibili.
E poi scrivere una recensione richiede una conoscenza profonda dell’autore. E io che posso dire? che amo Calvino, sia nelle sue storie fantastiche, sia nei suoi esperimenti all’apparenza più costruiti? che di Simoni questo è uno dei libri che mi piace di più perché in questo c’è lui tutto, unghie comprese? Lo vedi che non so argomentare?
Certo una cosa del libro di Simoni l’ho capita: non devi ricordarti tutto di Calvino per goderti questo testo. Per esempio, del Visconte dimezzato io ricordavo poco, devo averlo letto alle medie, ma non è stato un problema, l’ho riscoperto nelle parole di Carlo e ha funzionato alla perfezione.
Qfwqf scuote la testa, non l’ho convinto affatto, la faccio troppo complicata per i suoi gusti.
Ci lasciamo così, un po’ risentiti l’uno con l’altra e finalmente mi strofino via l’insonnia dagli occhi e mi abbandono alle acque del sonno.
Il mattino non ricordo nulla. Sguscio fuori dal letto dove mio marito ancora sonnecchia, mi lavo la faccia, un caffè, indosso le scarpette da corsa e filo fuori. In cielo ancora un brandello di notte, un abbozzo di luna.
Dietro la nostra casa estiva comincia il bosco, non subito, prima mi tocca un chilometro e mezzo di corsa in salita, poi spiana, diciamo che poi si apre un falsopiano, più falso che piano, che corre nell’intrico dei rami quasi a disegnare un tunnel. I piedi percepiscono la pendenza del suolo e cominciano a pensare. La rugiada appesantisce le foglie, tolgo gli occhiali da sole perché correre con gli occhiali è un supplizio e la miopia va a oscurare il buio delle fronde, l’ombra che le frasche proiettano. Attraverso di corsa il bosco il mattino presto, dove il nero s’addensa e ghermisce i pensieri: ancora nessuno è passato, se non un cerbiatto, una volpe. O un cinghiale, e mi pungono gli aghi della paura, un fremito, un’esitazione fugace. È forse quello spavento che mi conduce nelle tenebre del bosco ogni mattina, lì dove non sono altro che carta assorbente.
Quello è il paesaggio cupo in cui Q, come ormai in confidenza lo chiamo, si sente a suo agio e ricompare. Mi monta in testa e riprende così il nostro chiacchierare senza costrutto.
Allora hai deciso per quella recensione? mi chiede con quel suo sorriso sardonico che un po’ mi disturba. A giorni ha “un modo di buttar lì le questioni che riesce ad irritarmi”,come direbbe Calvino. Chi si crederà di essere? Q, ridimensionati bello mio, sei una parola, solo una parola, al massimo il personaggio di un libro, anzi di due. Ecco che l’ho offeso: devo stare attenta con le parole, me l’ero ripromesso, non devo lasciarle sconfinare, le parole sono proiettili.
Sì, voglio scriverla la recensione, ma con leggerezza – rispondo alla fine – evitando la pesantezza, l’inerzia, l’opacità del mondo: qualità che s’attaccano subito alla scrittura, se non si trova il modo di sfuggirle. Si tratta piuttosto, come insegna il maestro, di farmi“sostenere dai venti e dalle nuvole, come fece Perseo, evitare una visione diretta, catturare l’immagine tramite uno specchio”.
Eccolo che s’infervora, il mio amico Q, con un sorriso che gli riempie gli occhi, s’inorgoglisce, gongola tutto: ho letto il suo autore, la mia passione affonda le radici nelle sue parole. E si pavoneggia, quasi le avesse composte lui quelle frasi, invece d’esserne stato creato. E poi un guizzo, attacca a dire a precipizio, come se le parole gli si spintonassero in bocca, e un’esclamazione gioiosa: sarò io il tuo specchio – mi urla festante – mi offro, mi concedo perché sei tu, per le lunghe ore che passiamo insieme la notte, mi sacrifico diciamo. Invece di scrivere una recensione come fanno gli scrittori, prendi il filo di una delle storie del libro di Simoni e vai avanti, lasciati andare al “vapore gelatinoso e umidiccio”, fatti “nebbia,” fatti “bambagia”. Perché nel libro del tuo amico c’è quella lievità che, senza rumore, va nel profondo. E conta su di me perché io li conosco bene entrambi, quei due.
È riuscito a cogliermi di sorpresa Qfwqf, mi ha messa all’angolo. Vuole forse che racconti di lui, delle sue imprese, vanesio com’è vuole essere rimesso al centro?
Quasi mi leggesse nella mente nega l’intenzione egocentrica, vuole che scriva di Cosimo, di come Carlo – Simoni – l’ha fatto planare, attutito da un “improvviso addensarsi d’uno strato di foschia” sulla tolda della Seaflower. “Cosimo cadeva, tanto leggero da non scendere a perpendicolo ma lievemente oscillando al vento, come una foglia d’autunno… e sognava intanto uno di quei sogni che sembrano dilatare un breve lasso di tempo in un’intera storia.”
Che idea concedere una seconda chance al vecchietto che, stremato dalla fatica di restare appeso all’ancora della mongolfiera, s’era lasciato cadere come volando,fino a planare “sulla cima d’un albero privo di fronde”, per poi precipitare dall’albero di trinchetto, in compagnia di una rondine. “Poi di colpo, il buio.”
Ma sopravvive il Barone rampante e si apre a una nuova avventura in cui comprende che “la distanza necessaria non era forse quella che l’altezza degli alberi gli aveva consentito, ma quest’altra, che ponendolo al livello stesso dei suoi simili, o addirittura al di sotto di quello, il viaggio sulla nave gli imponeva.”
Mi corrisponde questa frase, dice anche di me, mi risuona dentro come l’eco di qualcosa che credevo di aver scoperto da sola.
Q ne è orgoglioso, si pavoneggia, lui c’entra, sia con Calvino che con Simoni, è lui che gliel’ha servita su un piatto d’argento la storia del tempo, del tempo zero. E chi altro se no? Chi più di lui sa del tempo? Lui, Q, la vede come Simoni: “quando gli astrofici ci sono venuti a dire che il tempo non esiste: credevano di dare una notizia sconvolgente. Invece è passata in coda nei telegiornali… non ha fatto né freddo né caldo a nessuno, perché l’avevano già fatto fuori prima iltempo… I giovani dicevano che gli avevano rubato il futuro, e dunque non ci credevano… i vecchi, che di passato ne avevano… si erano convinti che potevano ridiventare giovani… mentre i cosiddetti adulti… erano troppo presi in quel che facevano per pensare al passato e al futuro”.
No, neanche Q ci crede alla faccenda che il tempo non esiste, dicono, gli astrofisici, che “nelle loro equazioni non lo trovano… Ma morire si continua a morire”,anche se si sono perse le parole della morte e anche le parole sue “parenti strette: caducità, malinconia, nostalgia”.
“Potrei dunque definire come tempo e non come spazio quel vuoto che mi è parso di riconoscere nell’attraversarlo” – recita così, a freddo, Q citando il suo grande autore. E sono le parole di Calvino che mi riportano ai mesi da poco trascorsi, a quel silenzio nelle strade, allo spazio vuoto solo all’apparenza, a tutte quelle bracciate di tempo a non finire, da sezionare, da riempire, giorno dopo giorno, fino a imparare a starci solo dentro, fermi, in silenzio, dismettendoantichi vizi, come scrive Simoni, nella “consapevolezza di come siamo usi trascinare con noi i desideri che ci avevano animato in altre stagioni della vita,” e di come “ne restiamo prigionieri anche quando essi non sono più vitali per noi, ma non per questo cessano di renderci incapaci di vedere quelli nuovi che l’avanzare degli anni ci potrebbe donare.”
Sì, mi piace il tempo che passo con Qfwqf, si parla di tutto e di niente in silenzio, io corro nel bosco e lui mi gira nella testa, ride, suggerisce, disserta, mi prende in giro.
Potremmo farlo il salto, che ne dici? – mi butta lì caustico. E di quale salto starà parlando? mi chiedo. Ma sì dunque, non fare l’ingenua: passare da amici ad amanti.
Sbianco all’idea, ma come gli sarà venuta in mente questa panzana? mi chiedo, intanto che la mia autostima cresce di una tacca o due. Impossibile caro mio – replico – o tu ti fai carne, e uno solo da verbo s’è fatto carne prima di te, o io mi faccio parola.
La seconda che hai detto, è più probabile. Lasciati andare, concediti alle parole e poi vedrai che numeri io e te, che radici quadrate. Te le faccio vedere io le stelle, come scrive il maestro: “sulla mappa concava del buio, in quel corridoio di cielo notturno, la luna di fronte, e quello smoccolamento… allungato sulla terra, arricciatosi in punta come un baffo…”, ci attacchiamo a quelle “stalattiti, a quella sospensione di dense gocce d’una pappa cremosa… fino a raggiungere le propaggini lunari” e poi, bimba mia, non ci becca più nessuno – conclude con un sorriso umido, un po’ animale.
Certo dovrai parlare bene del libro, non quello di Calvino, non serve, quello di Simoni: libro galeotto che ci ha fatti rincontrare.
Rido all’idea di un amante, non se ne parla di certo.
Ma farmi parole, quello sì che m’intriga, come scrive Calvino: “ripetere quello strappo di me stesso, quel prender su e uscire, prender su me stesso e uscire da me stesso, delirio di quel fare impossibile che porta a dire, di quel dire impossibile che porta a dire se stesso…”.
Tenere aperto il tempo con le parole, una via d’uscita dallo sgomento di vivere.
Ecco, ora io come Italo “sentivo d’esser giunt(a) al punto in cui tutto convergeva”.
Dovevo continuare a provarci: superare quell’attimo di stridore, l’impatto della parola sulla pagina ed essere parole.
Un fulmine, un’illuminazione: mi tornano in mente le parole di Carlo, devo ritrovarle.
Sono quasi a casa, ora la luce è così intensa che i contorni degli alberi sembrano vibrare e i pensieri mi si accecano.
Ho corso una decina di chilometri con il peso di Qfwqf sulla testa, ma non me ne sono resa conto, al punto da dubitare d’aver davvero corso o d’essermelo solo sognato. Eppure sono sudata fradicia, il volto rosso e tumefatto, la testa leggera e libera. Pronta. Ora una doccia, un caffè e riapro frenetica Collezione di storie, là dove parla della scrittura in relazione alla vita, al tempo che passa. Lo so bene che ne ha scritto, l’ho sottolineato di sicuro, o c’ho messo una freccia a margine, come faccio per le cose importanti da tenere sempre presenti. E infatti eccole le parole di Simoni: “scrivere lasciandosi guidare dal proprio desiderio, serenamente fidenti nel proprio estro… una scrittura capace di aderire alla vita, capace di esserlo essa stessa vita invece di costituirne l’alternativa, o tutt’al più un calco sempre sfasato… perché senza la giusta distanza non si scrive, e scrivere – nel modo detto: senza pregiudizi, avversioni ecc. – , è del resto il modo migliore di guardar la terra come si stesse sugli alberi. E allora conviene vivere come si scrivesse sempre anche quando non si ha la penna in mano. Diversamente, quando poi la si prende, non si ha la distanza necessaria per farlo. E invece i moti dell’animo, le rughe che in esso l’esistenza incide, le cicatrici che vi lascia chiedono altro: non l’argomentare, ma il narrare. Solo il racconto può rendere conto di come la vita si fa vivere: senza ucciderne il concreto accadere, senza far svaporare il sapore fragile e ineguagliabile dell’esperienza”.
Erano queste le parole che cercavo. Ora tutto quadra: rispondere alla chiamata delle parole, tenere fede all’inviolabile patto fra vita e parole.
Oggi a pranzo mangerò poco, non ho mai tanta fame a metà giornata. Ma a cena, come al solito, m’ingozzerò. Poi alle due e mezza, quando il cielo si riempirà di stelle, mi dovrò alzare, spremere un limone e riprendere le chiacchiere con Q. Chissà questa notte che storia c’inventeremo? Perché, come scrive Calvino: “la verità è dalla parte della fantasia” e, nel regno dell’immaginazione, si è giovani tardi. Però, forse, glielo dovrei confidare, a Simoni, che ho una storia con un suo amico.
Share the screen
ovvero
Istruzioni su come sentirsi un pezzo di merda
ovvero
Della rabbia
▸ dai giorni del coronavirus
Share the screen, mamma, lo trovi sotto, clicca su share the screen.
Ok share the screen, un attimo che lo cerco, ragazze.
Dunque, share the screen, share the screen, dove sei? Calma, calma e sangue freddo, sono solo due parole, due parole semplici, semplici.
Cerco con cura, con determinazione, con speranza. E intanto il tempo passa.
Dai mamma che l’inglese lo sai bene: share the screen.
Ok ho capito, datemi un secondo, l’ho trovato anche l’altro ieri, vedrete che lo troverò anche oggi.
Dove sei share the screen? Fatti vedere, dai, fatti vedere che il collegamento dura solo quaranta minuti e se ce ne metto venti ad avviarlo le ragazze se la prendono.
Ma share the screen non ne vuole sapere di farsi trovare. Io comincio a sudare, ho fretta, il tempo è poco e devo farcela. Non posso fare la figura della mentecatta con le mie figlie. Intanto sento che le ragazze chiacchierano, in attesa del mio ritrovamento, perché loro lo schermo lo hanno già condiviso da tempo. Niente, buio fitto nella mia testa e un imponente, incontenibile senso di sconfitta. Rabbia, rabbia purissima.
Mamma, allora?
Non c’è verso ragazze – rispondo vergognandomi come un cane – share the screen non c’è più sul mio computer.
Ma dai mamma, non fare la deficiente, c’è di sicuro, devi solo trovarlo. Sotto, la banda nera sotto.
Io ci riprovo con ostinazione mista a disperazione, ma neanche la banda nera di merda si palesa.
Computer di merda, internet di merda, share the screen di merda.
A forza di smoccolare trovo il maledetto share the screen e, mentre ci clicco sopra, mi metto a piangere. A piangere? Sì, a piangere.
Purtroppo, come tutti sanno, share significa condividere, e screen significa schermo.
E’ così che le mie figlie mi vedono sul loro schermo mentre piango.
Mamma ma perché piangi, cosa è successo?
Niente, è che non riuscivo a trovarlo, a condividere lo screen, facevo una fatica del diavolo, mi sono sentita cretina, insufficiente, vecchia e questo mi ha fatto piangere.
Ridono, ridono a crepapelle le ragazze all’idea che si possa piangere perché si fatica a utilizzare un computer. Eppure le lacrime continuano a fluirmi copiose sul viso e a rendersi evidenti nello screen di merda fino in Francia. Sono imbarazzata, colta nella mia fragilità che loro faticano a comprendere.
Mamma, per l’amor di Dio, le priorità. Non si piange per un motivo così.
Ci vediamo domani ragazze, domani sono sicura che me la caverò meglio. Mi eserciterò, oggi fate ginnastica voi due insieme, io sono a pezzi.
Insistono per tenermi collegata, ma io so che è meglio sottrarsi. Continuo con la lagna delle lacrime senza senso ma di grande significato.
Piango la mia insipienza, la barriera che si alza nella mia mente di fronte a uno schermo, il mio cervello che arranca privo di quel talento così indispensabile oggi. Non ce li ho quei numeri, non ce l’ho un’intelligenza logico-matematica, non ce l’ho mai avuta. Ho una testa analitica, intuitiva, un pensiero che si svolge a balzi, non a step. Non ci riesco a restare nel sistema binario, non perché io lo rifiuti, perché è altro da me.
Ma, purtroppo, è quest’altro che serve oggi, un altro di cui io sono assolutamente priva.
Spesso mi aiuta mio marito che ha la pazienza di Giobbe, anche se pure lui a giorni si scoraggia.
Odio essere aiutata da un uomo, è stupido ma è più forte di me, preferirei che mi aiutasse una donna. Retaggio del femminismo o di quando mio padre diceva a mia madre: parlerai quando guadagnerai quanto me. Lei, mia madre, mi ha sempre spronata a bastare a me stessa. E ora, nel mondo di oggi, non mi basto più, non per quel che serve. Che cosa ne direbbe la mamma se lo sapesse?
E se mio marito mi lasciasse per una più giovane, come la metterei con il PC? Certo non sarebbe il problema maggiore, ma comunque un problema. E di smorfiose disponibili che magari portano pure la quarta c’è pieno il mondo. E ho anche preso qualche chilo e, senza tinta, ho i capelli tricolori.
Dovrei vergognarmi di questi pensieri, mio marito è sempre disponibile, gentile con me. E io m’incazzo, più lui è gentile più io, dentro di me e solo dentro per fortuna, m’incazzo come una bestia.
Una rabbia, Dio mio, una rabbia…
Lui, il perfettino: non perde un colpo, impara nuovi programmi senza fatica, usa il MAC come fosse una pagina bianca, ricorda tutto, film, musiche, libri, ragiona a raffica.
Io annaspo, il computer di merda lo odio e lo prenderei volentieri a martellate, non ricordo niente, non riconosco più neanche la nona di Beethoven pur avendo masticato musica classica dall’infanzia, mi accorgo di aver già visto un film non prima del secondo tempo, se qualcuno mi chiedesse quale è stato l’ultimo libro che ho letto impiegherei mezz’ora a ricordarmelo.
Perdita della memoria recente: sintomo chiaro.
Sarebbe saggio darci un taglio, arrendersi e giocare il proprio gioco, usare le carte che si hanno in mano per non continuare a perdere. Abbandonare definitivamente quel computer di merda.
Ma così si perde del tutto, così si è fuori.
Ora il mondo gira a una velocità diversa, frenetica, ci si deve adeguare.
Fra non molti anni si acquisterà solo on line. Non ci saranno più i negozi di abiti dove una commessa pietosa ti conferma, sempre e comunque, che ti sta bene, che quella gonna la porti divinamente. Balle che scaldano il cuore.
E se non saprò comperare con il computer? Dovrò chiedere ancora a mio marito, se non sarà fuggito con la smorfiosa di trent’anni che porta la quarta, se ancora sopporterà il mio perenne restare indietro su un sentiero per me troppo accidentato.
E se non l’avessi avuto questo computer di merda in questi mesi di esilio, come le avrei viste le mie ragazze? Come avrei tenute vive le amicizie? E del “Cerchio della scrittura”, del mio amato Cerchio, delle amiche con cui condivido parole che ne sarebbe stato?
Tutto vero, tutto sensato però la rabbia non passa. Forse non rabbia per la strada che ha imboccato il mondo, e chi sono io per giudicare? Rabbia per me, per la fatica inenarrabile che mi costa imparare questa implacabile astrusa logica di merda.
Rabbia per non essere all’altezza, l’atavico vizio di dover essere sempre la più brava?
No, non la migliore, con il computer di merda non c’è pericolo, ma essere almeno sufficiente…
Rabbia contro la faccenda dell’invecchiare. Categoria a rischio io? Io che ho sempre tirato fuori gli altri dai rischi e dai guai?
E invece sì, invecchio e il mio cervello, ben prima delle gambe, si sbrindella, si smaglia come un collant, s’intorpidisce e tutte le cose che so fare sono ormai moneta fuori corso.
Non rimpiango la bellezza, se mai ce l’ho avuta, lo noto che nessuno sguardo si posa una seconda volta su di me per strada. Avevo messo in contro la trasparenza del corpo, è l’arrancare della testa che mi mette in ginocchio, il terrore di svanire, dileguarmi, indementire addirittura. Succede a tanti, perché non a me?
Nella casa di riposo dove alloggia mia madre incontro spesso un ex-collega di poco più vecchio di me, un rianimatore pediatrico che s’è fatto la diagnosi da sé. Ora è completamente assente, mi sorride, mi stringe la mano ma non mi riconosce.
Mi specchio in lui, so che non dovrei farlo, ma mi vedo in quello sguardo perso, mi ci immergo in anticipo.
Sarebbe ora di smetterla con la rabbia. Dovrei imparare a convertirla in altro, a usarla come forza propulsiva per sa Dio cosa.
Ma per ora la rabbia, la mia rabbia è un computer di merda che, immancabilmente, mi mette nell’angolo.
Desiderio di libertà
▸ dai giorni del coronavirus
– E quando la porta di questa casa si spalancherà di colpo, che ne sarà di me? – Al pensiero, un lieve moto di inquietudine sembrò attraversarle il viso. No, non era la paura del virus, ma qualcosa di più oscuro, impenetrabile.
Più che paura, un timore, un’indecisione nel passo mista a nostalgia.
– Impossibile provare nostalgia per una reclusione – si disse. Eppure quel sentire impreciso era proprio impastato con una sorta di rimpianto.
Forse anche il carcerato, al momento dell’apertura della cella tentenna, preda di un senso di privazione dal sapore dolce amaro, di nostalgia per un tempo pur detestato ma che, in qualche modo, già comincia a mancare.
Forse ogni conclusione di una fase è anche una perdita segnata da questo retrogusto.
O forse era lei che non sapeva più destreggiarsi nei sentimenti, tenerli ben distinti l’uno dall’altro. Ora li avvertiva solo in mescolanza, deglutiva miscele informi che faticavano a parlarle con chiarezza.
Cercava di farsi strada in quella poltiglia scrivendo, ma anche la parola era cauta, brancolante e pure un poco allarmata. Lasciare la strada alle parole comunque, affidare a loro la rotta.
Rintracciare un senso in quella tristezza acquosa eppure nel contempo felice, era come cercare il senso dell’esistere: un’impresa impossibile, persa in partenza. Bisognava solo accettarla, osservarla con attenzione e chiedere allo scrivere di limitarsi a de-scrivere, a dipingere i contorni del paesaggio.
Aveva creduto, all’inizio di quel confinamento, che avrebbe faticato molto a convivere giorno dopo giorno con i muri, il soffitto e il pavimento. Che avrebbe agognato orizzonti ampi, vallate contemplate da cime, spazi senza limiti. E così era stato al principio: i muri s’erano piegati, il pavimento obliquato e il soffitto s’era schiacciato, pesante. Ma per poco.
Poi, realizzato che più si puntano i piedi e meno la realtà risulta tollerabile, si era adattata alla lentezza del tempo come a una terapia prescritta, sostenuta dal senso civico.
Più avanti, il panorama era mutato di nuovo: le pareti sostituite da alberi assonnati, il legno del pavimento sciolto in torrente limpido e su, invece del soffitto, cieli infiniti.
Cosa avesse innescato quella trasformazione non è dato sapere. Mutazioni impercettibili, spostamenti infinitesimali, dettagli: la smorfia di un gatto, l’arrivo delle rondini, la vista di uno straccio sbattuto alla finestra. Le pareva di scoprire di ogni cosa l’asse generatore, l’ombra intima. Ogni minuzia la portava ad avere coscienza del tutto, come udisse il respiro del mondo.
Si fa l’abitudine a tutto, verrebbe da pensare. Ma l’abitudine non dice abbastanza. Non era semplice adattamento, era uno stato confortevole di pace straniante, pur nella preoccupazione per il mondo che continuava ad esserle caro, anche di più, ma in modo diverso.
Lo scrutava dalla finestra perennemente aperta con apprensione, ma anche con fiducia, con calma, con speranza. Non speranza in un cambiamento di rotta al vertice: sarebbe stato ingenuo confidare nella politica. Impossibile alla sua età affidare ad un potere caricatura di sé stesso, a un comando privo di autorevolezza e gonfio di narcisismo il mandato per la trasformazione. Ma forse nelle persone quest’esilio qualcosa avrebbe mosso, forse non l’avrebbero archiviato senza domande. Forse.
A lei di sicuro una sommaria liquidazione di quei giorni sarebbe stata preclusa, proprio per via di quello stare rinchiusa, di quello stare sola che aveva lasciato traccia.
Era stata scrupolosa, ligia: una volta digerita la pillola amara dell’appartenenza ad una categoria a rischio, operazione non indolore, non era uscita quasi più.
Impaziente e inquieta per natura, stranamente aveva cominciato ad apprezzare quello stare dentro casa, anzi dentro una stanza. Prediligeva stare sola in una stanza, sempre quella, come presa dal desiderio di limitare ulteriormente lo spazio intorno. Poi la stanza era diventata un angolino, una tana, poi anche quello si era ristretto: stava dentro il suo corpo e le bastava. Spaziava fra gli organi, i vasi, i tessuti. Quando voleva allungarsi scivolava negli apparati, affidando ai tegumenti la relazione fra il dentro e il fuori.
Per casa, il corpo. Un corpo trasparente, in pace come di norma riusciva a stare solo correndo o arrampicando sui picchi.
Guardinga, si aggirava nei meandri di quella dimora che, pur conosciuta da sempre, scopriva in quegli istanti di vuoto, di silenzio, di vita sospesa ma ricca, piena.
Era fitta di sogni quella casa, sognava ogni notte, anche più di uno sogno per notte, sogni a sciame. Alcuni le restavano in mente e le portavano presunti messaggi, altri scivolavano via all’alba lasciando una scia, un’impressione, un impalpabile star bene che durava nelle ore. S’era come diluito il confine fra veglia e sonno, fra pensiero cosciente e vita onirica.
E ora che sembrava intravedersi la riva, lei si sentiva inspiegabilmente richiamata indietro, verso quei giorni uguali solo all’apparenza, verso quelle notti colme fino all’orlo.
Avrebbe continuato a sentirsi a casa in quel corpo, in quella pace anche dopo, quando le porte si sarebbero aperte o si sarebbe persa nella seduzione del fuori?
Avrebbe conservato ciò che aveva guadagnato?
No, guadagnare non è il verbo corretto: restituire è perfetto. Qualcosa in questi mesi le era stato restituito. Milligrammi di eterno, forse?
Non sapeva definire in cosa consistesse quella restituzione, ma di quel guadagno era certa, così come di quella strana, serena malinconia che le velava lo sguardo al pensiero della fine dell’esilio. Che non desiderasse più la libertà?
Ma quando mai? Certo che ancora aspirava ai passi lunghi, ai luoghi aperti, ai viaggi. E’ vero che, come diceva quel tale, il miglior viaggio è quello dentro se stessi, ma lei aveva imparato molto di sé viaggiando lontano. Anzi, era stato proprio in quei luoghi così stranianti che, lasciandosi attraversare da altre tradizioni, altre parole, l’altro l’aveva avvicinata a sé.
Eppure, quell’esperienza di solitudine, di essere corpo e nient’altro, era diversa, per ora indecifrabile ma profonda.
Che si stesse definendo in lei un desiderio di eremitaggio? – si chiese, come a canzonare se stessa.
Mai buttarsi avanti, stare all’oggi, a quel guadagno muto che neppure la parola sapeva scongelare. Affidarsi a questo sentimento taciturno e aspettare, sperando che non svanisca, che non si lasci appiattire a dimensioni minuscole e poi sostituire, cancellare.
Tenerlo appeso con un filo dorato sul retro del pensiero. E poi si vedrà.
Voci
▸ dai giorni del coronavirus
No, non ci riesco, mi arrendo. Ci ho provato con tutte le mie forze, ma restare chiusa qui è troppo, per una come me. Si dovrebbe tener conto delle caratteristiche delle persone: quelle che hanno il gene dello stare in solitudine, quelle che gli manca.
Sì, è casa mia, ma sono pur sempre rinchiusa: non posso uscire, fare due passi, prendere una boccata d’aria, guardare in faccia qualcuno.
Tengo spalancate le finestre tutto il giorno: c’è un sole che chiama fuori. La sento la sua voce morbida, suadente, a giorni imperiosa: che ci fai in casa? – mi chiede – e poi mi sfotte: fai i fioretti per la Quaresima? Ma esci fuori che è meglio.
No, non sono pazza. Perché voi le voci non le sentite?
Ok, se le sento solo io è perché c’ho l’orecchio fino, o siete voi che non fate attenzione, che neanche ci pensate agli astri, alle bestie, alle piante e ai loro messaggi. Bisogna provare ad ascoltare. Ma, non così come fanno molti: distratti, magari mentre scrivono un messaggio sul telefonino; bisogna metterci la testa e anche le orecchie. E il tempo, ci vuole anche quello, anzi è l’ingrediente principale, insieme alla pazienza: tempo e pazienza.
Certe mattine mi siedo vicino alla finestra, e sto lì ferma come una statua, vigile come un animale in agguato, pronta a scorgere il minimo movimento, un velo di brezza, una luce di poco più intensa, o l’ombra di una nube in cielo.
È in quei momenti che gli astri mi parlano.
Il sole è quello che fa la voce più grossa, uno smargiasso, un fanfarone. Si sveglia, con un colpo d’anca caccia la luna e fa alba. Chi ci si applica, ode il suo urlo poderoso di vittoria che scuote l’eliosfera, accompagnato da un fragore, come di un enorme pugno battuto sul tavolo, a confermare che l’ha spuntata sul nero della notte. E il cielo, per il fracasso di tanta esultanza, pare un mare in tempesta: orbite che da ellittiche si comprimono in sferiche, pianeti allo sbando che collidono….
Lui, adagiato al suo posto di comando, scuote i raggi solo un poco, sbadiglia e ride al contempo, ricolmo di una soddisfazione che è più di una gioia, è un’effervescenza, un’incontenibile conferma di sé: lui è il capo, lui è l’origine, lui fa girare tutta la baracca.
Sì, anche a me fa un po’ ridere: un vero narciso. Ma è proprio bello, non c’è che dire. Io lo rimiro quando posso e glielo confermo che è un adone.
Si dice: bello come il sole, se non sbaglio.
Lui si schermisce e si commuove: una lacrima d’idrogeno gli scivola rapida lungo il guancione di sinistra e lui la lascia scorrere senza provarne vergogna.
Non ve ne siete mai accorti? Impossibile. E la luna, neanche quella vi parla mai?
Lei ha una vocina sottile, spesso malinconica, come provasse nostalgia per qualcosa o per qualcuno. Chissà. Certe notti intona canzoni tristi, si smagrisce e si cancella il viso per ridursi a una falce piccina. Forse è timidezza, o magari pensa di non essere bella abbastanza. Sarà per questo che le piace il buio: ci si adagia come su un prato e pare riposare. Invece pensa, rimugina, rimpiange, si strugge. Per amore, è ovvio. E per che altro? Ditemi voi: c’è qualcosa che faccia soffrire o gioire più dell’amore?
Ed è la luna, che ne regola i flussi, lo distribuisce a tutti, non lo fa mancare a nessuno. Ma c’è qualcuno che lo perde per strada, altri che neanche scorgono il dono. Poi ci sono quelli che ci sputano sopra perché hanno ben altro da fare, quelli che lo usano a capocchia e poi piangono a catinelle, quelli che lo cercano lontano quando ce l’hanno sotto il naso, quelli che non ne hanno mai abbastanza perché lo sprecano.
Pochi sanno di averlo e ringraziano.
Ma, cosa dicevo? Ah, sì, le voci, che fatica. A giorni ne sento così tante che mi confondo, mi pesa la testa e mi prendo paura. Al tramonto quando il sole s’è già addormentato e la luna non si è ancora svegliata, mi si scatena dentro uno spavento che mi toglie il fiato. La casa si fa prigione, i muri mi si chiudono addosso. Non è un’immagine di poesia, si muovono proprio le pareti, si inclinano che mi pare di toccarle. E pure il pavimento si obliqua e s’inumidisce di un liquido vischioso come miele, come resina appiccicosa. Devo reggermi ai mobili per non cadere, ma le gambe mi tremano. Allora mi siedo in poltrona. No, a letto non va bene perché anche il soffitto s’abbassa e mi preme come in una bara. Sudo, il cuore mi esce dal petto, allungo le braccia per allontanare i muri e, quando m’incombono addosso, picchio con i pugni, respiro a fatica e devo scappare.
Ma ora di casa non posso uscire più.
Brutta sensazione, orribile, da morirne.
Panico si chiama, mi ha detto lo specialista che mi ha prescritto le pasticche. Prima non le prendevo tutti i giorni, non volevo sentirmi malata. Dopo il ricovero, invece, mi sono persuasa e mi curo, perché non le voglio sentire tutte insieme le voci, che non si capisce quali sono buone e quali cattive e mi fanno un fracasso in testa da delirio.
Con le pillole le voci cattive stanno zitte, parlano solo quelle buone. Ma quella non è mica la malattia, quello è il mio sesto senso. Non che io sia speciale, è che mi sono allenata al silenzio e ci percepisco dentro frequenze precluse agli umani.
Nelle sere fortunate l’ansia me la cura il gatto. È vecchio ormai, forse per quello è così saggio. Viviamo insieme da tanti anni e mi conosce come nessuno. Lui lo capisce quando sto male e si preoccupa. Con un’aria da niente comincia a girarmi intorno, mi si struscia sulle gambe, mi punta gli occhi gialli in faccia, mi salta in grembo e comincia la litania dei lamenti. Prima un miagolare incerto, quasi balbuziente, poco convinto, poi alza i toni e gorgheggia con gli acuti. Quando proprio non mi raddrizzo, si siede nel vano della scala a chiocciola, dove la voce fa eco, e ci dà dentro con il canto. Mi commuove, lo capisco che è in pena. Allora provo a calmarmi e lo prendo in braccio. Lo accarezzo piano, la testa, le orecchie, il dorso. Lui fa le fusa e il mio cuore rallenta.
È allora che iniziano i racconti. Io gli dico delle pareti e del soffitto, e del pavimento; lui, prima prova a convincermi che sono tutte fesserie nella mia testa, poi, quando afferra che non mi persuado, mi racconta delle storie.
Ieri sera per esempio, era il turno della volpe. Da non credere. Il gatto sostiene che per strada l’altra notte s’aggirasse una volpe. Una volpe in pieno centro, all’inizio non ci credevo proprio. Non viviamo mica in un quartiere di Londra. Lì si che può capitare, ma in Lombardia… E invece lui a insistere, a specificare particolari: era bella, un bel pelo fra il marrone e il grigio, non grossa, ma graziosa. Zampettava in via Cairoli sulla carreggiata, tranquilla. Macchine nessuna. La strada era sua. Annusava ogni angolo, forse in cerca di cibo, o magari per fare conoscenza con qualcuno. Non pareva spaventata, secondo il gatto. Così lui s’è fatto avanti, o così dice di aver fatto. S’è sporto dal balcone e l’ha chiamata, tanto al terzo piano la volpe mica si arrampica – ha pensato. E questo gli ha dato una baldanza più da tigre che da gatto. Le ha chiesto conto della sua presenza lì sull’asfalto. La volpe, a detta del micio, all’inizio pare si sia leccata i baffi, perché un gatto ben pasciuto se lo sarebbe pappato senza indugio. Ma c’erano i tre piani, o forse aveva già la pancia piena.
Allora s’è concessa di chiacchierare col felino domestico.
Pare gli abbia chiesto di noi, noi umani, di dove c’eravamo cacciati, che non le pareva vero di non trovarci in giro ad ammorbare l’aria. La mia tigre domestica le ha raccontato la storia del virus, del confinamento in casa, di scuole e fabbriche chiuse. La volpe lo ascoltava basita, incredula: che ci fosse ancora un poco di giustizia al mondo? Che il virus li avesse puniti quegli stolti che vivevano senza riflettere, senza rispettare, senza godersi nulla? – ha chiesto. E se la rideva sotto i baffi, pare addirittura che abbia improvvisato passi di danza per festeggiare il nostro castigo, per poi incamminarsi disinvolta verso il corso.
Il gatto s’è perfino convinto che avrebbe convocato anche gli altri: il lupo, il cinghiale, lo stambecco, il falco, il tasso. Magari si prenderanno la rivincita e occuperanno questo spazio urbano, alla faccia nostra. E pioverà, e l’acqua romperà l’asfalto, e nelle crepe crescerà l’erba, poi i fiori, poi le piante. Magari…
Il gatto ne è sicuro, e lui in quanto bestia, ci capisce.
Perché, non credete che gli animali capiscano? Ma se lo dimostrano anche i neurobiologi che gli animali e le piante hanno intelligenza, sensibilità, vita sociale, comprensione. Non si chiamerà pensiero, ma cosa importa? Le bestie sanno molto, ve lo posso garantire io che col mio gatto faccio discorsi da non credere. E apprendo un sacco da lui, specie quando lo osservo acciambellato sulla poltrona, sordo ai rumori, intoccabile. Invidio quella sua capacità di stare dentro di sé, di non lasciarsi distrarre, prendere per la coda, trascinare in cacce impossibili, inutili, dispersive.
Bel castigo c’è toccato però. E, in mezzo a tutte le voci che mi circolano in testa, manca l’unica che conta: quella di Dio. O sono io che non la sento?
Ora sono stanca morta, ma di prendere sonno non se ne parla. Questa sera non c’è neanche la luna per fare quattro chiacchiere. Quasi quasi un ansiolitico me lo butto giù, uno pesante, da due milligrammi e mezzo, e crepi l’avarizia: magari le pareti staranno diritte, il soffitto alto e il cuore calmo. Questa notte voglio proprio dormire di filato.
Una casa, anche piccola va bene
▸ dai giorni del coronavirus
Giù signora, stia giù che passa la Polizia.
E una mano l’afferra al polso e la strattona in basso, dietro la siepe.
Lei ubbidisce d’istinto, come farebbe una bimba a una madre. Potrebbe reagire, urlare, divincolarsi. Invece asseconda il movimento imposto, flette le ginocchia e s’acquatta nel verde.
Poi, finalmente, il lampo di un pensiero: ma perché mai si dovrebbe nascondere? Lei non ha fatto nulla di male, non ha infranto regole – si dice – e la sua mano, automaticamente, si muove a controllarsi il viso: la mascherina è al suo posto.
L’altra mano, quella estranea, ancora la stringe un poco: è sporca e non più giovane.
No, non per lei, per me signora, che se mi trovano è un disastro – sibila piano quell’ombra di donna accovacciata dietro i rami. A lei viene paura, magari è una ladra, o un’assassina. Certo, niente di buono, altrimenti perché sottrarsi? Ma lo sguardo della donna non pare cattivo: spaventato sì, forse terrorizzato.
Solo gli occhi si scorgono, la metà inferiore del viso è avvolta in un panno ridotto a straccio, sgualcito, sfilacciato agli orli, giallastro.
È vestita malamente, una giacca a vento sporca e troppo grande, troppo pesante per aprile, un foulard in testa di quelli da poco, scarpe infangate. Porta con sé due borse di plastica. Gliele mostra quasi orgogliosa: il mio guardaroba – esclama – l’armadio non ce l’ho più. Lei osserva il bagaglio attentamente: sporge appena da una buca poco profonda, scavata ai piedi della siepe. Una siepe di bosso, posta ai margini del parco di via Dei Mille, niente di che. Accanto, un telo di plastica e una coperta sdrucita.
Non parla male l’italiano, anche se le è rimasto l’accento dell’est, quel tono rigido, quasi marziale che ricorda il gelo e la neve, l’asprezza del clima e delle privazioni.
Non mi guardi così signora, non ho sempre vissuto qui. Prima lavoravo in una bella casa, curavo un’anziana, la lavavo, la vestivo, cucinavo, le leggevo il giornale. Poi è venuto il virus e mi hanno cacciata. Tornare a casa non si poteva, gli aeroporti erano bloccati, poi in Moldavia che figura ci facevo a presentarmi così. Qualche notte ho dormito in una pensione, ma poi hanno chiuso anche quella. Per una settimana mi ha ospitato un’amica finché si è messa con uno che non voleva gente fra i piedi. O magari era lei che credeva che glielo rubavo quell’uomo, che non l’avrei mai voluto. Un beone come pochi, sempre a metterti le mani addosso, a dire le brutte parole. Io non sono mica abituata così, mio marito è una brava persona, pulita, un lavoratore, uno per bene. Invece quello là …. Allora sono andata via, che scelta avevo, e mi sono sistemata qui vicino al parco. Quando non piove, non ci sto neanche male, mi sono abituata. Di notte, sotto la coperta, tengo su il giaccone, la mattina me lo cavo. Sì, qualche brutto incontro l’ho pure rischiato, ma io sono svelta, quando l’aria si fa cattiva me la filo e dormo sotto un ponte, là più avanti. Mi spiace per la pulizia, io che ci tengo tanto, guardi come sono combinata adesso. E poi mi sono fatta magra, mangio niente, quello che trovo nei pochi cassonetti ancora aperti. La panettiera di Corso Garibaldi, che mi conosce da prima, mi allunga uno sfilatino di tanto in tanto. Così vado avanti.
Parla a precipizio, come se il silenzio le avesse pesato addosso per giorni, forse di più. E intanto si studia le mani. Raccoglie da terra un legnetto, la punta di un ramo e, con quello, prova a ripulirsi le unghie sporche, con gesto abile e preciso.
No, i servizi sociali non possono fare nulla. I dormitori sono già tutti pieni e poi ho paura di prendere quel virus cattivo. Meglio sola. Magari ce l’avessi una casa. Che dico, va bene anche una stanza, anche da dividere con un’altra. Una donna però, perché di grane ne ho avute abbastanza.
Sa, certe notti, quelle in cui passano poche ambulanze e riesco a dormire, una casa me la sogno: piccola va bene, c’è meno da pulire, però con tante finestre, magari anche un balconcino per metterci il basilico e il rosmarino. Poi, mi sveglio e benedico questa siepe, questo pezzo di verde che mi ospita e mi custodisce. Di questi tempi, sa, non c’è da pretendere.
Lei l’ha ascoltata in silenzio, la faccia scomposta di una che non sa bene che espressione indossare. Anche che cosa provare non le è chiaro. Ora che l’ha lasciata vuotare il sacco, prova l’intensa sensazione di conoscerla. Forse la voce, o lo sguardo. Non familiarità, ma qualcosa come il vago ricordo di un volto, un corpo.
Potrebbe aiutarla, fare qualcosa, in fondo ha una bella casa grande e vuota, ma c’è in lei una viltà che chiama riserbo che la frena, che le trattiene gesti e parole.
Auguri, in bocca al lupo – si sente dire, brandendo la tesserina per gettare la spazzatura. Sale in casa, si toglie i guanti di plastica e la mascherina, poi si lava a fondo mani e polsi. Infine, si prepara la cena: tagliatelle con il ragù.
Accende la radio, la televisione è troppo, le immagini le inchiodano la digestione. Consueti numeri vuoti di speranze: infetti, portatori sani, ricoverati, deceduti. S’è fatta l’abitudine ormai a quel linguaggio, ai termini medici, ai valori percentuali della statistica. Non fanno più effetto. I racconti, quelli sì che fanno effetto: anche se hanno la voce di uno solo, parlano di molti. E non le dimentichi le storie, le mastichi e le rimastichi di notte come fanno le mucche.
Deglutisce senza riuscire a dimenticare. Quella donna non l’abbandona, riempie la cucina di chiacchiere con la sua voce di ghiaccio.
Non è che tocca a me risolvere i problemi del mondo – si dice – io la mia parte l’ho fatta, ora basta, devo pensare anche a me. Ma quei bocconi non scendono proprio. Beve un sorso di vino rosso. Lei non è una che esagera: giusto un bicchiere a cena, e nemmeno sempre. Ma quella sera il rosso ci vuole, deve fare pulizia di quel disagio, di quel non sentirsi a posto anche se non ha fatto niente. Forse proprio perché non ha fatto niente. Guarda un film alla televisione, ma non riesce a seguirne la trama. Non ci sono più i bei film di una volta, ora se non s’ammazzano non fanno scena – commenta mentre si prepara per andare a letto. Dorme poco e male, il pensiero alla donna coricata sotto la siepe, sola, le riempie la testa. Come dormirà? Avrà paura? E se qualcuno l’aggredisse?Poi, finalmente, il sonno la vince. Sogna polizia, questura, rapine, bambini abbandonati. Si sveglia di colpo all’alba sudata, sfinita.
Ma è la badante degli Zucchetti! – realizza improvvisamente – l’ha riconosciuta dormendo, sognando. Certo, la incontrava spesso dal fruttivendolo, dal macellaio di Corso Garibaldi. È che quella sera aveva la bocca nascosta. Però quegli occhi chiari erano i suoi. Una donna discreta, gentile, bassina, un po’ su di peso, ma con un viso ben disegnato. Non avevano mai parlato molto, giusto un buongiorno o buonasera, ma le era sempre risultata simpatica, la trovava educata.
Si prepara un caffè, si lava e si veste in fretta e, senza averlo deciso, scende e si incammina verso via Dei Mille. La ospiterà lei quella donna, lo deve fare, non può abbandonarla. Il coraggio le monta dentro come una marea e, con passo determinato quasi corre verso la siepe, come se si trattasse di vita o di morte, come in preda a una febbre, a un rimorso. Si guarda intorno circospetta e poi, dritta verso la meta.
La siepe è quella, ne è sicura, ma della moldava neanche l’ombra. Si inginocchia per scrutare il terreno, individuare tracce, la sagoma di un corpo che s’è coricato, un fazzoletto dimenticato, magari un pettine o una forcina.
Non può essersi sbagliata, mica se l’è sognato quell’incontro.
Accarezza l’erba: è fredda, pulita. Non è rimasto nulla.
Stare al proprio posto
▸ dai giorni del coronavirus
Domenica 22 marzo 2020. Il tempo è cambiato: uno strato spesso di nuvole grigie schiaccia il cielo sui tetti delle case. Cielo cupo. La primavera pare arretrare verso l’inverno.
E che cosa importa? – le verrebbe da chiedersi – tanto uscire è impossibile, per cui pioggia o sole non dovrebbe fare differenza. E invece paradossalmente, per lei il tempo atmosferico ha acquisito peso, come se una giornata di pioggia portasse con sé un peggioramento dell’infezione, come se il grigiore fosse di cattivo auspicio. Agogna cieli tersi, luce a profusione, conferendo ai colori il compito di spazzare via, di alleviare, di rallentare le sue ruminazioni quotidiane.
Invece, anche se ieri il sole brillava, la percentuale degli infetti, come quella dei deceduti saliva, indifferente al bel tempo e alla temperatura mite.
E’ primavera, una primavera malsana, ma pur sempre primavera.
Come è strano: la Natura non bussa mai prima di entrare, eppure non è mai un’intrusa! scriveva Emily Dickinson in una sua lettera.
S’è annunciata nei giorni scorsi con un caldo prematuro, uomini e donne reclusi sui balconi a tirare respiri che fuori parevano più lunghi. Anche terrazzini minuscoli acquistano dignità quando i parchi, i giardini, perfino le strade sono interdette e concedono la seppur fugace illusione che questa sia una primavera come tante.
Al contrario, a lei pare che questa stagione lieviti a strappi, senza i fiori ai mercati, senza mercati, senza sguardi sulle gemme, sull’erba, sulla neve che si scioglie. E il cuore le si raggela.
Scruta la primavera dove può, alzando gli occhi verso lo scampolo di cielo che i palazzi le concedono, carica del peso di un’apprensione sorda. Cerca una briciola di azzurro, cerca di mantenere i piedi fissi a terra, a quello che c’è oggi, vietandosi proiezioni, imponendosi di non attribuire allo scuro sopra di lei un qualsivoglia valore prognostico.
E’ domenica: strade vuote, qualche autobus vuoto pure lui, zero passanti.
Lei trascorre molto tempo alla finestra. Non tutto il giorno certo. Cerca di suddividere il silenzio in tappe, di mantenere una parvenza di ritmo nelle sue ore che le permetta di distinguere il mattino dal pomeriggio, di non invertire il salutare antico ritmo sonno-veglia. Pulisce casa, cucina, parla al telefono, manda mail, legge messaggi, legge libri, disegna. Succedanei di presenze.
Non scrive. Scrivere le pare troppo di questi tempi, quasi un sacrilegio. Eppure sarebbe bene scrivere, l’aiuterebbe a saturare le ore, la distoglierebbe dai pensieri neri. Ma, non scrive.
Ascolta le parole dei bollettini, dei decreti, degli amici, degli ex colleghi. Attribuisce maggior pudore all’ascolto. La scrittura che ama e pratica, che da sempre le tiene la testa fuor d’acqua, le pare impudica, irrispettosa ora. C’è qualcosa che manca, forse qualcosa di troppo, qualcosa che fa ostacolo al gesto dello scrivere, che gli toglie dignità. Si dovrebbe trovare il modo di spogliare la parola di ciò che la opprime.
Come parlasse a un oscuro ascoltatore dentro di sé, prova ad elencare ciò che lei sente come necessario alla scrittura, la sua naturalmente.
Dunque, intanto le serve una stanza, una stanza tutta per sé.
Quella ce l’ha: luminosa, ampia, dotata di scrivania con lampada, libri e musica. E’ la vecchia stanza delle sue figlie, convertita in studio. Nel ricordo ci sono anche loro, le sue ragazze, le fanno compagnia quando prende in mano la penna.
C’è poi anche l’altra stanza, quella interiore, quella che l’autorizza alla scrittura. Sono passati gli anni in cui Jane Austin nascondeva il manoscritto di Orgoglio e pregiudizio, quasi la scrittura fosse disdicevole per una donna. Scrive senza pretese, ma senza infingimenti, può farlo, la storia delle donne la sostiene e le dà spazio.
E’ lo spazio fuori dalle sue stanze che s’è ristretto: la città, la regione, il mondo si sono rimpiccioliti di colpo e incombono, spiazzano, tolgono il fiato anche dentro, dove si è sempre sentita al sicuro. Anche lì ora si respira a fatica, qualcosa preme da fuori e le si chiude addosso, come gettasse un sortilegio.
Serve il tempo.
Di tempo per scrivere ne ha fin troppo, tutto di fila. Forse è quel “troppo” l’ostacolo. Un tempo, l’urgenza di scrivere si faceva bastare anche i ritagli, le mezz’ore sottratte agli altri impegni sembravano doni preziosi all’impazienza di quelle parole che bussavano forte. Ora, in questo tempo spettrale che s’è come congelato, si è perso il passo, come impietriti, attoniti, smarriti. Fermi. Difficile esercizio quello dell’immobilità, incompatibile con un corpo tarlato dalla fretta, dal dimenarsi a casaccio nell’illusione che stia nel fare la salvezza.
Forse, come scrive un amico, per farlo fruttare questo tempo per la scrittura, serve un presente che abbia futuro, un presente abitato dagli altri, pur in solitudine, che li contempli, che li tenga vivi.
Apre a caso il libro di una delle sue storiche soccorritrici e legge, in Una stanza tutta per sé: …poiché la narrativa, che è opera di immaginazione, non viene fuori all’improvviso come un sassolino che cade per terra, come può succedere alla scienza; la narrativa è come una tela di ragno che se ne sta attaccata in maniera forse lievissima, ma pur sempre attaccata, alla vita, con tutti e quattro gli angoli. Spesso tale attaccamento è appena percettibile; le opere di Shakespeare, ad esempio, sembrano starsene appese con le loro sole forze. Ma quando la ragnatela viene tirata di sghimbescio, appesa a un bordo, strappata nel mezzo, allora ci ricordiamo che quelle ragnatele non sono tessute a mezz’aria da creature incorporee, ma sono opera di esseri umani che soffrono, e sono strettamente legate a fatti grossolanamente materiali come la salute, il denaro e le case in cui abitiamo.
Gli esseri umani, gli altri. Quanto le mancano, tutti quanti. Questo silenzio irreale, straniante, solcato solo dagli urli delle ambulanze, dal rumore delle pale degli elicotteri è la loro assenza, un’assenza insopportabile. Troppo vuoto, un vuoto che fatica anche solo a guardare.
Scrivere questo vuoto, questo silenzio è impossibile, eppure è l’unica cosa da scrivere. Ma come?
Mentre cerca di tradurre faticosamente in parole il filo disordinato dei suoi pensieri ha l’impressione di avvicinarsi al nocciolo del problema. Troppo spazio, troppo tempo, troppo silenzio qui. Mancanza di letti, di tempo, di silenzio altrove. Là dove dovrebbe essere, dove vorrebbe essere: vorrebbe tornare al lavoro. La chirurgia, il pronto soccorso, l’ospedale, i suoi luoghi per decenni, fibre del suo corpo che ha abbandonato per l’avanzare degli anni.
Basta con gli imperativi morali – sente dire da un amico che non ha capito niente. Perché è di desiderio che si tratta: essere in emergenza per fare la sua parte. Non per mostrare i muscoli o per eroismo, ma per passione, una passione che travalica il dovere, che ha a che fare con i propri tessuti, con il pulsare delle proprie arterie, con il cuore. Sente che dovrebbe, vorrebbe essere là e che non può esserci. E questo volere ma non potere la condanna a una lacerazione senza cura.
Prova a digerire il fatto che l’involucro provvisorio che è il suo corpo è andato oltre, che là non ci può più stare, che si ammalerebbe subito e sarebbe d’ingombro. Ne prende coscienza a fatica: si finisce sempre per nascondersele certe verità, per chiudere gli occhi sui propri confini.
Questo virus, fra le altre cose, obbliga anche a questo: prendere atto della propria vulnerabilità.
Ma la fragilità è un po’ come l’età, non ce la si sente mai addosso. Si finisce per considerarsi quarantenni per trent’anni. E si mettono da parte patologie anche gravi, non le si dimentica, le si accantona. E loro restano lì relegate in un angolo, pronte a risanguinare, a ricordarci che no, non si è più quelli di prima, che quegli eventi ci sono ben stati e hanno lasciato le loro impronte.
Così capita di inciampare negli acciacchi, nei divieti, nei bronchi stretti, nel fiato troppo corto e sa Dio che altro.
Non può più tornare al passato, alla prima linea, ma ha altre frontiere da tenere a bada – si ricorda. Una famiglia a dir poco impegnativa è un compito che si è assunta e che vuole portare fino in fondo. Raccogliere le storie dei suoi ex colleghi, ascoltarli, rincuorarli, dare voce alla loro fatica e al loro dolore.
Gli altri non sono solo i pazienti dell’emergenza. Deve stare a quello che c’è ora. Il suo lavoro ora è questo – si ripete. E prova a mettere da parte ogni altra velleità, a rimettersi all’oggi.
Stare al presente, a quello che la vita le mette davanti ora. Distogliere lo sguardo dal passato, lasciarlo andare.
Eppure fatica: forse quello che fa le sembra poco rispetto a quello che potrebbe fare, forse è solo nostalgia per quello che è stata e che non è più. Forse è la vita che stride quando mette in tavola tutte le sue carte. O è il mondo che è uscito dai cardini.
Forse è che anche quando si è malandati e oltre la scadenza, si continua comunque a sentirlo quel richiamo. Ed è proprio il corpo ad avvertirlo, ben prima della coscienza. E’ il corpo che scarta e scatta per rispondere: sì sono qui, pronta a fare la mia parte, a qualunque costo.
E’ quel a qualunque costo che resta inspiegabile ai più. Avventatezza, eccessiva baldanza, stupido eroismo. Semplice andare dove si è chiamati, dove c’è bisogno.
Non rispondere a quella chiamata è una delle cose più difficili e dolorose che possa capitare. E si resta lì impotenti, a lasciarsi attraversare da quella sofferenza incurabile, inevitabile.
Si sforza di stare dentro questo strappo nell’anima, senza impazienza, con attenzione, quasi con rispetto. Perché quando non si sa che forma dare a ciò che accade bisogna stare fermi, vigili, lasciare scorrere acqua e sangue, le spalle piegate, in attesa di intravedere la riva. Forse un’iniziazione.
Ad ogni risveglio si allena ad accettare questa ferita insanabile con il cuore pesante, per rispondere ad una chiamata diversa, sussurrata con parole quasi inafferrabili e prova ad imparare a stare al suo posto.
…a un certo punto non si può fare, ma soltanto essere e accettare… ma accettare si può solo per se stessi e non per gli altri, ed è per questo che sto passando un momento terribilmente difficile, qui. (E. Hillesum, Lettere).
Le cose stanno così, perché così stanno

Ehi bimba, diamoci una mossa, siamo proprio fuori tempo massimo: tredici giorni di ritardo, neanche fossimo delle gran dame. Bisogna concluderla ’sta fatica, ci tocca.
No no, ancora qualche giorno qui nella mia conchiglia al caldo, chi me lo fa fare? Dormo, mangio, tu mi porti a spasso e mi racconti le storie. E questa notte mamma, questa notte che cosa mi racconti?
Dunque, da pochi minuti è il 28 maggio. Oggi è un grande anniversario per la mia città, che sarà anche la tua, e per la mia vita. Due cose sono successe il 28 maggio, una meravigliosa e una tremenda.
Meravigliosa, meravigliosa, raccontala subito, voglio saperla.
Era il 28 maggio 1985, ero a Pavia per le lezioni di specialità di chirurgia e sono uscita a cena con degli amici e, per un caso assolutamente fortuito, c’era anche tuo padre. Ci conoscevamo da anni, ma non ci filavamo proprio, anzi ci guardavamo di traverso, sa Dio perché. Invece la sera di quel 28 maggio, proprio quella sera, ci siamo innamorati per non lasciarci più.
No, non così, raccontala per bene, voglio i particolari. Mi piacciono le storie alla “come on baby light my fire”. Tanto dormono tutti e non ti sente nessuno. Abbiamo tutta la notte davanti. Già m’immagino: fiori, ristorante di lusso, champagne, valzer…
Fiori tuo padre? Ma quando mai? Il valzer nel 1985? No, bambina, ma che film ti ho fatto vedere? Baretto per studenti, panino caldo, birra, la mia prima birra e politica: fiumi, mari di politica. Prima mari in tempesta, poi risacca, risacca lunga e assassina. La chiamavamo riflusso, che è una cosa che ti fa a pezzi. Il grande mare si ritraeva e la corrente ci tirava giù nel gorgo della solitudine, della disperazione, dell’eroina, dell’India, di un cappio al collo, della testa a posto, della testa esplosa che in fondo, allora, non sembrava fare gran differenza. Di colpo da tanti a uno, da noi a io. Mica cosa da niente. Noi che non riuscivamo a seppellire la passione politica, noi che non avevamo proprio la stoffa dei fricchettoni, noi ancora lontani dal cinismo e dal disincanto, noi bevevamo una birra e raccoglievamo i cocci, o almeno ci provavamo a cercare una ragione per passare oltre, per svegliarci, lavarci, vestirci, per camminare senza sogni. I sogni, bambina, sono potenti, ti sparano fuori da un cannone e voli per miglia e miglia. Ma quando cadi a terra… Ma che ti sto dicendo? Non si impara dall’esperienza degli altri, tanto meno da quella dei genitori. Capirai da te quando ti deciderai a uscire fuori e a camminare con le tue gambe, a rincorrere i tuoi palloncini.
Ma mamma, di che cosa sono fatti i sogni?
E chi lo sa? I sogni sono come le nubi, come l’amore, come un bacio, un bacio appassionato.
Allora poi papà ti ha baciata?
Ehi, non fare l’impicciona, questa parte della storia non ti riguarda neanche se scalci.
Coraggio, ora racconta la storia tremenda, tanto qui in questo guscio non c’è da aver paura.
Noi sì che avevamo paura, bimba, in quel 1974: attentati, pestaggi, minacce. Si chiamava strategia della tensione e ti ustionava la pelle, come una corrente, come una febbre che lievitava a poco a poco. Come faccio a spiegartela? Diciamo che quelli erano anni di grandi lotte operaie e studentesche, anni in cui sembrava davvero possibile rivoltare il mondo come un calzino e renderlo più giusto. E allora i padroni, quelli che comandavano si sono presi paura, paura di perdere i loro privilegi e ci hanno scatenato contro i loro cani da guardia: polizia, carabinieri, fascisti, servizi segreti deviati, forze dell’ordine. Hanno persino tentato un colpo di stato. Ma il movimento resisteva e riempiva le piazze. Allora sono comparse le bombe. Piazza Fontana: 17 morti e un centinaio di feriti; l’anarchico Pinelli, ingiustamente accusato precipita da una finestra della questura, poi viene assassinato il commissario Calabresi, poi l’agente Marino. Bombe sui vagoni ferroviari, sotto i tralicci dell’alta tensione. Tensione fuori casa e in casa.
Tu non esci di casa, alla manifestazione non ci vai, vestita così poi, con quel pastrano.
Si chiama eschimo papà, eschimo, me lo metto da mesi. È che tu neanche mi guardi. E se vuoi una figlia gonna a pieghe e filo di perle, ne devi fare un’altra, perché io esco così e vado alla manifestazione antifascista.
Che illusi, che illusi siete. Ma chi vi credete di essere? Cambiare il mondo con la politica? La politica è una cosa sporca.
È sporca la politica dei democristiani corrotti. Noi no, noi siamo dalla parte degli ultimi, degli sfruttati.
È tardi, afferro la maniglia della porta rabbiosa, rabbiosa contro di lui e il suo realismo, contro mia madre che non mi sostiene, contro le gonne a pieghe, contro la borghesia, contro le perle, contro il capitalismo.
E di colpo tutta quella rabbia si muta in coraggio ed esco, esco contro la sua volontà, esco e sbatto la porta, sbatto la porta. Boom, boom…
Volano ombrelli, vola sangue, volano le carni, carni umane. “Compagni e amici state fermi. State calmi, state all’interno della piazza, state all’interno della piazza, una bomba, portatevi a sinistra della piazza, verso il palco, state calmi, state calmi”.
Piove sul nostro sgomento, sui nostri occhi smarriti, increduli. Siamo morti? Siamo vivi? Chi è morto? Chi è vivo? Ci cerchiamo sbandando come ubriachi. Io sono intera, sono viva, viva per un soffio, sono viva perché ero in ritardo.
Mamma, eri in ritardo come me? Non mi piace questa storia. Io non voglio morire, non voglio che tu muoia, non voglio che muoia nessuno. Ma morire mamma, è proprio necessario? Si deve proprio morire?
Sì è obbligatorio, nessuno è mai riuscito a gabbare la morte. Diciamo che ora abbiamo imparato a tirarla per le lunghe, ma poi il passo ci tocca comunque.
Allora tu, tu mi metti al mondo per morire mamma?
No, no bimba, io ti metto al mondo per vivere. È che dentro la vita c’è anche la morte, non si spacchettano, è un regalo fatto così.
Non lo capisco mamma questo gioco, come si fa a vivere sapendo di dover morire?
Ma che ne so io bambina, io non ho ancora imparato bene. Si va avanti giorno per giorno, grazie a una distrazione, a una dimenticanza. Un tale, un poeta filosofo, uno di quelli che ci capiva, diceva che si vive “in forza di illusioni che hanno una radice vigorosissima e che tornano a rifiorire, a dispetto di tutta l’esperienza”.
Ma perché, perché?
Sempre quel filosofo poeta diceva che “le cose stanno così, perché così stanno”, che “ogni cosa ha radice in se stessa”.
E io, io allora da dove vengo?
Da un embrione, da un ovulo e da uno spermatozoo, diciamo da una possibilità su milioni.
Ma prima, prima?
Prima c’era un desiderio, prima c’era un amore.
Ma ancora prima, oltre l’amore, la terra, le stelle, le galassie, l’universo, la materia, l’energia? Oltre tutto, che cosa c’è mamma?
Bella domanda bambina, non so, oltre c’è il nulla, il nulla impensabile.
E se io sbuco fuori dal nulla e, alla fine della corsa, tornerò nel nulla, chi me la fa fare tutta la fatica?
Te la fa fare la vita, “cosa arcana e stupenda”, che riempie di stupore e di meraviglia: i monti e le montagne di rifiuti tossici, i mari e i morti annegati, l’amore e l’odio, le salite e le discese, le linguine al pesto e la fame, la bontà e la cattiveria. La vita è troppo grande per essere compresa, non ci sta nel nostro cervello e, a giorni, neanche nel cuore. Non puoi capirla, puoi solo viverla, illusioni comprese. E guai se non ci fossero quelle.
Allora si vive di illusioni mamma?
Sì anche, ma sotto sotto, sotto dove neppure i filosofi riescono a scavare, ho la sensazione che ci sia come una vitalità smisuratamente forte, più forte di tutto, una gemma che brilla per l’eternità per cui forse, forse, vale la pena. È come una spinta enigmatica ma potente che mi tiene sollevata sopra la vita, sopra la morte, sopra il nulla e che ogni mattina mi fa dire: sì eccomi, anche oggi sì.
Mamma che cos’è, come si chiama quella cosa?
Ehi scansafatiche, questo lo devi scoprire da te. Ora è quasi mattina: è il 28 maggio 1992, oggi ti lascio andare, smettila di tirare calci e preparati per il tuo tuffo di testa. Aggiungiamo un compleanno a questi anniversari.
Mamma, mamma, ma io, io… Anch’io bambina, anch’io.
Ça va sans dire
Aller, aller, mon petit, su con la vita. Spostasti un poco, ancora un paio di centimetri a droit, così, avanti, ora un petit peu a gauche. C’est bon.
Ditemi voi cosa mi tocca fare per quell’imberbe sulla soglia dell’adolescenza, con la bocca ancora sporca di latte e le ascelle che trasudano ormoni. Ecco, fermo lì. Voilà, les jeux sont fait. Finalmente abbiamo centrato il suo brufolo sulla mia macchiolina di ruggine, così il pivello non lo nota il foruncolo, che magari è capace di sentirsi svilito, sminuito nella virilità. L’adolescenza è proprio una stagione grama, si deve mordere chiunque si abbia vicino, anche se stessi, come cani in trappola. Gli arti si estendono, le spalle si disegnano, i nasi si allungano, le mandibole si squadrano. E quel odeur, che fetore di crescita che lo sento pure io che il naso non ce l’ho. Ma che fare?
Ehi mon enfant, ora te lo svelo io il trucco: a me gli occhi. Non conta tanto brufolo più o brufolo meno, è lo sguardo, mon amis, perso nel nulla, la fronte aggrottata e quell’espressione fra il tormentato e il misterioso…in italiano chiamasi bel tenebroso, appunto, qui, Ça va sans dire, fait tombé les femmes, come le mosche.
Non conta tanto quello che sei, non ti torturare, conta quello che sembri, che di maschi dallo sguardo alla Alen Delon con dentro il vuoto, je n’ai vu beaucoup, mais beaucoup.
Beh, bisogna dare una mano pure a lui e, finché si tratta di un brufoletto, ce la posso fare. Gioco un po’ con le mie imperfezioni e nascondo le prove del delitto.
Con sua sorella è più dura, c’est très difficile. Lei sono anni che si misura le tette, nella speranza che lievitino. Mi si para davanti a torace scoperto, senza pietà, senza attenzione alla mia sensibilità.
Che io sia di vetro o di carne, italiano o francese, les tettes sont toujours les tettes e, pure a me, un certo effetto lo fanno. E le sue non crescono proprio. Mi spiace poveretta, lei ce la mette tutta con gli impacchi caldo-umidi la sera, con le creme, ma niente, calma piatta. Glielo vorrei dire che non è quello che conta, anche se non guasta, che al giorno d’oggi c’è della biancheria che tira su e spinge verso in centro e fa di quel poco che hai un vero e proprio balcon, una balconata. Ma lei è proprio risentita, come fosse colpa mia, come se toccasse a me dispensare tette a destra e a manca. Se potessi, vuoi che non lo farei? Mi accontenterei anche solo di imbrogliarla un po’, di mostrarle quello che non c’è. Ma mica sono un mago.
La sera poi arriva l’homme, le marit, le père, le gros ventre: si sfila le scarpe, si toglie la giacca e la ripone sul servo muto. Poi è la volta della camicia, ed eccolo lì in canotta a righine, di profilo a richiamare la mia attenzione per misurargli la circonferenza della pancia. Raddrizza bene la schiena e prova a contrarre quel minimo strato di addominali mosci, poi si accarezza l’addome come per addomesticarlo, per convincerlo a ritrarsi almeno un poco e mi si mette di fronte. Quando è di faccia tira un sospiro di sollievo, perché la protuberanza sembra livellarsi, magari non proprio piatta, diciamo meno prominente. È ciò che gli basta per prepararsi un pirlo col Campari, e al diavolo la pancia.
E moi, io esulto: carboidrato santo subito, patatine, birra e rutto libero.
Lui si che ha capito come funziona la faccenda.
Sa femme, sua moglie invece, di fare la piega non ne vuole sentire parlare proprio. Mes amis, lei va dicendo che a una certa età gli specchi è meglio evitarli, ma è sempre qui a scocciarmi, a chiedere, a pungolarmi, a studiarsi le rughe, a misurarsi i fianchi o la circonferenza delle cosce, che sono sempre troppo tonde. S’è perfino comprata delle mutande rigide che le dovrebbero tirare su le natiche, fatte di una plastica che la fa sudare anche da ferma. Pauvre idiot, si crede che a sudare si dimagrisce!
Si mette di faccia e poi di profilo e mi guarda, come mi supplicasse. E io cedo per quello che posso, provo in ogni modo a distendermi nel senso della lunghezza, estendendo anche lei con l’inganno. Ma appena si avvicina di più, Ça va sans dire, l’effetto ottico svanisce e tutti i miei sforzi vanno a ramengo. Spaccarmi però non mi spacca, perché non sarà superstiziosa, ma sette anni di disgrazie non sono poche.
Quando si vuole misurare gli eccessi posteriori, io non le basto più. Apre l’anta dell’armadio dove è incastrato mio cugino più giovane e comincia la fatica di orientarla per vedersi dietro. Io e mio cugino nell’armoir abbiamo così l’occasione di rivederci, di scambiarci due battute, di tirarci su il morale a vicenda. E ce la ridiamo, mon Dieu de la France, come ce la ridiamo, quando la cicciona cerca d’assottigliarsi, quando implora lui di rifletterla sulla superficie mia con un minimo di clemenza. A lui la parte del poliziotto buono, ma a me quella del cattivo, perché è in me che si guarda e, purtroppo, si vede. Accidenti a lei.
È allora che parte la litania degli insulti alla menopausa, delle accuse agli ormoni, alla ritenzione idrica. E, a quel punto, la mia finezza, ma elegance, ma grandeur, s’envole, s’invola, e la mia italianità mi possiede.
Aho lardona, ma che te lo dico a fare? è inutile che cerchi in me Brigitte Bardot, molla il colpo, che la guerra con l’adipe l’hai persa. Passa al piano b, che so giocati il cervello, lo spirito, le equazioni di terzo grado.
Ma poi, nella mia immensa benevolenza, mi mordo la lingua, agguanto l’inclinazione della luce che entra dalla finestra e la concentro sulle sue caviglie, che non sono ancora sfatte. Quelle beauté, che caviglie sottili – le sussurro docilmente. Alla fine conclude che, Ça va sans dir, quello non è grasso, è solo gonfiore e spalma un paio di centimetri di nutella su una fetta di pane.
È un lungo addestramento il mio, mi alleno alla vaghezza, alla penuria di particolari, alla proiezione di ombre.
Quando lo sguardo di qualcuno si posa su di me, non mi illudo certo che cerchi me, cerca sempre se stesso, la propria immagine, a giorni la propria identità, raramente la propria anima. E più si guardano da vicino e meno si ritrovano. Io glielo vorrei dire che si comincia a comprendere, quando ci si allontana da se stessi. Ma poi mi prende la pena per loro, per la loro insipienza; allora li scruto e svelto svelto, cerco il desiderio dietro il loro sguardo: vuole vedere quello che crede di essere? Quello che vorrebbe essere? Quello che vorrebbe che si credesse sia?
Vita dura per uno specchio, e io sono pure antico, barocco francese, notare i miei riccioli dorati, un’imitazione, Ça va sans dir. E di fatiche me n’è toccate non poche.
Forse è andata peggio a quel mio antenato tedesco che, quegli sprovveduti dei Grimm, fratelli famosi, hanno messo nelle mani di una megera che voleva essere la più bella. E non le andava giù la storia dell’invecchiare, e se la prendeva con il mio prozio, quasi fosse lui a muovere la manovella che aziona il tempo.
Di storie poi, ve ne potrei raccontare per anni, da farvi sbellicare: dal trisnonno che prova il cappello da bersagliere con sguardo altero, alla moglie che si stringe in un corsetto fino all’apnea, al giovinotto, pistola in mano, che simula un duello, alla piccolina che ninna la bambola con occhio sognante, alla fanciulla che si allena a lasciar cadere un fazzoletto ammiccando. E potrei continuare.
Mi sforzo, giorno dopo giorno, di farli contenti, li guardo mettersi in posa davanti a me, cerco di rimandargli un’immagine che in qualche modo li soddisfi, oppure provo a fabbricargli un altro corpo all’istante, convincendoli ad indugiare con lo sguardo sul più, piuttosto che sul meno. Interrogo le emozioni, mi faccio psicologo e se scopro che ciò che vedono li fa soffrire, mes amis, quelle douleur, mi prende un’agitazione interiore, un lavorio di sensi di colpa da non credere.
No signori miei, non ve la prendete con me, non illudetevi che io sia il ritratto di Dorian Gray che si porta via la vostra monnezza; sono solo un muto testimone del tempo che passa e non sarò certo io a fermarlo. Io rimando immagini inerti, certifico, confermo, smentisco. Sono un notaio, a esagerare un ufficiale giudiziario.
Io più che vetro non sono, io rifletto, ma sta a voi riflettere, aprire una finestra su voi stessi, accedere a cosa sta dietro, penetrare la profondità, abbandonare l’illusione di eternità, di immutabilità, questo, signori miei non sta a me.
Non che non lo farei per voi. Negli anni mi sono pure affezionato al genere umano, soprattutto quando prende la via nostalgica del ricordo, quando si lascia aggredire dall’irruzione del passato.
Allora vorrei essere in grado d’ingrandirgli il volto per farglielo vedere meglio, per dirglielo quanto somigliano aux enfants, ai piccini che sono stati, quanta verità dell’infanzia ancora li impronta. Perché io ce l’ho la certezza che quei bambini ancora mi stanno scrutando, cercando in me il profilo di una regina, i muscoli di un futuro guerriero. Io ce l’ho l’attitudine a cogliere la vibrazione della realtà dietro il belletto, il groviglio di conflitti, le rimozioni. È che a giorni devo cedere all’inganno, perché non si può sempre dire tutto, bisogna essere discreti, distorcere le cose magari solo un pochino, snellire, per non turbare troppo.
Ma è la madame, la vecchietta che mi manda in crisi e mi commuove. Con lei non riesco proprio a mantenere le distanze. È ancora bella, di una bellezza passata ma non trascorsa, direbbe l’Alessandro d’Italie, il Manzoni, Ça va sans dir.
Lei non viene a chiedermi di renderle la giovinezza, lei lo sa che il bello prescinde dal tempo. Lei studia l’abisso, l’ombra della morte dietro di sé.
Allora io mi prendo paura, l’accarezzo, le rimando il passato, le rovescio il tempo addosso e lei, mon Dieu, lei ci casca. Ripercorre tre quarti di secolo indossando un cappellino con la veletta, cerca un ricordo in un paio di guanti estivi, un amore in un bottone di madreperla, un gesto perfetto in un petalo di rosa. A giorni passano ore in mia compagnia, lei e son chat, il gatto. Si scrutano, s’indagano: una si riconosce nel visino della mademoiselle che è stata e si sorride, l’altro, le chat, non si riconosce proprio, rizza il pelo e si fa la gobba Ça va sans dir.
Tornando a casa. Diario di un trekking himalayano
Dedicato a mia figlia Valeria, perfetta compagna di cammino
Si ringraziano Keshab lo sherpa, Prabath la guida e soprattutto il magico Nepal
Una volta anche lui era angosciato
dalla morte. Sì, e pure dalla vita, per
questo. Forse soprattutto dalla vita.
Angosciato, sì. Ma era molto tempo
prima. Anche l’angoscia è rimasta tra le
montagne. Ora c’è per lo più grande
quiete in lui. E, intorno a lui, come tra le
montagne.
(G. Gunnarsson, Il pastore d’Islanda)
La polvere nei denti è la prima sensazione che ti regala Kathmandu. Strade per lo più sterrate, traffico caotico peggiorato dalla guida a sinistra all’inglese. Macchine, bus strabordanti persone, motorini, biciclette, mucche patite, sdraiate sulla carreggiata che i veicoli evitano con sterzate improvvise, galli e galline, cani dallo sguardo mansueto e polvere dovunque. Gruppetti di donne, armate di scope di saggina hand made, spostano con gesti automatici la polvere dai marciapiedi, la sollevano per lasciarla ricadere pochi metri più avanti. Ci sembra di capire che il governo garantisca alle donne della capitale una sorta di compenso simbolico per il lavoro di pulizia strade, che in realtà si riduce a un semplice alzare la polvere in aria.
Kathmandu, oltre che inquinata e polverosa, è lurida e povera. Espone la propria miseria senza ritegno, baracche e campi tendati in pieno centro inclusi. Il Nepal è uno dei paesi più poveri al mondo, con una caduta del PIL del 35% negli ultimi due anni e un elevato tasso di denutrizione infantile. Ogni anno dalle cinquemila alle dodicimila ragazze nepalesi, dai sette anni in su, vengono rapite per lavorare nei bordelli indiani.
Al calare del sole la città si fa buia, cavi elettrici malconci penzolano fra un pilone e l’altro quasi sfiorando terra, annodati gli uni agli altri, ingarbugliati. La corrente elettrica illumina solo gli esercizi commerciali e gli alberghi, le strade sono scure e ci si devono cavare gli occhi per non calpestare mucche, bufali o cani randagi adagiati sui marciapiedi.

Kathmandu sorge a 1.337 metri di altitudine, ma di montagne neanche l’ombra. Comincio a chiedermi che cosa mi abbia condotta in questo luogo dimenticato dagli dei e sommerso dallo smog e dalla polvere. Che cosa mi credevo di trovare? Che cosa cercavo? Da dove veniva tutta quell’attesa, quel desiderio di Nepal che covavo da decenni e che mi ha portata qui a calcare i primi passi della mia vita da pensionata?
Il nostro è un viaggio in autonomia. Ho cercato di associarmi a un gruppo di Avventure nel Mondo che però non ha avuto fortuna. Dunque: o rinunciare al Nepal o organizzarsi da sé. Ho scandagliato internet, indagando tutti i siti di trekking, per poi decidermi a contattare un’agenzia nepalese che ci fornisse una guida e uno sherpa. Due viaggiatrici: io e mia figlia Valeria che si è offerta di condividere con me questa avventura.
Non è prudente due donne sole in un paese lontano come il Nepal – mi dicevano gli amici. In realtà si tratta di un paese povero ma tranquillo, dove non capita di sentirsi insidiate o in pericolo. Poi il percorso scelto è molto frequentato, uno dei classici, niente di veramente avventuroso. E poi si deve andare.
La guida ci conduce in un vicolo non più pulito di altri e in fondo compare come un lampo Boudanath, lo stupa buddhista più grande del mondo, ricostruito dopo il terremoto del 2015 che uccise novemila persone e ne ferì gravemente ventiduemila, riempiendo la capitale di profughi che avevano abbandonato i villaggi. L’impatto con questa imponente costruzione sacra è fortissimo. Su una base quadrata, poggia un’ampia cupola bianca. Da una sorta di campanile gli occhi di Buddha ti seguono ovunque. Pellegrini, monaci e nepalesi qualunque s’incontrano qui per camminare intorno allo stupa, secondo il rituale, suonando le campane tibetane, facendo rollare le ruote di preghiera e, ovviamente, pregando. Intorno monasteri, laboratori che producono candele di burro, corni cerimoniali, cappelli piumati per i lama e tamburi, scuole di pittura sacra e bandiere di preghiera ovunque. Un senso di sacralità è palpabile, forse è questo girare ipnotico, ne’ avanti, ne’ indietro, solo camminando in tondo in senso orario, in silenzio, le campane che suonano di continuo mentre il cielo scolora. Originariamente lo stupa era una stazione postale fra Lhasa e Kathmandu, dove i mercanti tibetani si fermavano a pregare per propiziare il viaggio prima di affrontare gli alti passi himalayani. Mi viene l’idea di acquistare un rosario nepalese e cominciare a sgranarlo, ma invisibili lacci ancora mi trattengono, sono appena approdata in questo mondo enigmatico. Un gesto mancato.
Continua a leggere Tornando a casa. Diario di un trekking himalayanoUomini e topi di John Steinbeck
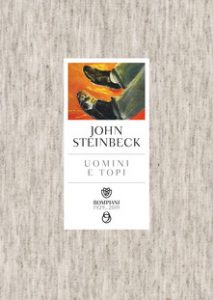
John Steinbeck, Uomini e topi*, Bompiani 2019 (pp. 128, euro 14)
Capita così, quando un romanzo mi ammalia, finisce che mi butto a leggere tutto del suo autore, vittima di una sorta di famelica curiosità, come alla ricerca, nella sua traccia letteraria, del suo percorso interiore. Così è stato che ho letto Uomini e topi.
Mi era stato presentato come un romanzo duro, crudo, che non lascia spazio alla speranza, ma ci ho trovato un mondo di pietà, uno sguardo acuto sull’invisibile.
Steinbeck lascia la miseria sullo sfondo e punta lo sguardo sulla relazione che si stabilisce fra due braccianti stagionali che migrano da un ranch all’altro, in una sorta di nomadismo.
Lennie, dotato di una stazza imponente associata a un’incredibile forza fisica che la sua mente insufficiente non sa gestire. Non sa bastare a se stesso e si mette inconsapevolmente e ripetutamente nei guai. Un gigante con un cuore da bambino, un po’ tocco, lento di testa. Ma, come dice George, non c’è bisogno di troppo cervello per essere un bravo ragazzo.
George gli è amico dall’infanzia: piccolo e minuto, ma acuto di mente; si prende cura di lui, lo protegge da sé e dalla crudeltà del mondo di fuori.
Chi abbia mai avuto a che fare con persone affette da disabilità mentale, riconosce in Lennie molte caratteristiche: la scarsa o nulla coscienza della propria forza, l’incapacità a dosarla, un’ingenuità disarmante, l’attaccamento a oggetti simbolo, come fazzoletti annodati, monete, pezzi di carta che rivestono un misterioso ruolo, per i quali farebbero follie. Per Lennie si tratta di topolini, cagnolini o coniglietti dal pelo morbido. Li acchiappa e li accarezza con le sue mani grandi e pesanti, li accarezza fino a ucciderli. Ma li uccide come per sbaglio, preda del forte desiderio di sentire il contatto con il pelo morbido, di coccolarli.
Nessuna malvagità in lui ma, come è ovvio, i suoi gesti goffi e smisurati, vengono regolarmente mal interpretati. È George che lo tira regolarmente fuori dai guai, dai tentativi di linciaggio, e che con lui fugge verso un nuovo lavoro: una nuova raccolta in una nuova fattoria, dove Lennie, per un motivo o per un altro, tornerà a mettersi nei guai.

Li tiene insieme un sogno che George ripete quasi ossessivamente all’amico per tenerlo calmo: un giorno metteremo insieme dei soldi e avremo una casetta, un paio di acri con una mucca e qualche maiale e… e vivremo dei frutti della terra, e avremo dei conigli, avremo un orto, e un capanno per i conigli e per i polli. E quando d’inverno piove manderemo al diavolo il lavoro e accenderemo un bel fuoco nella stufa e staremo seduti lì ad ascoltare la pioggia che cade sul tetto.
Perché – spiega ancora George – i tipi come noi, che lavorano nei ranch, sono le persone più sole al mondo. Non hanno famiglia, non appartengono a nessun posto. Arrivano in un ranch e mettono insieme un gruzzolo, poi vanno in città e fanno fuori il loro gruzzolo, e puoi star certo che la prima cosa che fanno è mettersi a sgobbare in un altro ranch. Non hanno niente cui aspirare.
È allora che Lennie, estasiato, lo incalza a continuare la storia che sa a memoria, ma che vuole recitata dall’amico, come una fiaba raccontata a un piccino per prendere sonno: ora dimmi quello che tocca a noi.
Per noi non è così… Perché io ho te che mi stai dietro, e tu hai me per star dietro a te… noi abbiamo un avvenire. Possiamo parlare con qualcuno al quale importa di noi. Non dobbiamo starcene seduti in un bar a buttar via i soldi solo perché non abbiamo un altro posto dove andare.
Due uomini non più soli che si prendono cura l’uno dell’altro: il piccolo protegge il gigante dai suoi movimenti maldestri e dalle asperità della vita, il grande dà senso al continuo migrare del piccolo, dà all’amico la forza del sogno che lo tiene lontano dall’abbruttimento dell’alcool e dei bordelli.
Steinbeck descrive questo accudirsi l’un l’altro con una delicatezza magistrale. E’ questo l’un l’altro che fa la differenza a mio avviso. Altre letture del testo si sono concentrate sulla pietà di George nei confronti dell’amico poco sveglio, senza vedere l’altro verso della medaglia, non meno ornato di cura e compassione.
Lennie apre a George la possibilità di una vita dignitosa ma, ancora di più, lo tiene sul bordo di un sogno, un sogno che George da solo non reggerebbe. È Lennie che consente a George di scoprire dentro di sé l’amore, la pietà, l’amicizia. Nessuno l’ha mai amato come Lennie, nessuno si è mai affidato a lui senza riserve come l’amico d’infanzia, nessuno ha saputo tenerlo attaccato al lato buono dell’esistenza come lui.
È quello che capita di scoprire nella relazione con chi affronta la vita meno attrezzato di noi, con chi pensiamo di aiutare, di guidare e che spesso invece ci conduce verso una comprensione profonda, oltre il visibile, oltre noi stessi, e ci fa fare i passi che contano.
E siamo all’epilogo: George, ho fatto ancora una cosa brutta. Non importa – disse George, e tornò al suo silenzio.
George è costretto a un gesto crudele, ma compassionevole. E ancora incanta l’amico con il mantra del loro sogno: avremo un posticino tutto nostro… avremo una mucca e forse avremo un maiale e dei polli… e nel campo avremo… un piccolo appezzamento d’erba medica…
Per i conigli – grida Lennie.
Per i conigli – ripete George.
E io baderò ai conigli.
E tu baderai ai conigli.
E vivremo dei frutti della terra.
Come talvolta avviene, un attimo discese e si librò e durò molto più che un attimo. E il suono tacque e il movimento tacque, per molto più che un attimo.
*All’origine del titolo del racconto una poesia di Robert Burns che recita:
«Ma topolino, non sei il solo,/ A comprovar che la previdenza può esser vana:/ I migliori piani dei topi e degli uomini,/ Van spesso di traverso,/ E non ci lascian che dolore e pena,/ Invece della gioia promessa!».
Di cosa parliamo quando parliamo d’amore
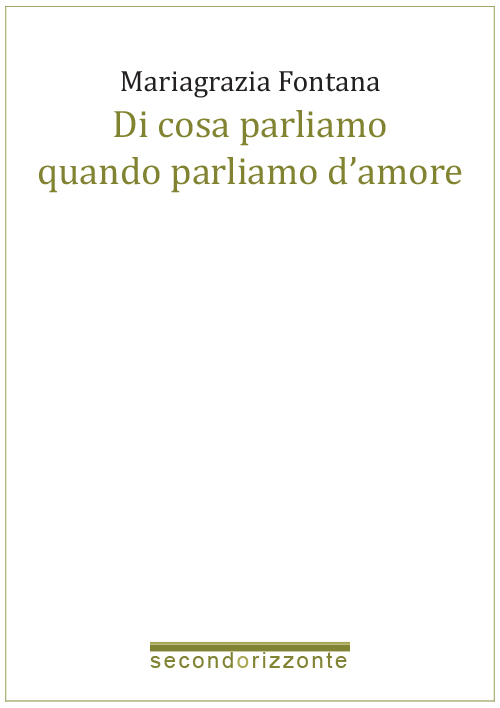
La soluzione alla mia vita mi venne in mente una sera mentre stiravo una camicia. Era semplice ma audace. Mi presentai in soggiorno dove mio marito stava guardano la televisione e dissi: c’è una cosa che volevo dirti da un po’.
Non fece neanche cenno di aver sentito, gli occhi calamitati dallo schermo dove ventidue giocatori si contendevano la palla sudando, dribblando, scartando.
Era così quando giocava l’Inter, la sua squadra del cuore o forse della pancia, perché era nelle sue viscere che tutte quelle scarpette chiodate correvano, poi retrocedevano, poi si passavano la palla, poi fingevano un’azione mettendone in atto in realtà un’altra. I primi anni di matrimonio questo istupidimento mi aveva fatta inorridire. Com’era possibile che un ragazzo intelligente e colto potesse farsi prendere per il naso da quattro calciatori, con tutto quello che succedeva nel mondo?
Sì, sì, ma il tifo è un’altra cosa, è un fatto a sé, tu non lo puoi capire – mi aveva risposto. E infatti io continuavo a non capire, a non spiegarmi tanto affanno, tanta sofferenza per una partita. Negli anni ci avevo anche provato a capire un derby, sia con mio padre che con mio marito, me l’avevano ben spiegata quella storia del fuori gioco, del contropiede e via discorrendo, ma mi restava attaccata per il tempo di una partita e poi, flop, si sgonfiava, così come la mia affezione per quei novanta minuti che mi parevano eterni e terribilmente noiosi.
E’ che il calcio a te non ti strizza le coronarie – mi diceva lui.
Infatti a me lo sport piaceva farlo, più che guardarlo: una volta corse nei campi, ora lunghe camminate lente.
Anche mio padre aveva lo stesso morbo di mio marito: si sedeva sul bordo del divano, mai abbandonato sui cuscini, ma rigido sullo spigolo, la radio accesa, lui in allerta, le pupille dilatate, le gambe pronte allo scatto, come se il goal competesse a lui.
Forse sarà l’espressione fenotipica dell’ipsilon, di quel secondo cromosoma sessuale maschile che si porta appresso il virus del pallone e che agli uomini fa rotolare il buon senso su un campo verde, verso una porta.
Forse il tifo è il loro modo per comunicare l’uno con l’altro, a suon di pacche sulle spalle, battute, scommesse, sfide da niente. Forse il tempo di una partita è ciò che un padre concede a un figlio maschio, una sorta di tregua, di sospensione delle ostilità fra i due galli nel pollaio. Sì, per mio marito l’Inter era un padre che scioglie gli ormeggi, che diluisce lo sguardo dell’imposizione e del controllo fino a scimmiottare amicizia.
Come sempre, dietro le cose semplici, c’è molto di difficile da capire.
Interrompere un derby, rovinargli una partita così importante, che responsabilità! Eppure era quello il momento, allora era affiorata l’urgenza di dire. È che quando le parole vengono su così, senza fatica, senza intenzione, quasi senza controllo non le si può cacciare giù. Erano così limpide quelle parole, che parevano pensate da un’altra, una con le idee ben più chiare delle mie, una che sapeva che cosa volere, una che non aveva paura di niente.
Sentivo che quell’ardire andava cavalcato, come fosse l’onda giusta, quella storica, per cui un surfista si sveglia all’alba da decenni a studiare il ritmo dei flutti: coppie di due, poi di tre, poi la risacca ed ecco la corrente perfetta, rimestata dalla luna crescente che alza quel muro d’acqua e ne fa un tunnel dentro il quale sciare, un piede davanti all’altro, le braccia spalancate, il tronco in leggera torsione, la tavola a volare sulla schiuma, gli occhi stupiti e increduli.
Non ti ho mai amato – gli avrei detto. Lo avrei detto a lui per dirlo anche a me stessa. Non che io non lo sapessi: il corpo, il sangue sapevano tutto. Ogni cellula aveva sempre saputo, sia nucleo che citoplasma, sia mitocondri che ribosomi. Ma dirlo era tutt’altra faccenda. Sono quelle verità che diventano vere solo a voce alta, per merito delle parole, come se solo le parole ne dovessero portare il peso. Mica male l’idea, traslocare la colpa della mancanza d’amore su un congiuntivo o su un condizionale: se fosse… se magari tu o io…
Provai a ripeterle a voce bassa, scandendo le parole ad una ad una, solo per me, per farci l’abitudine: Mario, io non ti ho mai amato. Quella sì che era una frase d’effetto, una dichiarazione secca, ruvida, di quelle che ti rimbombano nelle orecchie fino a gonfiarti i timpani come vele. Nessun preambolo, nessun panegirico, solo la verità, messa sul piatto tale e quale.
Che poi non si è colpevoli se non si ama, almeno l’amore non lo si programma, non ce lo si può imporre. Arriva quando è ora, spesso come uno schiaffo in pieno viso, come un colpo di vento, come un tremore irrefrenabile che cambia la prospettiva.
Io questo lo sapevo bene, così come sapevo che non era quello il sentimento che mi aveva tenuta insieme a mio marito. A lui volevo bene, molto bene. Condividevamo casa, figli, progetti, vacanze in buona armonia. Rari gli screzi e sempre di piccolo cabotaggio.
Perché Mario era un uomo come si deve, uno affidabile, un alpinista coi fiocchi, sincero, posato e, fino a prova contraria, fedele. Insomma un buon marito e un buon padre.
Provavo per lui un sentimento profondo ma tiepido, solido ma troppo liscio per aggrapparcisi.
Non che io fossi capace di abitare solo la superficie, la sicurezza. L’avevo ben sentita quella corrente impetuosa che sradica gli alberi, che demolisce i muri e spazza via le nubi. Ma era tanto, tanto tempo fa: cinquant’anni, forse più. Eppure a pensarci potevo lasciarmi riprendere da quel fremito, da quell’abbandonarsi, da quel conficcarsi i denti nella carne che ricordavo alla perfezione.
Poi Giorgio era partito per la guerra, una di quelle che dovevano durare poco e che non finiscono mai. Non aveva mai risposto alle mie lettere, addirittura si era pensato fosse morto al fronte. E tutto quell’amore era finito nel fosso della mia disperazione ed ero rimasta sola. Avevo aspettato, anno dopo anno, fino alla fine della guerra, sempre scrivendo, sempre sperando in una lettera, o almeno una cartolina. Nulla.
Alla fine era tornato, malconcio ma vivo. Vivo in apparenza, in realtà morto. Quello sguardo brillante e strafottente s’era mutato in occhi attoniti, vuoti. Gli erano state amputate due dita della mano destra per una mina, e quelle dita si erano portate via la sua anima. Vagava per il paese irriconoscibile, alto, ancora più magro, ingobbito. A giorni salutava con un cenno del capo, altri neppure quello, camminava per i campi perso in non si sa quali pensieri, o quali ricordi. Forse un attacco nemico, o un compagno che gli era morto fra le braccia. Nessuno seppe mai.
Poco alla volta ritrovò un lavoro. Lavorava, mangiava, dormiva, soprattutto camminava senza fine. Poi ancora lavorava, mangiava, dormiva e camminava, camminava a vuoto. Non s’era più affiatato con nessuno, neppure con gli amici d’infanzia che ci avevano anche provato a tirarlo fuori casa, ma niente da fare. Con me non ci aveva neanche parlato, come se nulla fosse successo fra noi, come se fossi un fantasma, o un sogno.
Certo, non aveva obblighi ufficiali, non eravamo fidanzati in casa, ma l’amore, quello che spacca le pietre più del sole d’agosto, quello c’era stato eccome. Eppure la guerra o sa Dio cosa era riuscito a frantumarlo.
Dopo anni anche Giorgio s’era sposato con una di un paese vicino. Forse con quella si sarebbe ripreso – s’erano detti gli amici. Invece nulla fiaccava quella malinconia.
Poi di botto, ad una festa di capodanno alla trattoria in piazza, Giorgio mi aveva invitata a ballare. Un valzer di Strauss.
Ballavamo bene che a guardarci era un piacere. Sarà stata la musica, o forse la danza, o il lambrusco ma a me era sembrato di riconoscere in quell’uomo smilzo, prosciugato dalla tristezza, un barlume, il riflesso di quel ragazzo che sapeva accarezzarmi, che mi parlava d’amore come nessuno, che mi stringeva a sé senza farmi respirare.
Era forse il tocco della sua mano robusta sulla vita, che mi avvinghiava, che mi riprendeva decisa senza parlare, senza dichiarare. O forse tutto era successo solo nella mia testa, nei miei desideri.
E invece no, l’avevo sentito sulla pelle proprio come allora.
Poi lo avevo incrociato nella bottega del panettiere e ancora quegli occhi parlanti che sapevano farmi sentire bella. Poi una domenica in chiesa mi aveva sfiorata leggero come per sbaglio, ma le sue dita erano calde, troppo calde per non avere intenzione. Quando Giorgio mi guardava mi ricordavo d’avere un viso, degli occhi, un corpo e dei sentimenti.
L’incanto era durato decenni. Decenni di sguardi, sorrisi appena accennati, qualche mazurca, mano nella mano.
Per tutti Giorgio era rimasto un libro chiuso, ma io, al tocco della sua mano, gli leggevo dentro e le sentivo le sue storie: lui che corre a perdifiato sul pendio e scavalca una staccionata, il suo occhio che punta nel mirino, sua madre che gli scalda il latte a colazione, le sue palpebre che vorrebbero serrarsi e non uccidere, lui che vince una partita di briscola, la sua divisa impigliata nel filo spinato, la mano ferita, il mondo intero che gronda sangue fra mitragliate e bombe. E lui che vorrebbe fuggire, scomparire, dissolversi nel fumo di una cannonata per tornare a casa e cancellare la guerra.
Ai balli sedevamo sempre lontani, ma anche così emanavamo la stessa luce e quel calore che annoda le viscere. Per anni ci eravamo amati così, un amore silenzioso, non detto, non consumato che bruciava la carne, riempiva il cuore e dava senso ai giorni. Nessun cedimento, nessuna infedeltà di giorno. Ma di notte, in sogno, che fragore di tempesta, che fulmini, che tuoni, che albe infuocate l’una nelle braccia dell’altro.
Ora che Giorgio se n’era andato, consumato da una di quelle malattie che non hanno pietà e non concedono speranze, anche i sogni s’erano spenti e lo sguardo non aveva dove posarsi.
Io gli parlavo tutto il giorno nella testa. Certi giorni mi spingevo fino al cimitero in collina per raccontargli di chi s’era sposato, di che se n’era andato all’estero, dei litigi, delle vendette da niente. Ma dovevo stare attenta per non insospettire la moglie, perché la vedova legittima non ero certo io.
È che poco alla volta anche dentro di me la vita si andava ritirando, non ci tenevo più a svegliarmi, lavarmi, cucinare, fare la spesa. Non c’era ragione per infilare un gesto dietro l’altro. Neanche mi sforzavo, andavo avanti per inerzia, giorno dopo giorno. Avevo ricominciato a camminare, così come da giovane, come camminava lui, chilometri e chilometri nei campi, in silenzio, senza neanche pensare, sgranavo passo dopo passo come chicchi di rosario.
Questa sera glielo avrei detto a Mario, perché era giusto, perché Mario se la meritava l’onestà. Non che avessi nulla da confessare, non era mai successo niente e secondo le regole dello Stato e della Chiesa io era pura e innocente come un lenzuolo appena lavato. Ma dentro che peso mi gravava sul cuore, che opacità nell’animo.
Dopo la confessione me ne sarei dovuta andare. Non sapevo dove e in realtà non mi importava affatto.
Ma che cosa ne sarebbe stato di Mario che non sapeva cuocersi neppure un uovo al tegamino? Sarebbe sopravvissuto a tutta quell’onestà? E le pastiglie della pressione chi gliele avrebbe date?
Sììììì, cavolo, finalmente: goal. Dimmi tu che cosa ci voleva. Non potevano mica farlo prima questo goal del cavolo che fra un po’ morivo d’infarto? Questa squadra di merda è fatta così, ti fa penare fino all’ultimo e poi ti consola.
Era balzato in piedi come un ragazzino, le braccia tese, i pugni stretti e un sorriso che pareva superare le orecchie, felice.
È che non posso non tifare per l’Inter, l’Inter è la mia squadra, la squadra dei perdenti. E la squadra e la moglie non si tradiscono – mi disse e quasi danzando mi indirizzò verso la cucina sempre con quel sorriso cristallino stampato in volto.
Moglie, non è mica ora di cena? Non si mangia stasera in questa casa? Mi chiese scherzando, come recitasse su un palcoscenico.
Era proprio un bell’uomo mio marito, un uomo dalla chioma imbiancata, un vecchio giovane che sapeva entusiasmarsi come un bambino. Lo guardavo gioire saltellando e ridevo mentre mi cingeva in un valzer senza musica. L’Inter aveva vinto, si doveva festeggiare.
Amavo quegli occhi limpidi che sapevano cogliere di me anche i cambiamenti molecolari, quel volto aperto, la sua stretta decisa, la sua passione per le cime. Sì, lo amavo, amavo anche lui, quasi a mia insaputa. Lui era la mia bussola nell’uragano, con lui avevo tenuto insieme l’ordito dei giorni.
Come avrei respirato senza di lui? Come avrei potuto svegliarmi, pensare, camminare senza Mario al mio fianco, senza l’Inter che perde spesso e vince di rado?
Magari l’Amore, quello grande e unico esiste solo nei romanzi, magari di amori ce n’è più d’uno. Magari a guardarlo al rovescio, un amore solo pensato non è che un sogno, un desiderio antico, un’onda che si infrange sulla battigia e di cui resta solo la schiuma. E la schiuma, si sa, non scalfisce la meccanica sacra di una vita.
Forse un amore tutto nella testa intorbida lo sguardo, e così, continuando a sognare, finisce che dormi, che t’intontisci e non vedi più quello che hai. Ti disorienti come una ragazzina.
È complicata questa faccenda dell’amore. Anche a provare a ragionarci non ci si capisce niente. A giorni sembra che la matassa si dipani, sembra di avere finalmente afferrato il capo del filo, che i pensieri si rischiarino, poi basta uno sguardo, un giro di valzer, un goal dell’Inter e tutto si capovolge di nuovo.
Lasciai che quest’amore quotidiano si tendesse dentro di me come una molla, che accorciasse le distanze, che capovolgesse inaspettatamente la prospettiva del sentire, che attecchisse.
Sempre danzando e sorridendo Mario mi condusse in cucina, io sollevai lo sguardo e, con la destrezza di un centravanti dell’Inter, lo baciai. Un bacio serio, di quelli da ragazzi: l’Inter aveva proprio vinto.
Poi mi infilai un grembiule e cominciai ad affettare una cipolla, mentre dietro le palpebre un pianto sereno rivendicava i suoi diritti.
Al finestrino
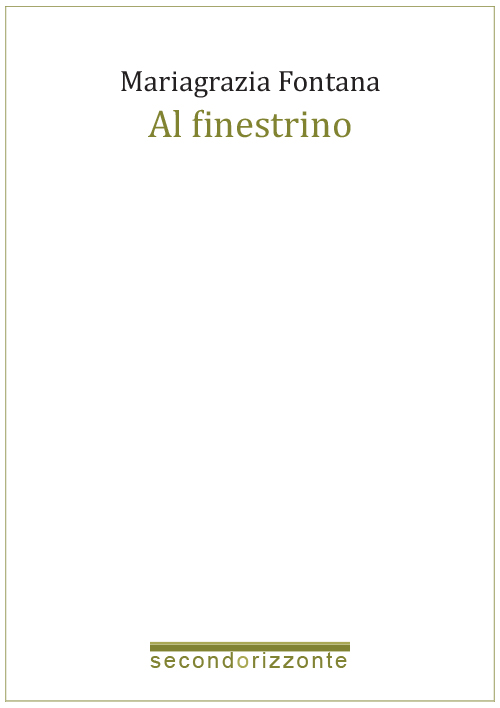
Verde, azzurro, azzurro, verde, verde, azzurro, verde, marrone, azzurro, azzurro, poi verde e ancora verde e azzurro a rincorrersi l’un l’altro. Quando prende velocità, il treno accelera i colori, e ciò che appare al finestrino è un minestrone di verde, azzurro e marrone, a volte giallo, non fusi insieme, ma in successione così rapida da confondere gli occhi. E questo inseguirsi di colori attanaglia lo sguardo, muove ritmicamente le pupille avanti e indietro in un ripetersi di vegetazione di pianura che stupisce, che incanta.
Non si può smettere di guardare, gli occhi incollati a quel riquadro rettangolare come fosse uno schermo. Concederglisi è perdere il senso del tempo, restare appiccicati a un movimento continuo solo apparente.
Ci si può illudere di essere immobili di fronte allo spettacolo del mondo di fuori che s’è messo ad accelerare di colpo al solo scopo di ammaliare.
A volte, invece, mentre il treno corre in avanti, capita che la memoria cominci ad andare a ritroso. Il passato prossimo la calamita per primo: eventi recenti, ordinaria amministrazione: impegni dimenticati, gesti incompiuti, parole frettolose o mal misurate balzano fuori da ieri e dall’altro ieri.
Sembra che a molte persone il treno faccia questo effetto: metta in moto il ricordo. Sarà quell’incedere ripetitivo, il mantra del rumore della velocità, dell’aria incisa dal movimento, quel continuo susseguirsi ossessivo di alberi e case che invita il passato a manifestarsi, a prendere posto in vettura, togliere il cappotto ed accomodarsi di fronte per lasciarsi scrutare a piacere.
Sono i ricordi buoni quelli che si addicono al viaggio, sapori dolci, tepore, un vestito che ti calza come un guanto, un incontro imprevisto che rivanga negli anni, una musica dimenticata che riprende fiato in uno scompartimento. Raramente gli eventi opachi, paralizzanti, che hanno fatto ingombro per decenni si fanno vivi in quel panorama, scelgono abitualmente contesti più intimi, raccolti.
Era entrata in silenzio, di soppiatto. O forse era lei che s’era persa nei colori, o imbambolata nei ricordi a lasciare lo sguardo sfiorare le cose di fuori, a guardare senza vedere e non l’aveva sentita arrivare. Le si era seduta proprio di fronte. Non che non ci fossero altri posti, lo scompartimento era vuoto, a parte loro. È che lei, deliberatamente, le si era piazzata dritta in faccia.
Si sforzò di ricordare se mai l’avesse conosciuta. Le succedeva spesso di scordare volti, e non solo i volti incontrati di rado, anche quelli che di consueto incrociava sul marciapiede di casa. Non è che li scordasse proprio, è che non sapeva dove metterli, il suo cervello le segnalava che li conosceva, ma non chiariva chi fossero, che relazione avessero con lei, quanto prossimi le fossero, se fosse il caso di interpellarli con il tu o con il lei. E questo la metteva in difficoltà e le iniettava dubbi, la rendeva guardinga e insicura.
Non era una vicina, neppure una paziente o una collega, ma qualcosa in quei lineamenti non le era estraneo: il modo di inclinare il capo, così come il vezzo di tenere sollevato il bavero della giacca e annodato il foulard al collo.
Si accorse di studiarla oltrepassando, inconsapevolmente, quell’area privata, intima che solo in amicizia si oltrepassa, a volte. Succede quando una persona ti si piazza di fronte in uno spazio limitato, di non sapere bene dove guardare, di cadere vittime di una sorta di imbarazzo, di timidezza, di incertezza dello sguardo che non sa dove posarsi, perché se si guarda l’altro in faccia si rischia l’invadenza, se non lo si guarda affatto l’indifferenza. Pensò di proteggersi dietro le pagine di un libro, ma c’era qualcosa in quella donna che l’attraeva.
Puntò di nuovo gli occhi al finestrino: verde, azzurro, verde, azzurro, verde, verde da stordire il cervello. Poi, con lentezza studiata, obliquò lo sguardo di quel poco sufficiente per osservarla di nuovo, nel dubbio di doverla salutare. Teneva le spalle un poco piegate in avanti, come se appoggiarsi al sedile, rilassarsi, le costasse fatica. Si intuiva qualcosa di potente dentro di lei che le toglieva le forze.
Forse la conosceva proprio, forse le ricordava qualcun’altra. O forse doveva salutarla solo per cortesia. No, in verità il bon ton imporrebbe il saluto alla nuova venuta, non a chi già se ne sta comodamente seduto sul sedile di un treno – pensò – e rise fra sé all’idea di essere ancora vittima di quei dettami materni che tanto l’avevano irritata.
Ma restò in silenzio, continuando di sottecchi a soppesare la donna che le si era seduta di fronte. Pareva accigliata, forse un pensiero, un cruccio, problemi di lavoro o un figlio che non faceva giudizio. Quel volto aveva un’aria fragile, come fosse crepato, come qualcosa che si fosse rotto e poi riaggiustato alla bell’e meglio.
L’estranea di fronte aveva i capelli ricci come i suoi, ma li lasciava grigi e non le stavano affatto male. Le risuonò in testa il rovello consueto: li tingo o non li tingo? Negli anni aveva continuato con la liturgia del colorarsi i capelli, ufficialmente per non mettere in crisi le figlie che non la volevano in disordine, cioè che non volevano vederla farsi vecchia, non illudendosi d’essere innocente sul quel versante: anche lei faticava a digerire il passo rapido del tempo e, in fondo, un po’ di colore in testa non faceva male a nessuno.
Anche la signora seduta in treno, come lei, aveva mani lunghe e dita sottili che teneva intrecciate come in preghiera. Ora si arrotolava un ricciolo con un dito mentre guardava fuori dal finestrino, forse lei pure calamitata dal correre delle cose di fuori. Ora pareva sorridere, cioè non proprio sorridere ma distendere un poco il viso, come se la contrattura delle afflizioni s’indebolisse. Doveva essere stata felice un tempo, quel volto tradiva le corde della felicità.
Continuava a frugarle il viso con lo sguardo. Forse ci stava ricamando sopra.
Provò a datarla, a darle un’età approssimativa, e sentì una femminile, perfida soddisfazione al pensiero che era sicuramente più vecchia di lei. Più vecchia, ma altrettanto triste, fu costretta ad ammettere.
E fu quel pensiero che le calò addosso come un maglio, che le allungò il mento verso terra e le piegò gli angoli della bocca da farla sembrare una barca rovesciata sulla battigia.
Quella donna faceva da specchio alla sua tristezza. Era triste, erano tristi entrambe.
Vide il proprio volto riflesso nello specchio del finestrino: quei lineamenti sfuocati e imprecisi confermavano la propria tristezza, prima solo dubitata ma ora percepita acutamente.
Era la tristezza della donna che le stava seduta di fronte che certificava la sua propria tristezza, le dava spessore, la rendeva inevitabile.
Verde, azzurro, azzurro, azzurro, verde, azzurro, verde.
Non aveva ragione quella tristezza, nessuna giustificazione plausibile, almeno per lei.
Forse era quella signora lì di fronte a lei che se l’era portata appresso. Era entrata zitta zitta, le si era seduta davanti per intristirla, per infettarla con quella malinconia amara.
Azzurro, verde, verde, verde e ancora azzurro.
Non voleva guardarla più in faccia quella donna, perché se avesse permesso al proprio sguardo di soffermarsi un attimo di più, quella malinconia si sarebbe levata improvvisamente davanti a lei, spaventosa, esigendo di essere nominata. Voleva inchiodare gli occhi a quegli alberi, al tronco, alle foglie solo intraviste, per non lasciare che la tristezza le si rovesciasse addosso. Perché certi virus, se non li contieni, si prendono tutto e allora non bastano più il verde e l’azzurro. Allora nulla può salvare.
Ma fuori cominciava a far buio, il cielo continuava a correre veloce, i contorni delle cose ora si distinguevano a malapena e cominciavano lentamente a scomparire. Impossibile appendere lo sguardo alla chioma di un albero per sfuggire a quegli occhi interminabili, a quella spenta tristezza.
Il tempo rallentava, mentre il treno non smetteva di correre e suoi pensieri storti e ansiosi sollevavano un gran fracasso dentro di lei. Le si era screpolata la bocca e aveva preso a mordersi ritmicamente il labbro inferiore per attutire il rumore dei pensieri.
L’assalì il dubbio che la meta di quel viaggio potesse essere quell’incontro, imbattersi nella profondità della malinconia che s’infila nell’anima e che vi s’annida, perdersi nell’uragano senza bussola. E il fiato le si fece corto di botto.
Pensò di rompere l’incantesimo e di parlarle, di chiederle conto di tutta quell’angoscia, di quegli occhi persi, di tutto quel vuoto che ci si intravvedeva dentro, del troppo spazio che quel corpo sembrava ospitare
Ma non sono domande da farsi a un’estranea, e spesso neppure a una cara amica.
Però, forse il treno potrebbe essere un porto franco – pensò – un luogo estraneo in cui concedersi a chi non si vedrà mai più. In certi romanzi succede che due persone sconosciute s’incontrino e si scambino segreti indicibili, mettano sul piatto dolori profondi senza ritegno.
Fu tentata di suggerirle una cura, o meglio degli strattagemmi per sfuggire alla malinconia, gli stessi che lei frequentava abitualmente e che la tenevano in vita: una corsetta, o una passeggiata in montagna, qualche parola buttata giù su un foglio bianco. Ma lo sguardo di quella donna comunicava una disperazione che andava oltre ogni possibile terapia, come se già lei avesse frequentato tutte le possibilità ed ora si trovasse al capolinea, lì dove niente può salvare, lì dove ci si può solo lasciare invadere dal nulla.
E, come in preda alla febbre, spostò lo sguardo dal riflesso del suo volto nel finestrino al viso dell’ospite inattesa e, contro la sua stessa volontà e contro ogni buon senso, cominciò a raccontare.
Furore di John Steinbeck
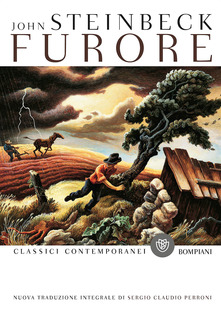
John Steinbeck, Furore, Bompiani 2013 (pp. 633, euro 12)
Della letteratura americana, in questi anni, mi hanno appassionato soprattutto le autrici: Flannery O’Connor, Joyce Carol Oates, Edna O’Brien, Elizabeth Strout. Steinbeck l’avevo letto ai tempi della scuola, ma poca cosa.
Su insistenza di mia figlia e di mio marito ho affrontato le seicentotrentatre pagine, un po’ per metterli zitti, un po’ perché non avevo null’altro in casa. E, fin da subito, mi ha travolta, mi ha tenuta incollata al racconto senza possibilità di fuga.
L’incipit è un’apparente descrizione naturalistica, attenta e minuziosa: Sulle terre rosse e su una parte delle terre grigie dell’Oklahoma le ultime piogge furono leggere, e non lasciarono traccia sui terreni arati.… Il sole prese a picchiare giorno dopo giorno sul mais in erba, fino a screziare di bruno gli orli di ogni baionetta verde… Il suolo si ricoprì di una crosta dura e sottile, e man mano che il cielo impallidiva, anche il suolo impallidiva, facendosi rosa nelle terre rosse e bianco nelle terre grigie.
E sotto il sole che ogni giorno picchiava più forte, le foglie del mais in erba si facevano meno rigide e dritte; dapprima s’inarcarono appena, poi, con l’indebolirsi della nervatura centrale, ogni foglia si piegò decisamente all’ingiù… L’aria era fina e il cielo sempre più pallido, e ogni giorno la terra impallidiva… Il vento si fece impetuoso, s’infilava sotto le pietre, scalzava paglia e foglie morte, perfino piccole zolle, creando dietro di sé una scia man mano che solcava i campi.
La penuria dei raccolti, il flagello biblico delle tempeste di sabbia e della siccità, la Grande Depressione mettono in moto il grande esodo dal Midwest verso l’Ovest di migliaia di famiglie prese nella morsa della povertà e della fame.
Furore è la storia di questa gente, della loro migrazione, delle loro speranze.
L’Oklahoma, il Kansas e il Texas, tutte le pianure inaridite del Midwest e del Sud ovest si svuotano, i contadini caricano carri sgangherati di mobili, abiti, figli, genitori e si riversano sulla Route 66, direzione California, la Terra Promessa.
Steinbeck affida il racconto di questa grande fuga a due diversi registri: il gergo degli “Okies”, il termine dispregiativo con cui venivano chiamati i migranti provenienti dall’Oklahoma, utilizzato per raccontare la vicenda della famiglia Joad, si alterna a capitoli di contestualizzazione storica. Anche in queste righe la scrittura resta lontana da ogni ideologismo, semplice, quasi colloquiale eppure estremamente incisiva.
Riesce, con parole secche, con descrizioni crude a rappresentare una realtà complessa.
Su entrambi i piani, si percepisce un ritmo biblico da fine di un’era. Una fine annunciata, un disastro che si legge in ogni riga: questa gente non ha speranza, la Terra Promessa sarà sfruttamento, condizioni di lavoro e di vita disumane, a tratti incompatibili con la sopravvivenza.
Negli accampamenti in cui si affollano famiglie sfollate, bimbi affamati che giocano fra le baracche si snodano le relazioni umane e si delineano personaggi chiave. In tutti, in qualche modo, non si può che identificarsi, percepire in loro qualcosa che ci appartiene.
L’ex predicatore Casy, che non crede più nella colpa e che, come Mosè, accompagna il popolo dei derelitti in questa migrazione senza futuro. Racconta la sua crisi e l’abbandono della predicazione, per la forza delle tentazioni della carne, per i dubbi su Dio e sullo Spirito Santo: Ho pensato, magari sono tutti gli uomini e tutte le donne che amiamo: magari è questo lo Spirito Santo… lo spirito umano… tutta la baracca. Magari tutti gli uomini messi insieme fanno una grande anima e ognuno di loro è un pezzettino.
Tom Joad, appena uscito di galera, che matura in sé il seme della solidarietà di classe, mentre la fame e la paura partorivano rabbia.
La madre, donna invincibile, collante della famiglia sua e di altre, quella che infonde speranza, che apre spiragli, che abbatte barricate e che, nel lungo cammino, accompagna gli anziani alla morte e i piccini sulla soglia della vita. E poiché marito e figli non potevano conoscere sofferenza o paura se lei non denunciava sofferenza e paura, aveva imparato a rinchiudere l’una e l’altra dentro se stessa.
Questo grande romanzo evoca una condizione umana di incredibile attualità; leggere di quegli anni di un altro secolo, è leggere di oggi, della moltitudine di esseri umani costretti a lasciare la propria terra, che vedono le loro speranze infrangersi contro muri di odio. Le parole di Steinbeck insegnano oggi forse più di ieri a cuori induriti dalla collera, dal rancore e dalle prevenzioni.
E sciamavano in cerca di lavoro; e le strade erano fiumi di gente, e i fossi lungo le alzaie erano file di gente. E altra gente arrivava dietro di loro. Le grandi arterie pullulavano di gente che emigrava…

La vita randagia li cambiò; le grandi arterie, i bivacchi lungo la strada, la paura della fame e la fame stessa li cambiarono. I figli affamati li cambiarono, l’interminabile vagare li cambiò. Erano emigranti. E l’ostilità li cambiò, li saldò, li unì; l’ostilità che induceva i centri abitati a raggrupparsi e a equipaggiarsi come per respingere un invasore, manipoli armati di manici di piccone, garzoni e bottegai armati di fucili, per difendere il mondo contro gente del loro stesso sangue. Nell’Ovest si diffuse il panico di fronte al moltiplicarsi degli emigranti sulle strade. Uomini che avevano proprietà temettero per le loro proprietà. Uomini che non avevano mai conosciuto la fame videro gli occhi degli affamati. Uomini che non avevano mai desiderato niente videro la vampa del desiderio negli occhi degli emigranti. E gli uomini delle città e quelli dei ricchi sobborghi agrari si allearono per difendersi a vicenda; e si convinsero a vicenda che loro erano buoni e che gli invasori erano cattivi, come fa ogni uomo prima di andare a combattere un altro. Dicevano: quei maledetti Okie sono sporchi e ignoranti. Sono maniaci sessuali, sono degenerati. Quei maledetti Okie sono ladri. Rubano qualsiasi cosa. Non hanno il senso della proprietà. E su quest’ultima cosa avevano ragione, perché come può un uomo senza proprietà conoscere l’ansia della proprietà? E i difensori dissero: sono sporchi, portano malattie. Non possiamo lasciarli entrare nelle scuole. Sono stranieri. Ti piacerebbe veder uscire tua sorella con uno di quelli?
Gli indigeni si suggestionarono fino a crearsi una corazza di crudeltà. Formarono drappelli, squadre, e li armarono: li armarono di manici di piccone, di fucili, di gas. Il paese è nostro. Non possiamo lasciare che questi Okie facciano i loro comodi. E gli uomini che venivano armati non possedevano la terra ma pensavano di possederla. E i garzoni che di notte facevano a ronda non possedevano nulla, e i piccoli bottegai possedevano solo debiti. Ma anche un debito è qualcosa, e anche un salario è qualcosa. Il garzone pensava: io prendo quindici centesimi a settimana; che faccio se un maledetto Okie si accontenta di dodici? E il piccolo bottegaio pensava: come la reggo la concorrenza di uno che non ha debiti?
E gli emigranti sciamavano per le contrade, e nei loro occhi c’era la fame, e nei loro occhi c’era il desiderio. Non avevano discorsi, non avevano criteri, non avevano altro che la loro quantità e il loro bisogno. Quando c’era lavoro per un uomo, dieci uomini lottavano per averlo – e la loro unica arma era il ribasso di paga. Se quello lavora per trenta centesimi, io ci sto per venticinque…
E le strade pullulavano di gente assetata di lavoro, pronta a tutto per il lavoro….
Le grosse imprese non capivano che il confine fra fame e rabbia è un confine sottile. E i soldi che potevano servire per le paghe servivano per fucili e gas, per spie e liste nere, per addestrare e reprimere. Sulle grandi arterie gli uomini sciamavano come formiche, in cerca di lavoro, in cerca di cibo. E la rabbia cominciò a fermentare.
È una rabbia che si sente incalzante in ogni riga, una marea montante, una marcia umana disperata che fa tornare in mente Erri De Luca quando scrive: le persone quando diventano popolo fanno impressione.
Indimenticabili le parole con cui Tom si congeda dalla madre: io ci sarò sempre, nascosto e dappertutto… dove c’è qualcuno che lotta per dare da mangiare a chi ha fame… dove c’è uno sbirro che picchia qualcuno… sarò negli urli di quelli che si ribellano.
Un libro da leggere e da rileggere. Un libro che mi resterà appiccicato addosso.
Il partito preso delle parole .4
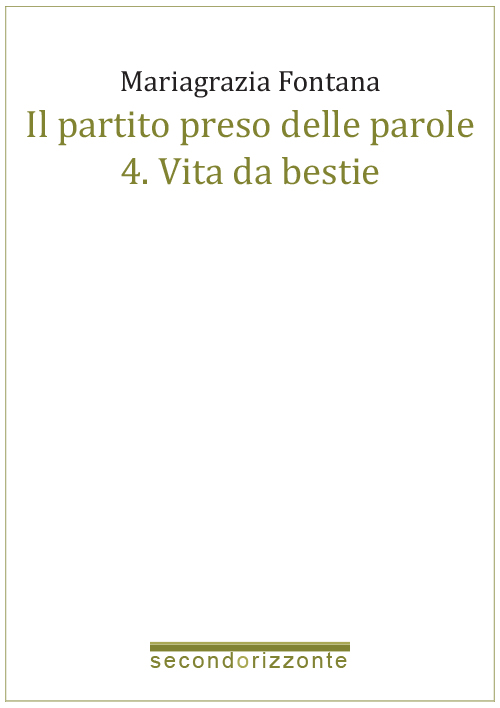
4. Vita da bestie
Per un paio di sere, della biondina neanche l’ombra. E lui, il capo, quello che tanto chi se ne frega, c’è rimasto male non poco. Dentro di sé ci contava di rivederla, anche se piuttosto di ammetterlo si sarebbe fatto tagliare le mani. Io però lo osservavo: puntava la porta con la coda dell’occhio e, ogni volta che entrava un vecchio, gli angoli della bocca gli si torcevano in una smorfia di delusione. E intanto ci beveva sopra.
E sì che sembrava non fosse andata del tutto male l’altra notte. Lui, il capo, il coglione, alla fine s’era salvato e non aveva fatto una pessima figura. All’inizio sì, aveva proprio esordito da schifo, con quelle parole grosse, con quel tono di uno che si scrolla la fortuna di dosso. Come se ne avesse tanta di fortuna! Chi lo guardava mai? Chi gli parlava? E lui che diceva che andava bene così, che parlare non serve, che sono tutte stronzate.
Con me però sì che ci parlava, anche se sono solo un cane, e me la raccontava di diritto e di rovescio. Magari non grandi verità, non era uno che sapeva guardarsi dentro, per quello non aveva i numeri. Solo lei aveva provato a condurlo per mano dentro se stesso, ma lui neanche a parlarne. Faceva la voce grossa, ma aveva paura delle parole, soprattutto delle sue. Forse temeva di non trovare niente dentro di sé, che tutto quel niente gli avrebbe dato la vertigine. E non era vero che dentro aveva il vuoto. Io lo sapevo bene. Non occorre essere umani per capire le cose, anzi alle volte l’umanità è un inciampo, con tutti i ragionamenti che gravano in testa ai bipedi. I cani scoprono le cose per altre vie, e le intuiscono bene.
A volte basta misurare il peso di una carezza sul pelo del dorso per saggiare la piega dell’umore, i grovigli del cuore che la muovono.
Quando lui non usciva di casa erano veramente guai, perché era garantito che si attaccava alla bottiglia, da solo. E se beveva solo, la questione era seria.
Meglio che bevesse in compagnia, anzi, sarebbe stato meglio che non bevesse affatto, ma era così infelice. Come reggere il tam tam feroce del silenzio senza una birra? Io lo so bene, anch’io a giorni mi lascio contagiare da quel grigio piombo, ma a me l’alcol lui non lo lascia bere. Ci vuole almeno uno sobrio in famiglia.
E’ la famiglia che gli manca, quella donna e anche quel bambino di prima che si è lasciato soffiare come un pollo. Perché è un vero coglione. Che cosa ci voleva a mettere in fila qualche parola per farla contenta? Mica ti pungono le parole. Certo le devi scegliere con cura, alcune è meglio schiumarle prima di buttarle fuori, altre andrebbero limate e poi pronunciate bene per non deformarle con la fretta o con l’ira.
Invece il tenore delle sue frasi aveva sempre un impeto d’urgenza, come sparasse proiettili, come dovesse espellere in fretta un grumo schifoso, come se si soffiasse forte il naso. Quello sbruffone spariva nelle parole, di fronte alle parole misurate di lei, ben ponderate e corrette, lui andava al tappeto. E’ che diffidava delle parole, ci vedeva un che di furbesco, di ammaliatore, di promessa non mantenuta.
Ma gli restavano i gesti, magari un fiorellino. Mica gliele potevo insegnare io queste cose.
Una volta ci ho anche provato, l’ho portato davanti alla vetrina di un fiorista e lì mi sono inchiodato, seduto, fisso come una statua. Ma lui niente, non capiva. Allora, a casa, mi sono ingessato davanti all’aiuola del giardino, che lì di fiori ce n’era a bizzeffe. Non avrebbe neanche dovuto scucire della grana, sarebbe bastato allungare una mano, raccogliere delle margherite, dei tulipani, farne un mazzetto per portarsi a casa una bella figura. Invece niente, non capiva proprio i fondamenti. Lo sanno tutti che le femmine le devi trattare bene, che con quattro moine te le compri. E invece lui a fare il duro, con lei e con il piccolino.
Era per il piccolino che mi spiaceva di più. Lei si sapeva difendere, ma il bambino si faceva ancora più piccino quando lui alzava la voce: a volte si faceva addirittura pipì addosso.
E io me lo sarei morsicato, anche se era il capo, gli avrei volentieri addentato una caviglia per spiegargli che i bambini non devono avere paura, che a loro si deve dimostrare di volere bene. Basta poco, una carezza, una leccatina, un abbraccio, una passatina contro pelo e loro sono felici. Perché i piccolini si fidano del padre.
E invece lui a pontificare, a fare il vocione, a puntare il dito, a dettare le regole. E il piccolo a frignare.
A me il bambino lo diceva, magari non con le parole, ma la sentivo la sua mano tremante, il cuore che andava a mille, il viso pallido e smunto. Quel bambino si era convinto di non valere niente, di essere uno da poco. E non era proprio vero, era un bravo bambino, timido ma sveglio, uno con il cuore grande. Certo era un bambino di poche parole, aveva preso dal vecchio forse.
Quando l’hanno mandato via, al vecchio sono rimasto solo io.
E’ allora che ho cominciato a capirci qualcosa in quella testa matta. Camminando ore e ore con lui, dormendo con lui nelle lenzuola sudate, mangiando con lui, ho visto che non era poi così male, era solo incastrato dentro di sé, in tutto quel freddo che gli si era annidato dentro.
Si sarebbe dovuto trovare qualcosa, un piede di porco, una chiave, un grimaldello, per aprirgli il cuore al coglione, che un cuore ce l’aveva, ed era un cuore grande. E dentro non era secco, ci passavano un sacco di sangue, di dolore e di tristezza, ma anche di cose buone, di quelle che servirebbero a qualcosa, se uno sapesse di averle. Ma lui, che non è uno sveglio, non lo sapeva. E me non mi comprendeva, perché leccargli le mani, mordicchiargliele, zampettargli al fianco, tirarmelo dietro in una corsa non gli faceva capire niente. Non c’era verso, non capiva proprio.
Ci voleva un umano, meglio una donna. Le donne ci sanno fare con queste cose interiori, con le emozioni, con i sentimenti, con il vangare il passato per mettere su un futuro. Ma quale femmina si avvicina a uno che si lava poco o niente, che tiene la barba incolta, i capelli spettinati e unti e il fiato che puzza di birra? A uno che non sa neanche se è giorno o se è notte, che mangia quando capita, che perfino io mi devo arrangiare da me? A uno che può sopravvivere solo sbronzo marcio, che se no gli tocca pensare e fare i conti, e alla fine la cifra che ne risulta è meno di zero?
Siamo rimasti così, soli per anni, che neanche a me nessuna si avvicinava più, perché lui non ci pensava neanche a lavarmi, a darmi una spazzolata al pelo, che anch’io ormai sembro un randagio.
Certo, non sono un cane di razza, non ce l’ho il pedigree.
Ma poi che razza e razza? Razza canina non dovrebbe bastare? E guardate che spalle, che zampe. E che dire della coda, non una di quelle corte e tozze, ma una coda lunga che svetta verso il cielo, una coda da sangue blu. Che, a dirla tutta, di spasimanti ne ho a bizzeffe, anche quelle signorine gne gne, quelle con la genealogia, mi vedono e lo capiscono subito che, razza o non razza, io ho carattere, ho carisma, sono uno che ammalia e mantengo sempre le promesse.
Così però non mi piaccio, ero più bello quando lei mi lavava in cortile, quando il bambino mi asciugava con il panno morbido e ruzzolavamo sull’erba, e lui sembrava un poco felice.
Ma almeno io dovevo restarci con quel rudere d’uomo, che sembra una lattina vuota buttata sulla spiaggia dalla marea. Se lo mollavo io avrebbe deragliato di certo, o al massimo sarebbe finito su un binario morto.
Diciamo che gli ho salvato la vita non una volta sola, all’ubriacone. E’ che mi dispiaceva, perché è coglione, ma in fondo è un buon diavolo, uno che se gli si dà una buona occasione magari ci riprova.
Gli ho cercato anche una morosa. Ho fatto il cretino con un paio di squinzie carine, di quelle che avrebbero potuto piacergli. Ma lui non mi aiutava affatto, avrebbe almeno dovuto dire due parole, fare un sorriso, tirare fuori una di quelle battute che le fanno ridere. Che quando una femmina ride, è quasi cotta. E invece niente, zitto come un pesce, testa bassa, passo lungo e via andare.
Non potevo fare di più, ho la coscienza a posto. Per essere una bestia ho fatto anche troppo. Che con lui ho vissuto proprio come una bestia, come uno di quei cani rognosi che non sono proprio di nessuno. E’ che non ci riuscivo a mollarlo. Non che mi fossero mancate le occasioni, un paio di cagnette coi fiocchi le ho pure incrociate. Una poi… non era di razza, ma che sguardo, che zampe tornite, che coda arruffata da farti svenire. Ci ho pensato a squagliarmela, ad andare dietro alla bella che mi faceva gli occhi dolci, che ci guadagnavo di certo. Ma non ho avuto cuore a mollarlo. E’ che mi hanno tirato su così, responsabile e serio, uno che il padrone non lo molla nella merda.
A un certo punto ho smesso di tentare, non facevo niente, non c’era più niente che potessi fare, le avevo provate proprio tutte. Mi limitavo ad esserci, a portarlo fuori a fare quattro passi, a incitarlo a correre un po’ per sgranchirsi le ossa.
A tenerlo lontano dall’alcol non c’era neanche da pensarci. Non sarebbe stato in piedi, si sarebbe sgretolato, sciolto in una pozzanghera. Lo sapevo, era ormai quasi trasparente per me, gli vedevo attraverso, gli sentivo i pensieri, gli leggevo nel fegato grosso.
Lui a me però ha sempre voluto bene, così come è capace, con le sue quattro parole in croce me l’ha detto più di una volta, poi con le carezze, con quegli occhi sghembi sempre umidi. E magari frignasse un po’ che gli farebbe bene, non spreme una lacrima neanche da ubriaco, come se avesse perso il sacco del pianto.
Io che lo conosco bene, l’ho capita la sua verità: è un cucciolo, un cucciolo grande e grosso, un cucciolo coglione, rabbioso, che sbraita a sproposito, ma sempre un cucciolo indifeso, più indifeso di tutti. Quando lo annuso la sento quella cosa impercettibile, che indietreggia sotto il risentimento, in quel cuore troppo gonfio. C’è, sono sicuro che c’è qualcosa di buono, che se qualcuna ci prova ad infilargli una mano in gola, ad abbassargli i toni e regolargli le corde vocali, qualche parola non dico dolce, almeno buona, la pesca di sicuro. E finalmente gli va in frantumi il silenzio.
Questo io alla biondina glielo ho detto subito, perché avevo capito che poteva essere quella giusta. E lei, che non è scema, ha afferrato il concetto al volo e gli si è fiondata addosso con il suo bagaglio di parole un po’ allegre, un po’ tristi, ma dirette al cuore.
Lui come sempre, all’inizio si è fatto prendere dal panico, quelli che urlano o abbaiano forte sono i più fifoni, lo sanno tutti. Addirittura la voleva mandare via, il cretino, che una così non gli capita più. Poi, sa Dio come, s’è ravveduto, il cervello ha ricominciato a carburare, il cuore s’è smollato un poco, e finalmente l’ha baciata. Dimmi tu che cosa ci voleva?
L’importante è che l’abbia fatto. Adesso stiamo a vedere. Speriamo che non faccia altre cazzate e che lei abbia pazienza, tanta pazienza. Così va bene anche a me, che magari mangio di più e qualcuno mi dà anche una lavata.
Lei alla fine s’è intenerita e l’altra sera al bar c’è tornata, merito delle quattro cose che le avevo detto e che, a dirla tutta, lo dipingevano anche meglio di quello che è, di sicuro di quello che sembra. No, non l’ho imbrogliata, ho solo zuccherato le parole come si fa con il bordo dei bicchieri quando si preparano certi cocktails. E il limone non ce l’ho messo.
Stanno bene insieme. Loro non lo sanno, ma io li studio, corro avanti, poi mi giro a osservarli. Lei è uno scricciolo e lui un gigante raggrinzito, ma va bene così, si compensano.
Questa sera poi, c’è una luna chiara che imbianca i muri, e i suoi crateri si vedono così bene, che perfino un umano sbronzo una faccia non può non vedercela. L’aria è così tiepida che sembra festa. E, chi l’avrebbe detto, lui ha anche vomitato qualche parola, addirittura mezze frasi. E non ce l’ha più quell’espressione selvatica di uno che la vita l’ha lasciata sgocciolare via.
Forse racconta qualcosa, forse gli è tornato in mente il bambino pallido che ha nel cuore. E, da non credere, il coglione ha accennato un mezzo sorriso e l’ha presa per mano.
Il partito preso delle parole .3
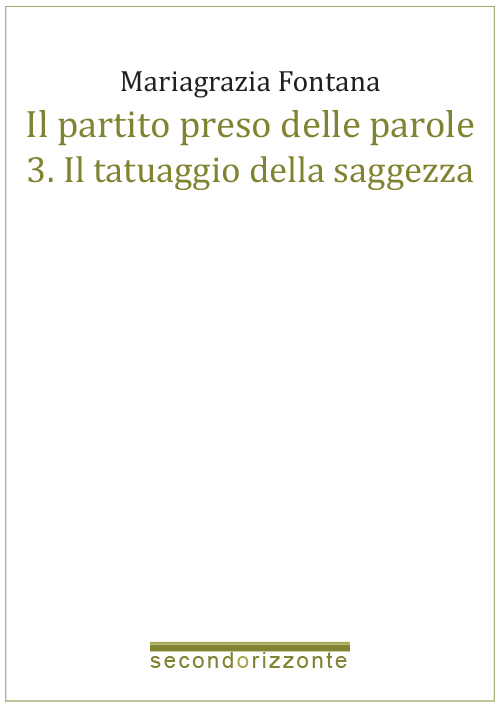
3. Il tatuaggio della saggezza
Sei in ritardo, non è che stanotte ti sei data alla pazza gioia? – le chiede Paola con quel sorrisetto malizioso di una che sa bene come si sta al mondo. Gioia non proprio, diciamo che non è andata malissimo – le risponde Angela, il viso struccato e pallido.
Lavorano insieme da anni e, si sa, lavorare gomito a gomito, inspirare lo stesso vapore, sopportare il peso del ferro da stiro professionale, sudare insieme facilita la confidenza e si diventa un poco amiche.
Le donne poi non ci mettono molto a sbottonarsi, a raccontare tutti i fatti loro. Sembra che non vedano l’ora di vuotare il sacco, come se a nominarle, le cose si facessero più lievi. Anzi a volte le ammorbidiscono loro intenzionalmente, ci mettono quel dolce che fa romantico e che nei fatti, nudi e crudi, non c’era proprio.
Dimmi che questa volta non è uno dei soliti sfigati, ti prego. Dimmi che è un ragioniere, un commesso, almeno un benzinaio – chiede Paola, che da anni spera in cuor suo che Angela si dia una mossa, che esca da quel pantano di tristezza, di svogliatezza in cui è sprofondata. Se la vede sfiorire davanti lentamente, senza piangere, senza lamentarsi, senza mettersi contro una vita che va storta da tempo, incapace di sintonizzarsi sulla frequenza dell’ottimismo.
E lei a spingerla, a tenerla su, a ripeterle che ha chance da vendere, che solo non sa vederle, come se non volesse darsi un futuro. Ma le parole, quando una è a quel punto, sono vento che corre senza lasciare traccia. Magari a forza di ribadirle, almeno un’eco nella testa di Angela sarebbe rimasta – si ripeteva Paola che non riusciva a smettere di provarci.
Un tempo era diversa, era una ostinata, una da bicchiere mezzo pieno. Di legnate ne aveva prese parecchie, ma aveva sempre rialzato la testa, orientando il corso dei suoi pensieri verso il meglio. Poi, a un certo punto, s’era afflosciata come un budino tremulo, le fibre del suo cuore s’erano fatte fragili, come se nella sua vita interiore si fosse esaurita la speranza. Aveva cominciato ad accompagnarsi solo con sbandati, con gente che bivaccava ai margini dell’esistenza. Cattivi no, solo pieni di guai, di garbugli che lei s’ostinava a provare a dipanare. Come se i suoi guai non fossero sufficienti!
Un intellettuale non è di certo, neanche un impiegato, mai visti impiegati così mal ridotti.
E rieccoci con un altro perdente, chi te lo fa fare di metterti sempre con uomini sconfitti dalla vita? Mica li devi salvare proprio tutti tu – ribatte Paola cui si srotola davanti un film già visto, destinato a un finale da schifo.
Non è che Angela li scegliesse apposta gli uomini tormentati, è che ne era attirata come un’ape da un fiore, è che le sembravano gli unici con un po’ di fascino.
Che cosa se ne sarebbe fatta di uno sbruffone, di un vincente sicuro di sé, di quelli che ti pagano la cena in un bel ristorante e ti fanno fare la bella vita? Che poi uno così, mica avrebbe perso tempo con una come lei, che di lavoro stirava, che non poteva neanche farsi crescere le unghie perché le si spezzavano maneggiando i panni, che aveva i capelli sempre crespi per via di tutto quel vapore.
In realtà uno buono ce lo aveva pure nel suo curriculum, uno per bene, intelligente, ma senza il becco di un quattrino. Allora si era offerta lei di lavorare per due, di prendersi anche i turni di notte all’hotel di suo cognato che venivano pagati bene, e un poco riusciva anche a dormire.
Così stirava di giorno e lavorava alla reception di notte, intanto che lui si impegnava a finire l’università. Era una buona causa, e poi lui era così bello, così dolce, e la trattava come una regina. Era durata quasi quattro anni la faccenda del doppio lavoro e lei non l’aveva fatta pesare mai, perché lui gli esami li passava, studiava e non si perdeva in chiacchiere.
Si trattava di tenere duro solo qualche anno, poi lui si sarebbe laureato, avrebbe trovato un posto come ingegnere con uno stipendio dignitoso, e lei si sarebbe riposata. Magari avrebbero anche messo su famiglia, casa con giardino e pure un paio di figli o tre, che a lei i bambini piacevano un mondo.
Era andata diversamente, ovviamente. Non perché lui dopo la laurea l’avesse mollata, non si era montato la testa e la gratitudine non gli era mancata. Era stata lei ad andarsene, come se si sentisse fuori posto al fianco di un laureato che indossa camicia e cravatta.
A decidere era stata quella storia della gravidanza che aveva rotto l’incantesimo. Lei il figlio l’avrebbe tenuto, non le sembrava vero, mettere al mondo un altro essere umano, fare qualcosa di buono, di indiscutibilmente buono. Che cosa c’è di meglio, di più di una vita?
Era lui che non si sentiva pronto, diceva che era presto, che ora lui avrebbe dovuto pensare al lavoro e alla carriera, che lei avrebbe dovuto avere pazienza. Ma lei la scorta della pazienza l’aveva esaurita da tempo e quel figlio lo voleva. Certo non l’aveva cercato, ma se era arrivato voleva dire che andava bene così, che era ora. E lei si sentiva pronta, pronta e felice.
Alla fine era andato tutto storto. La sua versione dei fatti era che il bambino, anzi quel grumo di cellule che sarebbe potuto diventare un bambino, si fosse sentito mal accolto, che avesse capito che era solo lei a volerlo, mentre lui, il figlio, li voleva tutti e due, un padre e una madre. Allora s’era sciolto in un flusso di sangue e in una decina di contrazioni dolorose.
Non era riuscita a perdonarlo, non aveva avuto la pazienza di aspettare, di riflettere, perché lei dentro lo sapeva che era stato lui a mandare via il bambino, che se ci avesse provato solo un poco, magari il piccolo si sarebbe lasciato convincere a venire al mondo. E poi ci avrebbe pensato lei, non avrebbe chiesto niente, gli avrebbe lasciato tutto il tempo per il suo lavoro e la sua carriera. Che in fondo c’era da capirlo, tanto studio per poi non farne niente, non c’era neanche da pensarlo.
E’ che sotto l’ingegnere non c’era più il ragazzo che lei aveva amato, quello che un figlio l’avrebbe tenuto caro. Ora s’era fatto serio, sempre concentrato su qualcosa. Niente sorrisi, di ridere poi non se ne parlava. Forse gli uomini, quelli responsabili, sono fatti così. Forse per lei andavano bene solo i ragazzini o gli spiantati. Perché a lei ridere piaceva proprio, soprattutto la sera quando era sopraffatta dalla stanchezza, aveva voglia di aprire un’ultima parentesi d’allegria nello sfinimento quotidiano.
Una mattina, dopo che lui era uscito per il lavoro, lei aveva raccolto i suoi quattro stracci e se n’era andata, così, senza parlarne, senza provare a ricucire, senza lasciare due righe.
Da lì in poi, o era rimasta sola o s’era accoppiata solo con perdenti, gente senza speranza, da tenere a galla. E lei era un portento nel dare aiuto, e non solo agli uomini.
C’era sua madre che invecchiava e aveva sempre più bisogno che qualcuno le facesse la spesa, le pulisse la casa e la stesse a sentire.
Quando la guardava attraverso la pellicola gelatinosa che le velava le iridi, Angela non aveva scampo, si rimboccava le maniche e ci dava dentro con scopa e straccio.
Poi c’era il figlio di sua sorella, quello piccolo, che aveva qualche problema, non era ben chiaro quale, ma non imparava né a leggere né a scrivere. Era Angela che passava le serate a farlo scrivere e riscrivere, a leggergli fiabe, perché sua sorella ne aveva altri due di bambini, e questo quasi non lo voleva vedere, così tonto.
Era la fatica a dar forma alle sue giornate, un mattoncino sopra l’altro, fino a tirare sera.
Quest’uomo, quello della sera precedente, con capelli e barba rossicci, non si smarcava dal prototipo in uso. Era uno con la sconfitta alle calcagna.
Abbigliamento assemblato a casaccio, occhi reticenti, graffiati dalla delusione, fra l’impaurito e il malinconico e quegli scatti di repentina impazienza, come fosse stato scoperto, come se qualcuno avesse squarciato la cortina dei suoi pensieri. Poi subito una conchiglia chiusa, serrata nella morsa di uno sguardo duro, dell’istinto atavico di difesa del territorio.
Ma quegli occhi celesti lasciavano trasparire un bagliore particolare, qualcosa che lei aveva intravvisto solo per un istante. Poi, lui aveva distolto lo sguardo nervoso, come spegnendo una luce in fretta e furia.
Certo aveva capelli e barba rossi, e il rosso si sa, non porta niente di buono.
E la casa, che desolazione: un materasso, una sedia, un’asse su due cavalletti come tavolo, niente armadio, vestiti accatastati ovunque, puliti e sporchi insieme. Non un quadro, nemmeno un poster alle pareti, i vetri dell’unica finestra resi opachi dalla pioggia e dalla polvere di anni.
C’era di buono il cane, lurido pure lui, ma bello, educato, con l’aria sveglia di uno che capisce. Gli occhi un poco obliqui lo facevano sembrare triste, o forse era solo intelligente, più intelligente del rosso silenzioso. Cenciosi erano cenciosi tutti e due, magari a stare insieme si finisce per assomigliarsi.
Alla fine è stato gentile – raccontò a Paola, come per salvarlo dentro di sé.
Non fece parola della dolcezza, di quell’infanzia che gli si leggeva sotto pelle, di quello sguardo in cui pareva di annegare, di quelle lacrime spremute dal suo abbraccio che lui continuava a chiamare sudore, del suo accarezzarla senza fretta, senza pretese, come fosse l’unica cosa che gli importasse fare. Era un uomo che parlava con gli occhi e con i gesti, non con le labbra che non sapevano scollarsi per articolare parole. Rifuggiva le parole come la peste, come se le parole avessero preso partito contro di lui, come se gli corressero incontro imbracciando un moschetto per stanarlo, come fossero state loro, le parole, a mandargli a gambe all’aria l’esistenza. Sembrava avesse la testa ricolma dei cocci delle parole, di sillabe pensate e mai proferite.
Eppure un centro doveva averlo pure lui in quell’arcipelago di frasi smozzicate, di sentimenti sbandati, in quell’odore di selvatico, in quel dormire agitato come vela sbattuta dal vento.
Gliele avrebbe insegnate lei le parole, lei che, con quello giusto, poteva parlare per due, lei che sapeva scovare nel cesto del vocabolario quelle che colpiscono nel segno, che affondano il coltello, e poi quelle che addolciscono, che consolano, che aprono spazi.
E poi non si parla solo con le parole, ci sono messaggi, dichiarazioni, pensieri profondi che si mutano in sguardi, carezze silenziose, gesti imprevisti.
Angela non aveva dubbi, aveva ricevuto il segno, quello che non mente: quando l’aveva visto, le spalle curve, una faccia che promette solo guai, la birra che gli galleggiava nel sangue, lei aveva sentito le farfalle nello stomaco.
Solleva quella manica, tira su la maglia e fammi vedere quel tatuaggio – le chiese con voce imperiosa Paola. Che cosa mi avevi detto che significava questa roba cinese o giapponese? Saggezza, mi sembra. E dov’è questa saggezza nella tua vita se continui a cadere dallo stesso gradino, se ripercorri lo stesso tratto sempre con lo stesso passo da vittima? Perché mi viene il dubbio che tu stia bene nella parte della vittima, che ti piaccia sanguinare.
Angela non rispose, non sapeva cosa dire.
Forse Paola aveva ragione, forse lei si ostinava a soffiare su tizzoni spenti?
Ma come uscire da se stesse? Non è che quando sai che sei fatta male, ti puoi rifare da capo. Sei così e basta. E non ti difendi da te stessa, magari ti lecchi le ferite, ti dai dell’idiota da sola, ma poi ricominci le tue giornate male, come sei capace. Tiri la carretta al lavoro, pulisci la casa di tua madre, cerchi di volere bene al tuo nipote svergolo e ti innamori dell’uomo sbagliato, ammuffito dentro, e ti condanni all’infelicità.
Eppure, nel profondo, lei in quel rosso ci vedeva qualcosa, ci sentiva un humus fertile, una possibilità. Probabilmente era sempre così all’inizio di una storia, lei ci immaginava quello che non c’era affatto, ce lo metteva. Perché era dell’amore che lei era innamorata, anche se un uomo che valesse la pena di amare davvero ancora non l’aveva incontrato, perché forse gli esseri umani non possono essere all’altezza dei sogni. E lei non smetteva di sognare come un’adolescente, sognava un amore magari non perfetto, ma quasi perfetto, uno di quelli in cui non devi fare la piega, in cui c’è molto del tutto che vorresti.
Non ci sarebbe ritornata quella sera al bar del quartiere. Non c’era da dargli troppa biada al rosso. Doveva starsene da solo, con il suo cane, aspettarla, girare il capo ogni volta che s’apriva la porta, nella speranza di vederla entrare e poi deglutire amaro. Doveva berci sopra alla sua assenza, assaporare il desiderio e la mancanza.
Gli avrebbe dato due sere libere, poi sarebbe ricomparsa. Si sarebbe truccata come si deve, avrebbe indossato gli orecchini e i bracciali della fortuna, quelli che allargano i campi di forza del destino, si sarebbe seduta al tavolino in fondo, avrebbe ordinato un caffè macchiato e l’avrebbe aspettato.
Lui non avrebbe mollato, i suoi occhi sfuggenti non l’avrebbero omaggiata con uno sguardo, lo sapeva, troppo coraggio ci voleva per ingarbugliarsi l’animo. E lui il coraggio l’aveva smarrito. Magari l’avrebbe raggiunta il cane e lui, con la scusa di riprenderselo, si sarebbe avvicinato come un sughero che galleggia in acque agitate, il volto infarinato dall’imbarazzo.
Eccoci qui – beh sì – già. Le parole erano troppo grandi per lui, gli andavano larghe, forse perché aveva solo silenzio nelle vene.
Allora sarebbe toccato a lei invitarlo a sedersi, gli avrebbe offerto una birra e gli avrebbe raccontato la sua giornata, così, per rompere il ghiaccio. Che se fosse stato per lui il silenzio sarebbe durato in eterno. Poi, come per sbaglio, gli avrebbe sfiorato un polso, forse una carezza di sfuggita. Magari lui ce l’avrebbe fatta a prenderle la mano.
Il partito preso delle parole .2
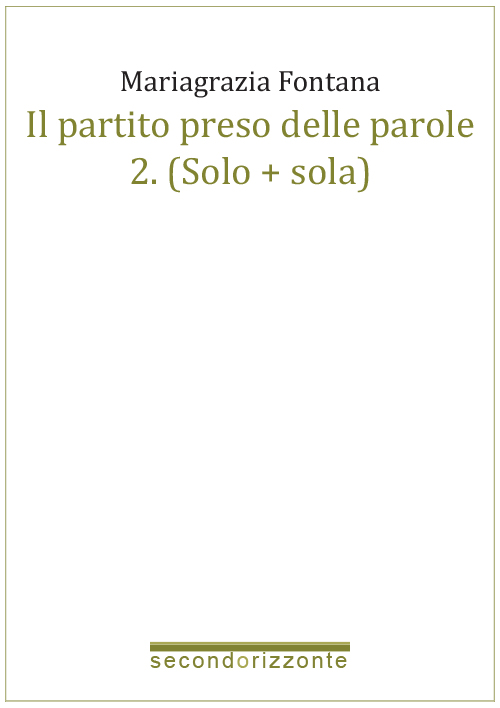
2. (Solo + sola)
Il solito sgabello nel solito bar. Era un locale senza pretese, niente happy hour, niente musica, niente macchinette mangiasoldi. Un bar di quartiere mai rinnovato, tavoli di legno segnati dalle bruciature di sigaretta, a testimoniare che per anni nei bar ci si era potuto fumare, e dalle cicatrici a cerchiettini lasciate dai calici. Sembrava pulito, anche se era tenuto un poco in penombra, forse per lasciare indefiniti i pensieri consumati, i ricordi rosicchiati dal tempo degli avventori, quasi tutti anziani, che di passato da dimenticare non mancavano.
Lui si sedeva al bancone, in uno solo non occupi un tavolo. Sceglieva l’ultimo posto, quello dove il banco aveva già fatto la curva e ci si poteva appoggiare al muro. Non aveva bisogno di ordinare: Beppe il barista, lo conosceva, anche se in verità parlati non s’erano parlati mai. Sapeva che lui beveva birra, birra da poco, per poterne ingurgitare di più.
Dick era tollerato, il barista lo lasciava accovacciarsi sotto il suo sgabello, perché sapeva che era un cane ben educato, uno di quelli che non attacca briga, che non abbaia, uno che gli basta stare con il padrone, andare dove va lui, sedersi dove lui si siede e fare silenzio quando si deve. Quel cane non lo abbandonava mai e non pretendeva gran che. Certo c’era da portarlo fuori almeno due volte al giorno, ma se proprio Franco non era in grado, Dick si arrangiava da solo. Aveva imparato ad afferrare con le zampe anteriori la maniglia della porta d’ingresso e ad appendercisi di peso fino ad aprirla per poi scendere le scale e fare i suoi bisogni nel cortile condominiale. Tanto lì erano tutti poveracci, per lo più immigrati, e alla pulizia mica ci badava nessuno.
A Franco non piaceva quella storia del cane che sgusciava da solo in cortile, hai visto mai che i cinesi del quarto piano se lo cucinavano per cena. Non hanno proprio religione quelli, per loro un cane è come un pollo. Ma certe sere non ce la faceva proprio ad uscire, era come insabbiato in una tristezza dolciastra, di quelle che ti si attaccano come la colla e ti imbrattano di grigio dentro. Altre era troppo sbronzo per reggersi in piedi e neanche riusciva a raggiungere il letto. Succedeva che si svegliasse il mattino rannicchiato sotto il tavolo della cucina, la faccia in una pozza di grappa da poco, colata dal collo della bottiglia.
Aveva cominciato a esagerare con l’alcool, poco per volta. Non che avesse deciso di imboccare quella strada, era la strada che gli si era distesa sotto i piedi da sola, prima che lui potesse realizzare, scegliere. E di bicchiere in bicchiere il tasso alcolico lievitava e ogni sera di bicchieri ce ne voleva uno di più.
La birra aveva il pregio d’invogliare al rutto, e il rutto, si sa, manda giù. E lui da mandare giù ne aveva parecchio.
Aveva deciso che non era una buona cosa bere da solo, per via di quella parola solo che gli prudeva sulla pelle. Non sarebbe diventato un vecchio ubriacone, di quelli che trovano stecchiti in casa magari dieci giorni dopo la morte, già decomposti. Allora aveva preso l’abitudine di andare verso sera al bar di fronte, lui e Dick, a bere sbirciando la strada polverosa di fuori. No, Dick non beveva di certo, anche se una volta l’aveva sorpreso a leccare del rosso che lui aveva rovesciato sul tavolo. Beppe, gli dava sempre un pezzo di pane vecchio e il cane gli faceva festa, gli leccava le mani, raddrizzava le orecchie come a ringraziare.
Era una bella compagnia un cane, l’unica di cui un uomo si potesse fidare. Un cane non pretende, al massimo butta fuori due versi a fauci spalancate per farti capire che una corsetta non gli andrebbe storta, o che un poco di cibo a riempirgli la pancia sarebbe gradito. Soprattutto un cane non parla, non ti racconta i fatti suoi e non ti chiede i tuoi, non ti dà il tormento, non ci da sotto con la rava e la fava, non ti vuole diverso da ciò che sei. Con un cane si può stare in silenzio come se si fosse soli.
Franco aveva capito molte cose sullo stare soli. Da solo s’era allenato a sopravvivere quando la nostalgia gli toglieva la forza, a blandire la collera quando gli deflagrava dentro. La sua vita si torceva giorno dopo giorno come il tronco d’un ulivo, dentro di lui il buio s’insediava e Dick stava lì, presente, silenzioso a vederlo sgonfiarsi poco a poco come una gomma bucata, senza recriminare, senza consigliare, senza pretendere.
Forse era per quello che tutti i punkabbestia avevano un cane, rognoso come loro, sporco lurido, ma accoccolato vicino, all’apparenza felice di quel poco. E loro, i punkabbestia, camminavano con il cane a fianco, mai legato per via di quell’illusione della libertà, la barba lunga, i vestiti che non si potevano guardare e dormivano per strada, cane e punk abbracciati, che quasi si assomigliavano rannicchiati nel vano di un portone. Chissà se erano felici? Chissà se spogliarsi di tutto, se ridurre la vita all’osso, a mera sopravvivenza, era meglio? Forse loro avevano capito quello che conta davvero.
Lei glielo aveva lasciato Dick, in uno slancio di generosità imprevisto che lo aveva stupito. Quella donna era così, ti buttava fuori casa e poi ti regalava il cane. Due giorni dopo quella sera dell’appostamento sotto casa con la carabina carica, si era presentata alla porta delle sue due stanze fetide, bella, luminosa, ma con un’onda di tristezza nello sguardo che lui volle interpretare come rimpianto, o forse malinconia. Forse lui cominciava a mancarle?
All’inizio gli era balenato il dubbio, la speranza che lei lo rivolesse con sé, ma era stata la frazione di un secondo. Non era da lei tornare sui suoi passi, lei era una calma, non irosa come lui, lei non s’infiammava, lei ponderava, analizzava e poi alla fine decideva. E allora era finita, quando lei si metteva in testa una cosa non gliela levava più neanche il Padreterno.
Non l’aveva invitata a entrare, non voleva esibire il suo squallore, la sua disperazione e tutta quella solitudine arrampicata sulle pareti, distesa sul pavimento sporco. Aveva con sé il cane e glielo stava consegnando. Il loro cane, quello che avevano scelto insieme al canile perché il bambino s’era fissato con il desiderio di un animale. E neanche a farlo apposta, quel bambino anemico aveva scelto il cane più pulcioso, svergolo e sgangherato di tutti quelli disponibili. Forse era la pena che lo muoveva, forse il bambino si specchiava nel cane, o forse lei l’aveva infettato con quella storia di aiutare deboli e indifesi, di non tirarsi indietro, di stare dalla parte degli ultimi. Figlio sfigato e cane sfigato, bella accoppiata.
Ma lui con lei non riusciva a farsi intendere, provava a comandare, a dire la sua, ma lei, che con le parole ci sapeva fare, lo metteva nel sacco alla svelta, squadernando delle buone ragioni che lui neanche aveva considerato. Allora lui alzava la voce, metteva in fila due frasi stitiche e le urlava fuori con impeto astioso, come se il volume potesse compensare tutto quello che non riusciva a dire.
A ben vedere, Dick era un gran cane e con lui s’era inteso subito, subito l’aveva individuato come capo branco. Almeno il cane capiva qualcosa, almeno per il cane Franco contava qualcosa. O forse era perché toccava a lui portarlo fuori la sera e la mattina presto. Era così, moglie e figlio sceglievano e lui si pascolava le grane.
Erano impagabili le passeggiate col cane, soprattutto il mattino presto. Dick cominciava a leccargli le mani già prima delle sei, e se lui fingeva di non sentire, passava ai piccoli morsi, solo un accenno, forse un avviso che se non si fosse alzato avrebbe addentato di più. Franco s’infilava una tuta, si tirava in testa il cappuccio e fuori, Dick davanti a correre, poi ad annusare tutti gli angoli e i portoni per decidere se quello era il posto giusto per farci pipì. Che non la faceva tutta insieme come fanno i cristiani, ne buttava lì un goccetto e poi ricominciava a correre. Dopo qualche minuto, eccolo pronto per il secondo goccio, e poi per il terzo. E in mezzo, fra una pipì e l’altra, aveva un gran da fare a zampettare e saltare. E gli toccava accelerare anche a lui per stargli dietro, anche se Dick aveva ben altro fiato e filava come un razzo avanti e poi indietro per vedere se Franco non si fosse perso, e gli addentava la tuta perché lui si desse una mossa, perché la città addormentata era un sogno da godersi tutto, senza rallentare, senza perdersi nei pensieri.
Lei glielo stava affidando e quel dono lo sorprendeva. Avrebbe dovuto essere imbestialita con lui per la cazzata del fucile. Invece, eccola con cane al guinzaglio, ciotola e cibo. Che avesse annusato la sua disperazione? Che lui le avesse fatto pena? E allora perché non se lo riprendeva? Perché non veniva a proporgli di riprovarci invece di liquidarlo con un cane, come se anche lui non fosse che una bestia?
Non glielo chiese, l’orgoglio impediva la domanda. E poi non avrebbe saputo come, che parole usare per farsi capire, per proporre senza implorare. Che un maschio deve conservarla la dignità. E poi c’era il brizzolato della bmw, quello con la faccia malinconica. Meglio tacere.
Senza neppure un grazie, aveva preso il guinzaglio e le aveva chiuso la porta in faccia. Che andassero al diavolo lei, quello della bmw e la compassione che le aveva letto negli occhi. Lo metteva a posto con un cane, come se una bestia bastasse a riempire il vuoto d’amore.
Neanche l’aveva guardato Dick quella sera, perché gli sembrava troppo poco, una miseria, un cane al posto di una famiglia, che faccia tosta.
E invece Dick era ben più di una bestia, lui capiva un sacco di cose senza bisogno di dirgliele, lui sapeva quando era ora di mettersi tranquillo, di dormire o di fare finta di dormire. Il cane lo teneva d’occhio a modo suo, senza rompergli l’anima, senza dirgli che cosa dovesse fare.
Una notte in cui Franco era svenuto e giaceva incosciente sul pavimento, un tasso alcolico poco compatibile con la sopravvivenza, Dick s’era attaccato alla maniglia della porta d’ingresso con tutto il suo peso, era uscito e aveva cominciato ad abbaiare e a grattare alla porta dei negri del Camerun per chiedere aiuto. E i negri, incredibile a dirsi, avevano chiamato un’ambulanza. Forse questi giargia, non tutti, questi del Camerun, non erano poi così male.
Bella bestia quel cane, bel cervellino, bella prontezza di spirito e, soprattutto, a lui ci teneva, altrimenti chi glielo avrebbe fatto fare di sobbarcarsi tutto quell’abbaiare, e grattare, e saltare per salvarlo.
E senza neanche sfasciargli le scatole perché smettesse di bere. Dick se lo teneva così, non proprio lindo, la barba rossiccia sfatta, lo sguardo annacquato e quel leggero tremore nelle mani. Non ne faceva una questione, perché quando si vuole bene non si rompono le palle.
Entrano nel bar come ogni sera, senza salutare nessuno. Non é lì per fare amicizia e poi sono quasi tutti vecchi che giocavano a briscola.
Franco solleva le sopracciglia in direzione del barista, Beppe solleva un calice a mo’ di benvenuto e prepara il pane per Dick che salta per azzannare il boccone al volo e poi gli sorride. Succede che qualche cane lo faccia mostrando denti e gengive, ma in realtà è con gli occhi che un cane sorride, sorride e ringrazia. Poi si accuccia sotto lo sgabello e comincia a dormire, mentre Franco dà l’attacco alla prima birra.
La prima è per togliere le sete, la seconda per ammorbidire la prima, ma è la terza quella magica, quella che scioglie i muscoli del viso, pulisce il cervello come una spugna, poi con la quarta non c’è più niente che non sia il bar, gli aneddoti dei vecchi ripetuti cento volte, la polvere sulla strada, l’ultimo raggio di sole che colpisce di sbieco il cartello stradale.
Ce n’è sempre una quinta, una sesta e, nelle sere buone, anche una settima. La birra ha questo di bello, ti sbronza lentamente, poco per volta, non ti dà la botta secca dei superalcolici. E poi non costa cara.
Che cosa vuole quella secondo te Dick? –chiede accarezzandogli la testa. Guarda me o te quella bionda? Vuoi vedere che ci tocca condividere anche le femmine oltre che il letto! Facciamo un patto: quelle a quattro zampe sono tue, quelle a due sono mie – gli dice mentre gli viene quasi da ridere. Dick apre un occhio come a sigillare l’accordo e poi riprende a sonnecchiare, mentre lui ordina la settima birra, questa sera ci vuole.
La bionda non molla l’osso e ora lo guarda dritto negli occhi, come se volesse risucchiargli il fiato.
Da non credere, che cazzo vuole quella biondina slavata? Si guarda alle spalle nel dubbio che sia un altro quello cui è diretto lo sguardo, ma c’è solo il muro. Beppe sorride di sbieco, Dick ronfa della grossa.
Non l’aveva notata prima, non è che di donne in questo bar ce ne vengano molte. Non era una cui di solito avrebbe concesso una seconda occhiata. Se ne sta seduta a un tavolo in fondo, sola, con davanti una tazzina di caffè. Un caffè in questo bar lui non ce l’ha mai bevuto, pensa, e sorride un’altra volta. E’ allora che lei si alza e si avvicina. Magari ha pensato che Franco sorridesse a lei e s’è illusa, ha creduto di piacergli. Ma sbronzo com’è, sorriderebbe pure a una scimmia.
E’ lei che parla per prima. Sono sempre loro, le femmine che decidono, ai maschi lasciano l’illusione di gestire il timone, ma in verità i maschi non contano mai un cazzo – pensa fra sé.
Non è che capisca bene quello che lei dice, è troppo intento a contarle con lo sguardo gli orecchini e poi tutti quei bracciali che pare una ferramenta. Lei intanto parla. Fanno così le donne, blaterano e ti rimbambiscono, e finisce che credi che hanno ragione loro, e fai quello che vogliono.
Le parole di lei gli rimbalzano nella testa come palline da tennis, le sente ma non ne capisce il significato, o forse teme che le sue domande possano strappargli i vestiti di dosso fino a lasciarlo nudo e indifeso. La sente parlare come in lontananza e aspetta in silenzio che tutte quelle parole gli si organizzino nel cervello come soldati in parata, per poter cominciare a capire. Ma tutto quel vociare gli rimbomba dentro e lo stordisce.
Eppure sente forza in quelle parole e sotto ci vede germogliare dolore. Gli parlano dritto al cuore, come allacciando il sogno alla realtà. A tratti ha l’impressione di poter affondare in quella coltre di parole calde, di potersi affidare, come se avessero il potere di fare avverare le cose.
Lui si stropiccia la faccia e appoggia una mano sotto il mento come a sostenere meglio la testa assediata dai discorsi che gli vengono incontro troppo veloci, che sembrano tramortirlo.
Dick si è svegliato e le fa le feste. Cane bastardo, che gioco fai?
Gli viene il dubbio che il cane si stia confondendo, che abbia scambiato la bionda per sua moglie, per la sua ex moglie. No bello mio, lei ci ha mollati tutti e due, sono cinque anni che ti ha scaricato sulla porta di casa mia. Lei non ci vuole più, prima te lo metti in quel cranio duro meglio è.
O forse Dick aveva nostalgia del bambino e questa bionda, così magrolina, glielo aveva fatto ritornare in mente.
Alza una mano per ordinare l’ottava birra, non che ne abbia voglia, ma così, per togliersi d’impaccio, perché non riesce proprio a seguirla questa donna che gli chiacchiera in faccia come se lo conoscesse. Lui resta muto, diffidente e non prende parte alla faccenda.
Beppe finge di non sentire la sua ordinazione, forse non vuole vederlo piombare a terra nel suo bar, non vuole dover raccogliere il suo vomito. Non che fosse mai successo, era sempre riuscito a fermarsi prima, o al massimo a vomitare per strada, ma il pavimento del bar non l’aveva inzaccherato mai. L’aveva calpestato a tentoni, quello sì, perché si sentiva balengo e perché quel pavimento, a una certa ora, diventava obliquo, pendente e se non ci stavi attento ti faceva perdere l’equilibrio.
A casa invece vomitava spesso, e ci si svegliava dentro nel suo vomito, i pantaloni umidi di piscio.
Ora erano per strada, il cielo screziato dalle nubi. Non ricordava come fosse successo, come fosse uscito dal bar, se il pavimento fosse dritto o storto quella sera, se avesse pagato le birre. Camminavano fianco a fianco, lui, Dick e la bionda che gli si era incollata addosso sa Dio perché. In fondo l’odore di una donna non lo sentiva da anni, perché no
Il sole entrava obliquo dalle persiane e le colpiva il volto. Aveva una donna nel letto e il cane, quel traditore, dormiva accoccolato vicino a lei. Restò immobile, gli occhi spalancati come ad interrogare il giorno, per capire che intenzione avesse, che cosa avesse previsto per lui. Sentiva una tremenda pressione dentro che lo faceva ritrarre nel suo guscio di lumaca.
Provò a rimettere insieme i frammenti della serata. Sicuramente aveva bevuto, beveva tutte le sere. Si ricordava i suoi occhi insistenti, lo sguardo aguzzo indagatore e quelle parole che gli erano franate addosso e che non aveva capito. E ora che cosa le avrebbe detto? Perché qualcosa doveva pur dire, una donna se le aspetta sempre le parole.
Tentò di alzarsi in silenzio con l’idea di sgattaiolare via, uscire di casa e non farsi trovare. Ma Dick era balzato in piedi e l’aveva svegliata. Lei aveva allungato le gambe, si era sgranchita come un gatto e aveva aperto gli occhi. Sembrava non riconoscere né lui né la stanza, poi le sue labbra si erano distese in un sorriso.
Beh, ora te ne puoi anche andare – aveva sibilato lui prima che potesse frenare le parole. Ora che hai avuto quello che volevi, lasciami in pace.
Lui era capace di parlare solo così, con furore, con parole fuori misura, parole nervose che sapevano solo mordere. Le cercava le altre parole, ma loro lo disertavano. Nei giorni buoni riusciva a sentirle in fondo a non si sa cosa, ma erano come schiacciate, trattenute da una mano invisibile e non c’era pinza che le stanasse. Allora si metteva in salvo negli abituali insulti e nel rumore che sollevavano superando ciò che voleva dire. Nel cuore, il silenzio di una cattedrale deserta.
Il viso di lei si era accartocciato in una smorfia e d’istinto aveva allungato una mano verso il lenzuolo per coprirsi, come volesse rimangiarsi quello che avevano fatto, come per pudore. Sul viso le si era sparso un forte rossore, la bocca tesa in una linea secca, offesa. Per un attimo sembrò che la vista le si annebbiasse, mentre nella stanza entrava un forte senso di disagio. Poi un fiume di rabbia le aveva attraversato lo sguardo, due minuscole rughe le erano comparse fra le sopracciglia e, arrotolata nel lenzuolo grigiastro, si era messa in ginocchio sul letto, gli occhi in fiamme pronti allo scatto. Niente ho avuto, se proprio lo vuoi sapere, non è successo niente.
Com’era possibile che avesse fatto cilecca, con tutta la fame che aveva?
Lei gli lesse il dubbio nel volto e gli chiarì che non aveva fatto fiasco, che proprio neanche ci aveva provato; che, dopo un rutto da far tremare i vetri, si era schiantato sul letto e era caduto nel mondo dei sogni.
Beh, se ti devo pagare dimmelo e poi vattene – buttò fuori come un veleno la sua bocca.
Lei si alzò di scatto, lasciò scivolare a terra il lenzuolo e rimase nuda, diritta davanti a lui guardandolo con disgusto. Poi cominciò a strillare, come se strappasse a morsi le parole, che lei non era una bagascia, che lavorava in una stireria, che non le servivano certo i suoi soldi sporchi, che s’era solo sentita sola, che l’aveva visto solo e aveva pensato che soli in due era meglio. Perché non è che solo più sola faceva due solo, e neanche un solo al quadrato, per lei faceva meno soli, magari fra due parentesi tonde come abbracci.
Lui sedeva afflosciato sul bordo del letto, a un palmo dal suo livore, le braccia penzoloni fra le cosce, un mozzicone di sigaretta spenta che gli pencolava da un angolo della bocca.
C’era qualcosa di disarmante in quell’uomo, si aveva l’impressione che respirasse ai bordi esterni di ciò che accadeva, come riuscisse a starne fuori.
D’improvviso, lei lo guardò dritto in volto come a trafiggerlo e lo colpì con due colpi secchi, due schiaffi di quelli ben assestati. Bel colpo per ‘sta magrolina – pensò lui mentre le afferrava i polsi con le sue mani grandi. E più lui stringeva e più lei urlava e si dibatteva, scuotendo i capelli a destra e a sinistra.
Aveva paura la ragazza, la mostrava scritta in quegli occhi febbrili che sembravano sopraffare tutta la faccia e nella bocca tirata. In fondo di lui non sapeva proprio niente, magari era un violento, magari aveva un’arma. Certo che ce l’aveva, una carabina di lusso. Ma dopo l’ultima cazzata l’aveva data in deposito a suo padre, perché non si fidava più di sé stesso, perché sentiva che il passo dalle parole ai fatti non era poi così lungo. Anche per questo beveva, per tenere a bada tutta quella rabbia, oltre che la tristezza.
Era carina senza trucco e senza la ferraglia, forse un po’ troppo magra per i suoi gusti, ma ben fatta. E tutta quella foga, quegli strilli la facevano quasi bella.
Franco la guardò, pareva una corda tesa e lui sentiva la sua presenza come una pressione sulla pelle, come qualcosa che lo toccava dentro. Quella donna camminava dal lato buono della vita.
Franco le sorrise e, delicatamente, la avvicinò a sé e la baciò con tenerezza. Lei cercò di divincolarsi, c’era troppa notte in quell’uomo, ma poi a poco a poco si sciolse, dimenticò di essere arrabbiata e annacquò la sua solitudine in quella di lui.
Dick si tenne decorosamente in disparte, un cane come si deve sa quando è ora di togliersi di torno.
Il partito preso delle parole .1
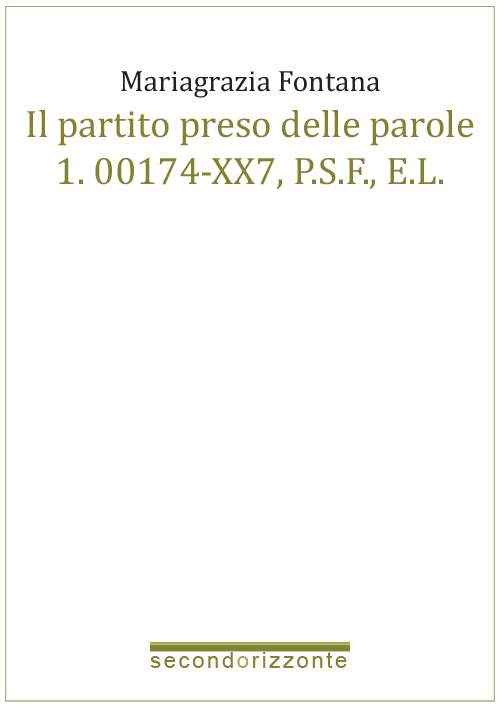
1. 00174-XX7, P.S.F., E.L.
Non entrava in quella casa da mesi, eppure nulla era cambiato: gli stessi mobili da quattro soldi, vecchi e consunti, congelati nella disposizione di sempre. Era sua madre che era fissata con i rinnovamenti. Certe mattine la trovava già sveglia all’alba a spostare poltrone, a ficcare stracci sotto i piedini della credenza per farla scivolare sul pavimento e posizionarla nella parete di fronte, così da fare sembrare la stanza diversa, visto che soldi per comprare mobili nuovi non ce n’erano mai.
Da quando lei era mancata, in quella casa non si muoveva foglia e, ovviamente, neppure mobili.
Di convivere con una badante suo padre non ne voleva sapere, aveva accettato solo l’aiuto di una vicina che, per quattro soldi, s’era offerta di pulire una volta ogni tanto. Non faceva un buon lavoro, una polvere vecchia di anni ricopriva i mille soprammobili che probabilmente lei neanche spostava e un odore di cibo stantio ristagnava nell’aria. Non si poteva pretendere, per quel poco che la pagava.
Suo padre era seduto in cucina, come sempre. Il divano e la poltrona non aveva l’abitudine di usarli, li teneva buoni per chissà quale occasione, in salotto, coperti da un involucro di plastica che ormai aveva quarant’anni ma che non s’era sbrecciato mai, perché nessuno mai s’era seduto su quel divano.
Parenti ne avevano pochi e abitavano lontano, di amici non se ne parlava proprio. Magari qualche vicino, gente di casa per cui una sedia in cucina e la tazzina del caffè di tutti i giorni erano perfette.
Era vecchio e trasandato, le sopracciglia lunghe e arricciate, gli occhi cisposi incapsulati in palpebre rugose che l’acqua non sfiorava da tempo. La fronte sembrava un campo arato di fresco e le guance flosce e cascanti con quelle due parentesi ai lati della bocca gli disegnavano un’espressione vacua, lontana da tutto, perfino dalla disperazione, assente.
Come te la cavi pa’? gli chiese accendendo la luce e appoggiandogli una mano sulla spalla per scuoterlo dal torpore, mentre sentiva che non riusciva proprio ad amarlo quel vecchio perso in non si sa quale altrove.
La bocca del padre si contorse come se non riuscisse a rispondere, come fosse imprigionato in un’eco interiore. Forse era diventato ancora più sordo, forse la sua testa vagava in un altro mondo, un mondo in cui sua moglie ancora si occupava di lui e lui era un operaio che timbrava il cartellino, non un vecchio scalcagnato, prostrato dalla rassegnazione e da quell’agonia diluita.
Faticava a vederlo così e forse per questo non si curava di lui. Meno lo vedeva e meno ci pensava, a lui e a quella storia balorda di invecchiare e poi morire. Che tanto ognuno ha il suo destino e le sue grane. E a Franco le grane non mancavano di certo.
Anche la sua stanza da ragazzo era rimasta immutata, tale e quale: mobili al risparmio, ACDC e Metallica alle pareti, i libri di scuola. Del suo fucile nessuna traccia.
L’ho messo insieme ai miei nell’armadio chiuso a chiave, con tutti i negri e i disgraziati che girano…
Suo padre di fucili ne aveva ben tre, tutti comprati con lo sconto alla fabbrica Beretta dove aveva lavorato, come la maggior parte degli uomini della valle che non volevano più fare i pastori o i contadini. E lui di fucili se ne intendeva.
Quando Franco era un ragazzino gliene aveva regalato uno leggero, con il calcio inciso a mano. In Val Trompia c’erano donne che praticavano ancora l’arte della bulinatura scolpendo scene di caccia sui calci delle armi. Il suo fucile d’infanzia era impreziosito dall’immagine di una piccola lepre in fuga.
Come sparare a un leprotto? – s’era chiesto lui undicenne quando, fucile in spalla, era uscito con suo padre per la prima battuta di caccia. Per cacciare bisogna essere pronti ad uccidere, non solo a sparare– gli aveva detto papà. Uccidere è l’istinto dell’uomo e delle bestie. E’ così, è la natura. Se vuoi diventare uomo devi uccidere. Uccellini certo, non cristiani, che se no ti si aprono le porte della galera. Anche se a certi cristiani una pallottola in fronte gli starebbe proprio bene, che qui se non ci si difende da soli, a noi non ci pensa mica nessuno. Prima te lo ficchi in testa e meglio è. Pensa per te e per la tua famiglia, pensaci tu, non stare a sperare in quelli della politica. Comandano i rossi o comandano i neri, i poveri diavoli restano poveri diavoli, credimi.
Gli piaceva uscire con suo padre, non tanto per la caccia ma per stare ad ascoltarlo, per camminare con lui nel verde, per l’attenzione ai rumori, perché ogni fruscio poteva essere un passero.
Il capanno non ce l’avevano, suo padre aveva le sue idee, preferiva vagare calpestando l’erba, gli archetti li odiava, erano una roba da figli di puttana. Per non dire degli uccelli di richiamo, una vera bastardata. E’ nel tiro a volo che sta la bravura di un vero cacciatore – gli diceva sempre.
Bella forza uccidere un uccellino indifeso, avrebbe detto a Franco sua moglie, vent’anni dopo. Che gusto ci provavi a interrompere una vita che non ti aveva offeso, che si faceva il suo volo senza pretendere nulla? Non mi vorrai far credere che la caccia è uno sport? Uccidere per sport?
Ma le donne, si sa, di caccia e di sport non ci hanno mai capito un accidente.
E poi in valle gli uomini erano tutti cacciatori, era tradizione. Lavoravano alla fabbrica Beretta e cacciavano, uccelli consentiti e specie protette, perché chi ce l’ha il diritto di stabilire questo sì e quello no? Dov’è finita la libertà? E che cos’era quella storia di proteggere gli animali, c’erano la selezione naturale e subito dopo la caccia: chi ce la fa bene, e gli altri a pascolare nei cieli di Dio. Perché per un cristiano è forse diverso?
Franco non aveva mai beccato un granché, non aveva una buona mira e poi a volte chiudeva gli occhi all’ultimo minuto, come per non volerne sapere niente, per non essere lui quello che premeva il grilletto. Che premere il grilletto non è una cosa da poco. E poi ci si deve subito preparare al rinculo.
Suo padre gli aveva raccomandato di tenere il calcio inchiodato stretto alla spalla per sentire meno dolore nel contraccolpo, di impugnare l’arma con fermezza ma delicatamente, di allineare l’occhio al mirino e poi, superata la soglia della paura, sparare sicuro.
In realtà, quello che gli piaceva era la corsa che veniva dopo, con i cani davanti, in mezzo all’erba, il sangue a pulsargli nelle tempie. I cani abbaiavano e lui urlava come un pazzo, preda di una frenesia, del piacere di averlo premuto quel grilletto, di essere un uomo a tutti gli effetti, non un moccioso.
Il suo fucile c’era ancora, ma a tenerlo in mano sembrava leggero, le canne troppo corte, il calcio stretto per la sua spalla di uomo. Suo padre gliene propose uno dei suoi, non uno qualunque, il più bello.
Tienila bene, mi raccomando, trattala come se fosse sempre caria. Questa sì che è un’arma, un’arma da uomo.
Franco provò a mettersi in posizione, la guancia appoggiata all’arma, il peso sul piede sinistro spostato in avanti, il calcagno del piede destro di poco sollevato, proprio come gli aveva insegnato suo padre che non sbagliava un colpo, puntava il bersaglio con una faccia inespressiva e, come se avesse un computer in testa, colpiva il fagiano che si afflosciava in volo e cadeva a testa in giù.
Era perfetta, una gran bella carabina, completa di cannocchiale. Portava cesellato sul calcio un cervo con uno splendido palco di corna, pronto al balzo.
E’ una carabina da caccia grossa, calibro 308, ci puoi uccidere un cervo o un cinghiale. Se miri con il cannocchiale da puntamento la preda te la vedi lì, come se fosse a due passi. E poi guarda bene sul fusto e sulla canna, osserva la matricola, il catalogo e soprattutto il punzone del banco.
00174-XX7, P.S.F., E.L. mostravano le incisioni. Il primo è il numero di matricola, cioè la targa del fucile e il numero progressivo di produzione, XX7 è il certificato di nascita, vuol dire che è stato costruito nel 1971 e P.S.F. indica le prove di sparo fatte dal banco. E.L. sta per extra lusso, mica un fucile basico – chiariva il padre gonfio di orgoglio, gli occhi rianimati forse dal ricordo del volo di una quaglia o del ritmo della catena di montaggio della fabbrica Beretta, o del bicchiere di bianco con l’oliva del fine turno, seduti all’osteria, le gambe accavallate, a tirare il fiato parlando di calcio, donne e politica.
Ricordati di pulirla come si deve prima e dopo l’uso, ben oliata, come ti ho insegnato. Un’arma come quella è un gioiello. E poi sono contento che vai a caccia, è un po’ come se ci andassi ancora anch’io che adesso ci vedo poco. Dovrei decidermi per quell’intervento delle cataratte. Ma poi che cosa mi importa, non è che ho gran che da vedere. Anzi alla mia età, meno si vede e meglio è.
Franco teneva la carabina sotto il sedile dell’auto: un’arma a portata di mano ti dà sicurezza, pensava. L’aveva pulita per bene, godendosi in mano il freddo delle canne, accarezzandolo come fosse un bambino. Se ne sentiva la responsabilità, era una “signora carabina”. Non che avesse deciso che farsene, ma stava meglio a sentirla vicino, gli faceva compagnia, gli apriva possibilità nuove.
Da quando il giudice lo aveva cacciato di casa con un decreto di allontanamento, lui viveva in due stanze ammobiliate in un quartiere popolare degradato, pieno di neri e magrebini. Ma non si poteva permettere altro, perché c’era da pagare il mutuo di casa, anzi dell’ex casa, gli alimenti per il figlio ancora piccino, l’affitto di due stanze fetide e poi doveva vivere lui. Niente sfarzi, con il suo stipendio ci stava dentro al pelo. Niente cene fuori.E poi con chi? Di amici non gliene erano rimasti, si erano schierati tutti con lei, cioè contro di lui. Dicevano che era un violento, ma non era vero. Lui non aveva mai spaccato la faccia a nessuno. E certo le occasioni non gli erano mancate Aveva un brutto carattere, si accendeva con niente, sputava fuori parole roventi, si alterava, la minacciava,ma solo con la voce.
Magari l’aveva spintonata, qualche volta un ceffone. Sì, anche davanti al bambino, non è che lo scegli quando dare fuori di matto, non è che l’ira la puoi rimandare, quando arriva arriva e chi c’è c’è.
E di ira in quelle due stanze anonime, che continuava a considerare provvisorie, ne masticava parecchia.
Si sforzava di non guastarsi l’animo rimpiangendo i tempi andati, di andare avanti, di farsi riprendere dalle fesserie della speranza, dal filo appiccicoso della vita, ma vivere insieme alla feccia, ai pakistani con i loro capelli unti, ai negri che ballano e mangiano a tutte le ore, ai nordafricani con il coltello facile non era mica uno scherzo.
Le liti nel suo stabile erano all’ordine del giorno e della notte. Lui cercava di starne fuori, di non mischiarsi a quella gentaglia che, se fosse stato per lui, avrebbe rispedito a casa loro.
Ma, come sempre, lui non contava un cazzo.
A volte la mattina si svegliava agitato, come se avesse dormito in casa d’altri, arrotolato in lenzuola sudate e stropicciate, comprate a buon mercato, e sentiva i mugugni di quelli di sopra, o di quelli delle stanze accanto, in una lingua che non si poteva capire e pensava che una casa vera ce l’aveva e che la stava ancora pagando. Una villetta a schiera nella parte sud della città. Niente di lussuoso, ma lui, che con le mani se la cavava e sapeva fare un po’ di tutto, l’aveva sistemata bene. Aveva immaschiato le assi del parquet di rovere nella zona giorno e incollato la moquette nelle camere. La tappezzeria se l’era risparmiata, grazie a Dio non era più di moda, altrimenti lei, che era grande nella testa, avrebbe preteso pure quella.
In realtà si era divertito a fare quei lavori, ne era orgoglioso.
Ora però gli prudevano le mani all’idea che quella casa non fosse più sua, che non potesse più ciabattarci la sera, bersi una birra con i piedi sul tavolo a fine turno, insegnare a stare al mondo a suo figlio. E sa Dio quanto quel bambino ne avesse bisogno, che più lo si lasciava in mano a lei più si faceva pauroso, da sembrare malato, quasi una checca.
Lui si era impegnato per quel che poteva a raddrizzarlo, a cementargli la spina dorsale. Ma il calcio non gli interessava, la box non parliamone, non la reggeva neanche in tv. La caccia non poteva neanche nominarla senza farlo impallidire. Era un bambino fragile, piccolo e magro per la sua età, gli occhi perennemente cerchiati di nero. A scuola se la cavava bene, anche se le maestre dicevano che soffriva d’ansia, che non reggeva lo stress delle interrogazioni, che aveva attacchi di panico.
Certo a trattarlo come una femminuccia come faceva lei, che cosa volevi che ne saltasse fuori? Se glielo avesse lasciato in mano, che so per un annetto, lui lo avrebbe aiutato a farsi uomo, a tirar fuori le palle, perché era figlio suo e le palle ce le aveva di certo da qualche parte.
Quella sera non c’era verso di stare tranquilli a cena. Si era comprato un pranzo precotto al supermercato, non cucinava mai, non si cucina per uno solo, si mangia freddo o al massimo si riscalda al microonde. E poi quei vassoietti costavano poco.
I giargia del piano di sopra facevano un fracasso d’inferno, parlavano in tanti, tutti insieme, forse litigavano con i loro vocioni spessi. E mica c’era da incazzarsi con quei bestioni, che magari ti portavi a casa un sacco di mazzate.
Aveva acceso la macchina e aveva cominciato a girare nella città buia, incazzato con quei negri, con quella vita grama che gli era toccata, con i soldi che non c’erano, con le speranze andate in fumo, con lei che l’aveva cacciato, con suo figlio che cresceva storto e anche per quello sembrava fosse colpa sua.
La macchina come d’incanto aveva imboccato la strada di casa, della sua ex casa. Aveva parcheggiato sul marciapiede di fronte, i fari spenti, così senza motivo e se ne stava lì senza sapere che fare, il cuore vuoto.
Le luci da basso erano accese, le tende tirate, non si vedeva niente di dentro, però si poteva immaginare. A quell’ora lei aveva finito di cucinare e stavano mangiando. Televisore spento, lei diceva che faceva male mentre si mangia. Inspirò a fondo, forse per annusare i profumi e scoprire che cosa avevano nel piatto. Odore di casa. Che idiota, da questa distanza, finestrini chiusi, che cosa vuoi sentire?
Gli sfuggì l’occhio verso il garage. Era chiuso, lei parcheggiava sempre dentro per paura dei vandali, anche se lì in quel quartiere non succedeva mai nulla. Avrebbe dovuto provare a vivere dove abitava lui adesso, in mezzo a quella feccia senza nulla da perdere, immerso in quel puzzo di curry, di aglio e di olio fritto.
Fuori dal garage, in fondo al vialetto, proprio davanti alla basculante, era parcheggiata un’auto grigia metallizzata sconosciuta, una bmw.
Suo suocero non guidava più, e poi una bmw non se l’era mai neanche sognata, sua suocera non aveva mai guidato, amiche con l’auto di quella tinta e di quella cilindrata non se ne ricordava.
E se fosse di un uomo? E se lei avesse un uomo?
Quella possibilità non l’aveva mai sfiorato, lei diceva sempre che con gli uomini non voleva più avere nulla a che fare, che gliene era bastato uno. Ma magari aveva cambiato idea. Magari ne aveva incontrato uno di quelli tutte moine, fiori, cioccolatini e compagnia cantando, un uomo che ci sa fare con le donne.
Quel pensiero gli imperlò la fronte di sudore e la mano, inconsapevolmente, scivolò sotto il sedile, ad accarezzare la carabina Beretta, la testa come imprigionata in una bolla.
No, non era geloso, è che lui era un uomo, uno di quelli che sa difendere il suo, che non si fa soffiare moglie e figlio da un damerino con auto grigia metallizzata che certo non abita in due stanze puzzolenti ammobiliate, fianco a fianco agli immigrati.
Decise di aspettare, di calmarsi, di riflettere. Forse fantasticava e stava costruendo castelli in aria, forse ci ricamava sopra e poi quell’auto magari era di una collega di sua moglie.
Ma quella era un’auto da uomo, ne era certo. Non che ci sia una regola: a destra le auto da uomo, a sinistra quelle da donna. E’ che le donne le berline non le amano, così lunghe poi, non le sceglierebbero mai. Poi come le parcheggiano? Loro, le femmine, comprano auto compatte, meglio se piccole e poi rigano anche quelle.
Pensava e intanto accarezzava la carabina. Non era lì per caso quell’arma, nulla succede per caso.
E se quell’uomo fosse anche ricco? E se fosse istruito? Lei di fronte a una poesia avrebbe calato le difese e anche le mutande, ne era sicuro. Le donne sono tutte così, non capiscono un cazzo. Non lo sanno che con le parole non ti riempi lo stomaco. Uno suda in fabbrica una vita, incastra le assi del parquet, tinteggia le pareti, taglia l’erba e poi arriva un sapientino qualunque che, senza una goccia di fatica, con due parole messe in fila per bene riesce a imbambolarle.
Al solo pensiero sentiva la rabbia scorrergli a fiotti dagli occhi iniettati di sangue.
Era sangue quello che bramava, fiumi di sangue per lavare l’onta di essersi lasciato soffiare moglie, figlio e casa, di vivere in un quartiere di merda, di mangiare cibo di merda, di fare un lavoro di merda, di essere solo come una merda.
Era quello che gli bruciava di più, quella parola solo che gli apriva una voragine davanti. Sarebbe sempre stato solo. Sì, magari una sgallettata se la sarebbe portata a casa, giusto per il servizio notturno, ma solo sarebbe stato comunque. Perché non è che di famiglie ne metti in piedi cento, che immaschi migliaia d’assi di parquet, posi chilometri di moquette, tagli quintali d’erba. La cazzata la fai una volta e poi, per il resto della vita ci frigni sopra, bevi birra, rutti in santa pace e ti senti morire.
Si era aperta la porta d’ingresso e il respiro gli si era inchiodato. Alto, brizzolato, più vecchio di lui, ma ben più elegante, un principio di calvizie che lo fece gioire, sbarbato di fresco.
D’istinto si portò una mano alla guancia ruvida, la sua rasatura non era recente.
Se ne stava andando. Allora non dormiva da lei, non erano ancora a quel punto. Bisognava intervenire subito, prima che succedesse, perché poi quando si crea quell’intimità fra maschio e femmina è dura. Perché lei non era una facile, una da una botta e via. Lei se con uno ci andava a letto, poi ci parlava e lo seccava con i ricordi, con quella menata dell’infanzia, e poi con i progetti, poi i sogni e via discorrendo.
Suo malgrado, ricordò quanto gli piacesse il sesso con lei, come potesse essere stupendo anche per quel dopo, per quel perdersi in fantasticherie che lo aveva ammaliato, per quel fare tutto semplice che lo teneva attaccato al lato buono della vita.
La guardò intensamente, come per accarezzarle il viso con gli occhi.
Tirò su la carabina e se la pose sulle cosce, così era pronto. Non aveva ancora deciso per cosa, ma era pronto. Bisogna essere pronti nella vita, altrimenti ti scavalcano tutti, ti rubano i soldi, la macchina e perfino la moglie. E tu te ne resti lì come un coglione, con l’indecisione in mano.
Ancora parlavano, fuori dalla porta. Chissà cos’avevano da dirsi? Lei ce l’aveva questa fissa delle parole, diceva che lui non parlava abbastanza, che non raccontava mai niente di sé, che era come aver sposato un muro.
Io non sono capace di entrare nel tuo silenzio, gli aveva detto un giorno.
Ma lui delle parole diffidava. Hanno un’aria da niente le parole, ma poi d’improvviso scatenano emozioni forti e ti ci trovi attaccato via come a un cappio. E ti tocca tremare per il resto della vita per il terremoto che hanno innescato, che mai avresti detto fosse possibile smuovere solo con i sentimenti. Le parole hanno così tante facce che non c’è da dargli credito, certe sono capaci di rigirarti le cose da non capirci più niente.
Però, a giorni, gli sarebbe piaciuto avere qualcosa dentro da dirle, ma le sillabe gli si impastavano sulla lingua, le parole erano grevi come se dovessero farsi strada attraverso qualche sostanza densa, e lui restava lì esitante come un allocco ad ascoltare tutto il silenzio che si sentiva dentro.
E poi che cosa raccontare di giornate di lavoro in cui, a parte che lavorare, non succedeva niente. E che dire dell’infanzia, chi se la ricordava?
Certo, a ben vedere non le aveva mai raccontato del fucile e della caccia, della sua paura, del sangue che gli pulsava alle tempie, dell’angoscia che lo prendeva di notte quando sapeva che il padre l’avrebbe svegliato presto per portarlo a sparare, del sudore della mano che teneva gli uccellini morti per le zampe, della speranza inconfessabile di sbagliare mira, di fare cilecca. Mica voleva fare la figura dello sfigato. Che poi la paura se l’era fatta passare e si era fatto uomo.
Non aveva più sparato da allora, ma non era una cosa difficile. Un conto è colpire un uccellino in volo, un altro un uomo fermo davanti a una porta, davanti alla porta di casa tua, che fa il cascamorto con tua moglie e che magari chiacchiera anche con tuo figlio.
Abbassò il finestrino e il suo fiatò si condensò nell’aria quasi gelida. Imbracciò la carabina Extra Lusso, la faccia chiusa in una smorfia e tolse la sicura sentendo un click. L’arma era fredda e lui le stava attaccato come l’edera al muro. L’avrebbe scaldato lui quel fucile, con un colpo secco, di quelli che mettono le cose al loro posto. Pesava, era una carabina da uomo. Girò l’anello della messa a fuoco e di colpo l’avversario comparve al centro del mirino, vicino. Il suo dito si tese sul grilletto, era pronto.
La sua bocca era asciutta, le labbra serrate, le narici tese, il cuore sembrava percuotergli il petto lento, sotto la luce fredda della luna, la testa vuota di pensieri.
Non era così vecchio come aveva creduto, i tratti del viso erano distesi, quasi dolci, il naso leggermente storto come di chi qualche grana l’ha incrociata.
Lui, l’altro, neanche si immaginava di comparire nitido al centro del mirino di una carabina Beretta di quelle buone. Magari un’arma non l’aveva mai impugnata e per quello aveva quell’aspetto inamidato, come di uno che ha le ossa fragili e non ha capito niente della vita. Magari l’avevano bastonato pure lui e, invece di farsi forte, s’era immalinconito.
Ma era tardi per rifletterci, per cominciare a costruirci sopra, che se t’infittisci la testa di pensieri poi non fai più niente. Non si sarebbe tirato indietro questa volta, non avrebbe chiuso gli occhi, avrebbe fatto ciò che andava fatto, avrebbe difeso la sua vita, quell’unico pezzo di vita per cui valeva la pena di battersi. Ora avrebbe contato fino a tre e poi bang.
Non sudava, non tremava, sedeva con il tronco in leggera torsione, fermo come una statua, risoluto, le mani di pietra, gli occhi aguzzi a punteruolo. L’angoscia era rimasta a presidiare le sue due stanze ammobiliate.
Un respiro e poi: uno, due…
Ma, fermi tutti, che cos’è quella roba che corre?
Dick, Dick sei tu? Urlò trasalendo.
Aprì la portiera d’istinto e fu investito dal suo cane, un meticcio, cioè un bastardo, giovane e bello come il sole.
Il cane era così felice di vederlo che saltava come un matto e sembrava rimbalzare come una palla. Lo abbracciò e se lo strinse al petto forte, mentre Dick gli leccava il viso uggiolando, si beveva le sue lacrime salate e lui lo accarezzava. Sbavava Dick la sua sorpresa, il muso imbrattato di gioia. E intanto spiccava balzi da non credere, come se anche le zampe volessero confermare alla terra tutta la sua irrefrenabile contentezza. Bava e lacrime, umori mescolati, lo stesso stupore, la stessa speranza.
Franco, con una folle ilarità negli occhi, si inginocchiò sul marciapiede e presero a rotolare, uomo e cane avvinghiati sull’asfalto, vicino ai bidoni dell’immondizia, a ridere, a dirsi dolcezze, a scambiarsi baci e leccate a non finire.
Dick gli voleva bene.
La carabina Beretta 00174-XX7 Extra Lusso, con il colpo ancora in canna, era scivolata a terra. Dal calcio di legno un cervo li osservava stupito in silenzio, piegava di poco il capo regale, palco di corna incluso e, con un balzo, scattava via.
Fino all’ultimo respiro

Distolse lo sguardo, chiuse la porta e, la testa incassata nelle spalle, si avviò lungo il corridoio. Percorse lentamente a occhi bassi, i metri che lo separavano dalle scale, desiderando di non incrociare volti, di non rispondere a saluti. Per strada, l’asfalto era estraneo ai suoi passi, tagliente. Gli pareva di camminare in equilibrio sul margine di un dirupo. Il freddo gli feriva la faccia. Si calcò il berretto sulla fronte e sollevò il bavero del giubbotto. Si soffiò sulla punta delle dita, ma il suo fiato era di ghiaccio, come scaturisse da un gelo che gli infuriava dentro. Si ficcò le mani in tasca fino in fondo, svuotato, vittima di una calma innaturale, quasi un torpore.
I pensieri stentavano a prendere forma, sembrava dovessero farsi strada a fatica attraverso un magma troppo denso. Eppure, sentiva di dover pensare per poi poter parlare. Parlare a nessuno di preciso, parlare a sé, nominare gli eventi per renderli reali, perché sono le parole che fanno la realtà. Forse, sarebbe stato più facile cominciare dalle parole per ottenere pensieri, frasi che rimorchiassero un senso da dare a quella notte di disperazione, di pioggia e di furore, all’irreversibilità del fatto.
Il buio cominciava a sbiadire al ritmo del suo cammino, brandelli di discorsi gli affollavano la mente: giustificazioni, buone ragioni che si sarebbero potute mutare in un’assoluzione. Frasi brevi si spintonavano nella sua bocca, pronte a rotolarne fuori liberandolo. Lentamente e coraggiosamente le labbra gli vennero in soccorso e si scostarono l’una dall’altra pronte ad emettere suoni. Ma la lingua restava inchiodata al palato, immobile. Quella lingua di serpente che sapeva fare in quattro un capello, precisare puntigliosamente, accusare, correggere, analizzare, ora giaceva inerte, impantanata, pavida, come se qualcosa l’avesse sopraffatta.
Cercò di schiarirsi la mente, provò a contrarre i muscoli del viso nella speranza che il fiato facesse vibrare le corde vocali. Cercò di gridare, ma le labbra si muovevano senza che ne uscisse alcun suono. Come quando si cerca di urlare in sogno e il silenzio sommerge la voce.
Il primo sole era tagliato in due dalla linea dell’orizzonte, mentre il suo viso, indurito dallo sforzo si faceva esangue, gli occhi parevano oscillare liquidi nelle orbite, alla ricerca di un appiglio cui ancorarsi.
Le parole battevano in testa e gli ingolfavano il cervello, sospinte da un vento impetuoso.
Ora, le frasi si erano agglutinate in ricordi, incursioni nel passato, pallide assunzioni di responsabilità, ma si fermavano sulla superficie della lingua, anzi dentro quel muscolo che le custodiva, forse per trattenere in sé l’evento, per riportare indietro il tempo di qualche ora, a prima del fatto.
Il cielo sembrava abbassarsi per schiacciarlo, per cementarlo al suo gesto e il fiato gli si faceva corto. Allungò il passo. Ora le parole gli scavavano buchi nel cranio per poter emergere in qualche modo, perché non ci stavano più dentro la lingua turgida. Provò ad ascoltarne l’eco profonda e le sentì sgocciolargli dentro fino a penetrargli nel sangue, come fossero pronte a raggiungere una meta. Protese le mani a coprire le orecchie per non udire, perché se le avesse ascoltate, le parole si sarebbero gonfiate dentro la sua bocca e ne sarebbero ruzzolate fuori, estranee, spaventose, esigendo il suo ascolto e il suo giudizio. Aveva bisogno di quelle parole, anche se lo facevano tremare in preda a un senso di raccapriccio.
Il marciapiede oscillò sotto i suoi passi e gli parve d’inciampare.
C’era come una presenza in quella strada, qualcuno che sapeva, un occhio immenso che aveva visto tutto e che, come un pugno di fuoco, gli frugava dentro per fargli sputare il rospo, per condannargli l’anima. E quell’occhio imperioso esigeva parole.
Ma la lingua restava muta. In alcuni momenti sembrava difenderlo dal macigno che gli gravava addosso trattenendolo dentro di sé, in altri sembrava percuoterlo come una scudisciata, squadernando ciò che aveva fatto, quel gesto orribile e pietoso che si allargava in una massa acquosa impronunciabile.
Le sopracciglia si contraevano ritmicamente in movimenti impercettibili d’angoscia. Ora, la sua bocca pareva trattenere a fatica un urlo, la lingua lentamente si staccava dal palato. Voleva parlare, parlare del fatto fino a scorticarsi la gola.