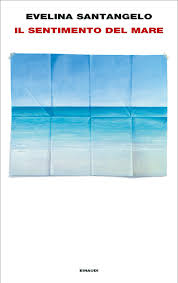
Evelina Santangelo, Il sentimento del mare, Einaudi 2023 (pp. 160, euro 17,50)
Un sentimento che non si lascia inquadrare nel genere (romanzo, saggio, raccolta di racconti, autobiografia) né ordinare secondo una precisa logica temporale, tantomeno circoscrivere entro un luogo determinato. La narrazione procede a ondate, è il caso di dire, e ogni racconto emerge dal precedente e fluisce nel successivo. Anche se un fulcro attorno al quale tutto il materiale narrativo ruota c’è: Lipari, l’arcipelago delle Eolie, al quale l’autrice torna – dopo traversie coniugali e sanitarie – per ritrovare l’“intimità” con il mare che era stata della bambina di un tempo.
Aneddoti ripescati dalla propria memoria ma più spesso sentiti raccontare da altri – non di rado nel dialetto, lingua prima della narrazione – entro una cornice di relazioni nella quale il saper raccontare è ancora un’esigenza vitale, una pratica sociale di cui non si saprebbe immaginare di poter fare a meno: il lettore ha in alcuni momenti l’impressione di trovarsi di fronte a uno di quei quadri che non si finisce mai di guardare, tanto sono densi di figure, gesti, paesaggi, allusioni simboliche. E riferimenti letterari – dagli scrittori antichi a quelli moderni; da Melville all’Hugo dei Lavoratori del mare; da Caterina Bonvicini, testimone della vita sulle navi umanitarie (in queste note il primo maggio 2022 e l’1 novembre 2024) a Simone Regazzoni, filosofo dell’Oceano (in queste note il 27 agosto 2023).
È un sentimento composito, quello che ci viene trasmesso, nel quale un ruolo dominante sembra svolgerlo la compassione, un’adesione al vissuto delle vittime che fa tutt’uno con l’orrore per la loro sorte, siano i pescatori ingoiati dal mare che per loro era vita, i migranti affogati in un Mediterraneo ridotto a cimitero di senza nome, o i tonni barbaramente uccisi nelle tonnare un tempo, nelle enormi navi frigorifero oggi. Un sentimento che trova sintesi in uno “sconcerto” a fatica traducibile in parole, come quello provato quando si viene a sapere “dai pescatori di Mazara del Vallo, che almeno due volte alla settimana trovano cadaveri o avanzi di corpi nelle reti a strascico e, dopo aver sperimentato cosa significa rivolgersi alle autorità per consegnare i corpi o quel che ne resta, una trafila infinita e il rischio di essere denunciati per traffico di migranti, adesso li ributtano in acqua con tutto il pescato di quella calata funestata dal fetore insopportabile della decomposizione”.

Ma al di sopra di tutto è forse un altro sentire, che tutti ricomprende: una percezione del mare, un viverlo, come grande entità viva e pure non umana, luogo privilegiato del confronto – sempre più problematico – tra gli uomini e un mondo di cui sono parte. “Dovremmo ripartire da qui – leggiamo nella conclusione –, chinarci e accarezzare questo sistema fragile, in pericolo e, accarezzandolo, accarezzare i ghiacciai che si stanno sciogliendo, gli oceani che si stanno surriscaldando, le terre che stanno scomparendo, l’umanità che lo affronta ogni giorno con il rischio di naufragarci, morirci dentro, persino di sete, e accarezzandolo accarezzare ciascun morto che ci è annegato, ciascun sopravvissuto, accarezzare noi, che di questa misteriosa bellezza faremmo parte se non fossimo così presi dalle nostre piccine ed effimere vite di terrestri”.
