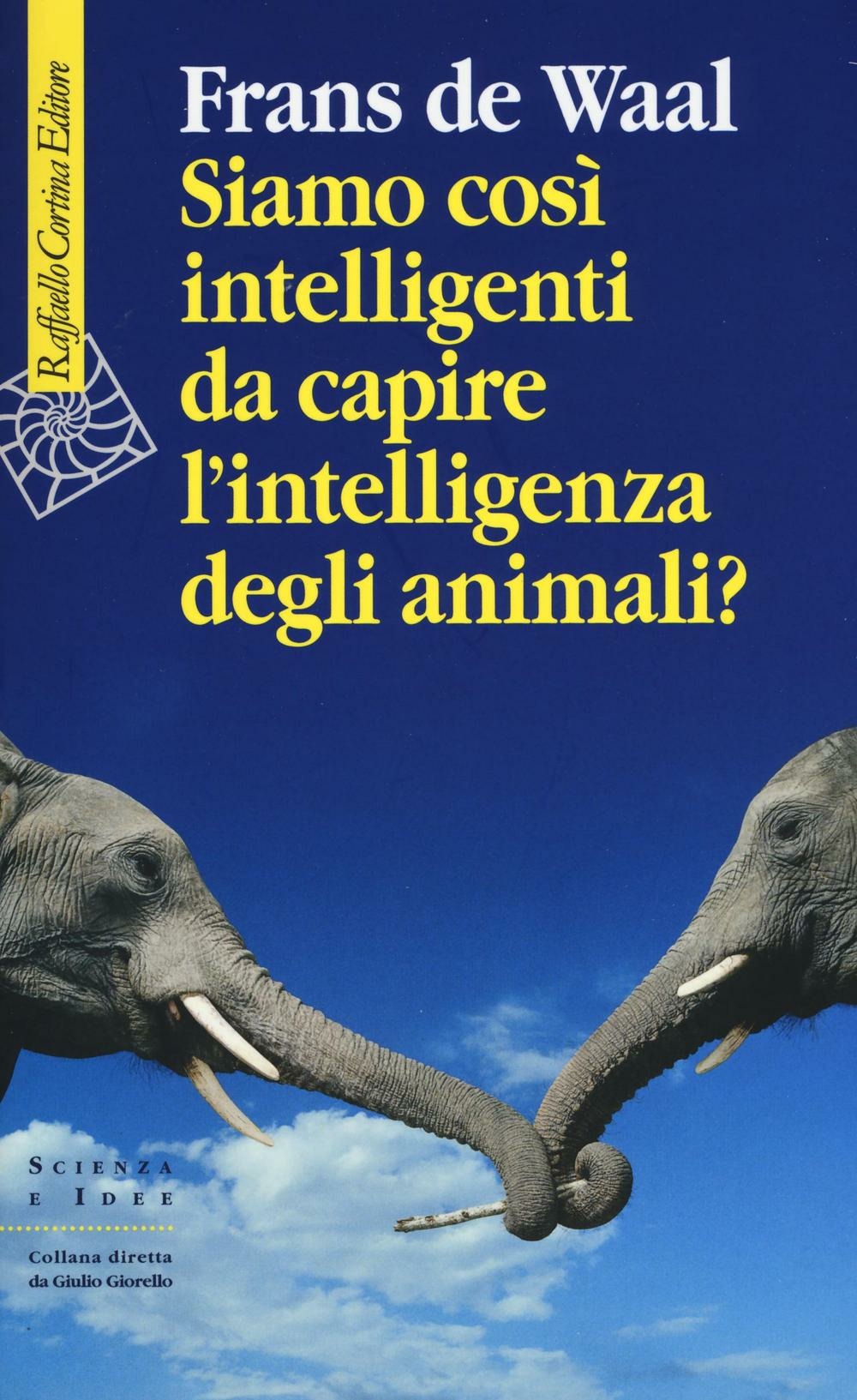
Frans de Waal, Siamo così intelligenti da capire l’intelligenza degli animali?, Raffaello Cortina Editore 2016
Chi nutre, nelle sue varie forme, un sentimento di vicinanza e interesse per gli animali, non avendo del tutto abbandonato lo stupore che da bambini la loro presenza suscita, non cessa di interrogarsi, più o meno consapevolmente, sulle ragioni della qualità della relazione che con essi conserva.
Secondo punti di vista e tonalità diverse l’hanno fatto filosofi – come quelli richiamati introducendo la Nota dedicata all’ultimo libro di Alberto Rollo – così come i narratori, quali lo stesso autore di Billy il cane (in queste note lo scorso 20 dicembre).
Altri ancora sono l’angolazione e gli strumenti impiegati nell’osservazione scientifica, come quella proposta in questo libro dall’etologo e primatologo olandese – scomparso lo scorso anno. La sua domanda, blandamente provocatoria, rimanda in realtà a un quesito di fondo: “perché l’umanità è così incline a sottovalutare l’intelligenza animale?”. Perché “di solito neghiamo agli animali capacità che diamo per scontate in noi stessi”? e “che cosa c’è dietro a tutto questo?” Sicuramente una “resistenza interna”, che contraddice la nostra stessa intelligenza di animali umani, ancora restii ad ammettere quanto riconosciuto da Charles Darwin, ossia che “non c’è dubbio che la differenza fra la mente dell’uomo e quella degli animali superiori sia certamente, per quanto grande, di grado e non di genere”.
Timore di un’altra ferita narcisistica, dopo quelle subite ad opera di Copernico, dello stesso Darwin e di Freud, probabilmente. Un atteggiamento non dichiarato, definibile come “antropodiniego”, da cui discendono impostazioni della questione che risultano fuorvianti, tali da trascurare il fatto che “il confronto – pur legittimo e anzi inevitabile – non è fra gli esseri umani e gli animali, ma fra una specie animale – la nostra – e una grande varietà di altre”, solo per convenzione raggruppabili sotto l’etichetta di animali (Darwin, non caso, riduceva il suo confronto agli animali “superiori”, così come in queste pagine è su alcune specie che la trattazione si incentra: dai primati ai corvidi, dai canidi ai delfini, dagli elefanti ai pappagalli).
Ma questo è un libro fatto di esempi circostanziati, di riferimenti precisi ad osservazioni svolte con pazienza e rigore, secondo un metodo che non impone agli animali studiati esperimenti dettati da una logica umana e che, da un lato, prescindono dai bisogni e dalle capacità degli esseri oggetto di indagine – essendo che ogni animale ha un proprio mondo che “gli impone che cosa deve conoscere per poter sopravvivere” – e, dall’altro, si richiamano ai metodi del comportamentismo, alla sua pretesa di oggettività programmaticamente aliena da ogni empatia, immediatamente tacciata di antropomorfismo.

Una visione continuista dalla scala evolutiva, che non presupponga salti che giustificherebbero l’eccezionalità umana, è, nella sostanza, il presupposto di ogni corretta impostazione del tema che questo libro affronta, senza escludere quesiti cui forse in futuro un’etologia arricchita del contributo delle neuroscienze saprà rispondere.
Uno per tutti: “E se l’autoconsapevolezza si presentasse per gradi?”, se anche la coscienza cioè, il discrimine finora più accreditato, fosse un attributo non specificatamente, non esclusivamente, non interamente umano?
