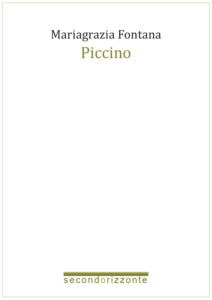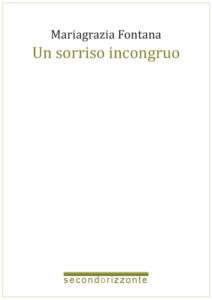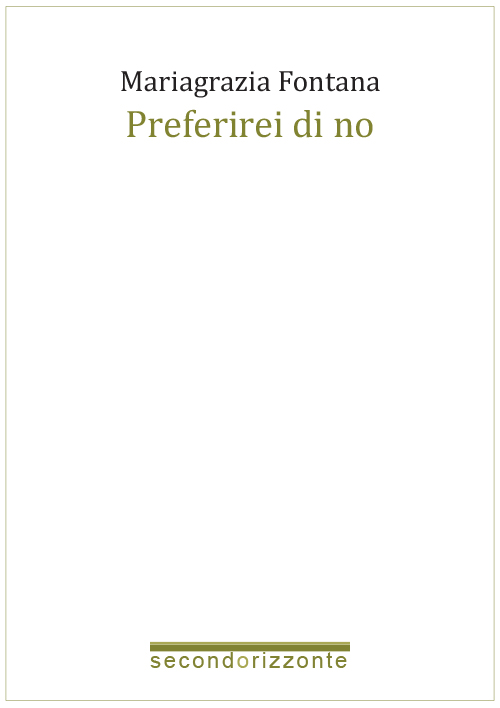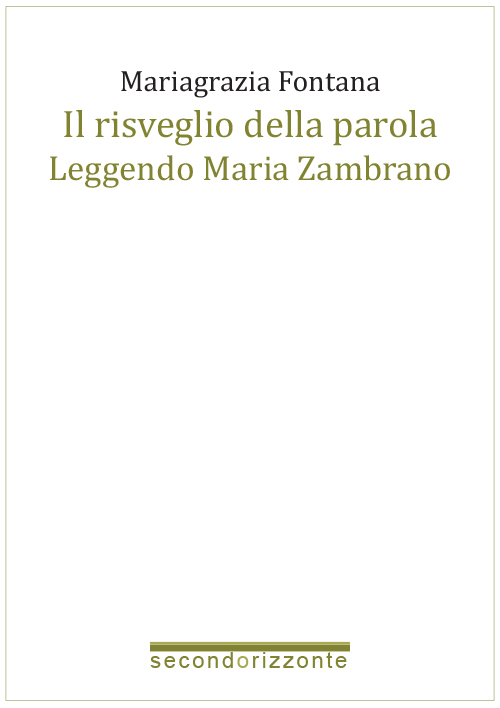Gracile, incurvata, ripiegata su di sé. La guardo e di lei mi colpiscono soprattutto le mani, dove il tempo ha seminato chiazze di vecchiezza, dove la cute si scolla e si ripiega sovrabbondante, come stoffa in eccesso. Abbiamo sempre avuto mia madre e io, delle mani asciutte, dita affusolate, lunghe, non interrotte da nodosità. Anno dopo anno le sue mani sono andate assumendo l’aspetto di rami rinsecchiti, artigli spesso preda di tremori incontrollabili. La vista di quelle mani mi scatena fiumi di pena, mista a risentimento per lei che si permette di invecchiare, non mantenendo le promesse: una madre è per sempre.
Entrambe osserviamo quei tremori di sfuggita, come ladre, l’una colpevole di vecchiezza, l’altra di scarsa compassione. In realtà il suo tremore non é venuto con l’età, c’é sempre stato in quelle mani, quando l’emozione eccede il recipiente del cuore. Lei la chiama emotività, quella stessa da cui sono fuggita infilandomi in una professione dove per l’emotività non c’è spazio, concedendo all’emozione altre rappresentazioni.
La guardo, le mani in grembo, l’una sull’altra serrate a pugno per nascondere il tremore, tradita dal labbro superiore che si increspa appena appena. Guardo quella donna innegabilmente vecchia che é mia madre, che regge ormai a fatica il bagaglio dei giorni, abdicando spesso anche alla dignità minima del tenere per sé ciò che andrebbe celato.
Ha sempre avuto un’innata abilità nello svuotare il suo zaino addosso a me bambina, a me ragazza, a me a mia volta madre e ora donna più che adulta. Da sempre mi presto a essere il setaccio delle sue ansie, della sua angoscia, del suo terrore di invecchiare e di morire, fino ad abitare le sue paure, a svegliarmici dentro il mattino.
Mi lascio trapassare dalle sue parole lamentose, ne filtro la paura e gliene restituisco di chiare, trasparenti, piene di speranza. Ho ingoiato i bocconi amari delle sue rughe, delle sue rare patologie, della sua solitudine. Trascinata fuori da me, mi sono allenata alla vecchiaia e alla decadenza di corpo e mente, in un trailer ripetuto all’infinito. Per interposta persona, ho già sperimentato il collare di rughe sul collo, le chiazze di pigmentazione cutanea, i dolori articolari al punto di stupirmi quando lei mi butta lì l’impietosa previsione mista a minaccia e a vendetta di quel “Vedrai come è difficile invecchiare!”, senza vedere che sono già vecchia per osmosi, per il principio dei vasi comunicanti, parte degli anni e degli acciacchi materni mi appartengono, li sento nel corpo.
Eppure questa è la madre che mi sommergeva di fotografie fin dalla nascita, documentando ogni mio impercettibile cambiamento nel mirino della macchina fotografica, intercettando le mie prime, smorfie. E’ questa la madre che non sapevo lasciare sulla porta della scuola materna, che attendevo per ore sola, senza giocare, senza mescolarmi con gli altri bambini, seduta sulla panchina rossa nel cortile della scuola. E’ questa la madre che mi mancava fino a togliermi il respiro in colonia in montagna, quando tutte, proprio tutte le sere piangevo e mi struggevo nella nostalgia… E’ questa la madre che se ne stava seduta facendo la maglia mentre ripetevo gesticolando per casa il nome di ossa e muscoli prima dell’esame di anatomia, che mi ascoltava o fingeva di farlo, presente, silenziosa, pronta a caricare la caffettiera al primo intoppo.
A volte mi drappeggio intorno agli occhi una raggiera di rughe, così per prenderci ancora più confidenza, per portarmi avanti. Quelli sono i giorni in cui riesco a provare pietà per me stessa, a intravvedere la fatica inutile, dietro i pensieri che si snodano nel cervello di una brava figlia.
La guardo mentre preda di un’ansia nuova, rifiuta di governare la paura e si abbandona al flusso di emozioni infantili che snocciola come i grani di un rosario, sicura che parlandomene se ne libererà. E’ così che funziona fra di noi fin dalla mia infanzia: lei apre il pozzo delle sue angosce, le sue parole si gonfiano come vele e fluiscono nel fiume dei miei giorni, da tempo immemore. E io, che ho anticipato il tempo, che ho superato in corsa la mia vecchiaia con la sua, non posso che diventare sempre più abile a portare pesi, inarcando un po’ la schiena, sempre più curva sotto una gerla altrui eppure mia.
La ricordo seduta sul bordo del mio letto quando un amore adolescente svaniva, pronta all’ascolto, sempre attenta, mentre mi pronostica una vita meravigliosa e si butta a cucinare un budino che divoriamo. Le sue parole sapevano attenuare dolori, aprire varchi in terreni aridi, pur nell’incapacità di gesti, nella negazione di abbracci o di baci. La fisicità le è sempre stata preclusa, il suo campo da gioco erano le parole.
La sento cantare canzoni d’amore in macchina o mentre camminiamo in montagna o accennare qualche aria della Carmen o della Traviata nei rari momenti in cui il dover essere si assopiva.
Ma anche allora, quando la vicinanza pareva intimità, sapeva brandire con arte l’arma invisibile del ricatto. Con fine intuito sapeva portarmi lì dove lei credeva dovessi stare, al punto da annebbiarmi completamente la vista, da trafugare il mio sentiero di soppiatto, aprendo il sipario su una strada asfaltata a doppia corsia di suo gradimento.
A volte la sento affannarsi a frugarmi nell’anima con il chiaro intento di rubare, non so bene cosa, forse quello che lei crede essere la mia riserva di vita cui potrebbe attingere senza riserve, se questo fosse decoroso. Detesto la sua rapacità celata in quell’aspetto inoffensivo che trattiene gli artigli, nella finta debolezza di una donna che non si è mai piegata e neppure flessa per un istante, ben concentrata su una bussola costantemente orientata verso di sé.
Le telefono da Maidstone, al primo anno di università, spaventata dalla mia disavventura britannica, nella speranza che mi richiami, che mi riaccolga a casa. E invece lei fa leva sul mio desiderio e mi spinge nelle fauci di Londra, dove sogno di andare da anni. Infonde fiducia nelle mie vene, mi garantisce che ce la posso fare, che devo solo allungare una mano e aprire le dita. E’ lei, più di mio padre, a farmi udire il richiamo del mondo, a sostenere la mia fuga, a dare voce alla mia inquietudine. Londra la devo a lei. A lei devo dunque anche l’uscita da casa, pur nel suo confuso tirare e mollare l’elastico della mia adolescenza.
Derubata, quando la guardo, istintivamente tendo a rannicchiarmi ancora di più in me stessa, immergendomi sempre più a fondo per non essere catturata dalle sue dita lunghe.
E’ in quei momenti che percepisco la sua volontà di trascinarmi con sé fino alla morte, oltre la morte, non per amore ma per non essere sola, per attenuare il suo terrore, per conservarmi come devoto balsamo filiale. Saprò sottrarmi quando sarà il momento o mi lascerò scivolare, ancora incapace di frapporre qualche centimetro fra di noi?
Con stravagante ingenuità provo a mettermi contro il suo tempo, contro il tempo, con i talloni puntati. Provo a lasciare emergere il buono che so esserci stato. La rivedo che mi fa compagnia ad ogni ciclo di chemioterapia, quando i farmaci inondavano di gelo le mie vene e cominciavo a battere i denti. Eccola che si alza, si procura un’altra coperta e mi asciuga il sudore freddo dalla fronte, senza una lacrima, lei che piange per nulla. Durante la mia malattia non ha mai ceduto in mia presenza, si è presa cura di me senza battere ciglio, come fosse stata certa delle mie chances, come se la mia sopravvivenza non fosse mai stata in dubbio. Lei, terrorizzata dalla sua morte, sedeva accanto alla mia con dignità, con fiducia, come un soldato al fronte, certo della vittoria.
Mi impegno a scrollarmi di dosso il risentimento e le antiche pendenze. E’ vecchia e a una vecchia non si fa la guerra. Semplicemente la si digerisce così, la si accudisce, la si sopporta clementi.
Ma la clemenza mi fa difetto e inciampo, riluttante, nelle mie stesse acrobazie scomposte. Sento il frastuono dei suoi ferri da calza che incrociano la falce della Grande Signora. So che si sta allenando al grande passo, ma il rovescio delle sue paure ha un sapore troppo amaro. Come un’attrice prima del debutto si sforza di contenere l’angoscia, nella vana ricerca di un appiglio, di un senso, di una seppur minima speranza. Interroga tutto e tutti: Dio, la scienza, il delirio ed ovviamente me che imbastisco balbettii compassionevoli che sopravvivono giusto una sera.
Nel suo inespugnabile tormento, vive nel terrore di quella prova suprema, di quel torrente che la porterà via e che percepisce vicino almeno da trent’anni, senza neppure il buon gusto di vedere che gli unici piedi che lì si sono immersi sono stati i miei.
Forse questo non lo può guardare, forse per una madre la morte di una figlia risulta così intollerabile da non poterla neppure sfiorare con il pensiero. E il suo amore materno non lo posso mettere in dubbio. Ma l’amore materno ha mietuto non poche vittime.
O forse è ancora lei al centro del suo mondo e del mondo intero. Forse invecchiando il mondo si restringe fino al cerchio che le proprie braccia possono disegnare intorno al corpo e quello diventa l’unico mondo visibile, la patria.
Il rancore si tende dentro di me come la corda di un arco, pronto a scoccare una freccia che non partirà, che non saprà ferirla, che non potrà difendermi. Le sue narici fremono nella sua quotidiana questua e lei annaspa in attesa che io spalanchi il mio cuore pavido e alleggerisca la sua ansia di oggi. Ma un muro sottile e trasparente si erige fra di noi, la mia volontà recalcitrante temporeggia, sta a guardare e la mano resta in tasca.
Il suo collo si inclina, sinuoso come un rettile, in quella postura sofferente che chiede la pietà che oggi stento a concederle, finché mi accascio esausta e offro i padiglioni auricolari che non riesco a scollegare dall’anima, alle sue lagnanze di oggi. Mi sforzo di ascoltare senza sentire, di anestetizzarmi saggiamente, come non ho mai saputo fare. Intercedo per me stessa e cerco di essere un vaso bucato sul fondo, da cui transitano le sue parole senza lasciare impronte, senza ferire, senza incidere ricordi. Fingo che non si tratti di mia madre ma del racconto di una paziente senza nome, cui non devo nulla se non un’empatica accoglienza. Provo a mettere distanza fra di noi a escogitare la giusta postura.
Sono in piedi sul tavolo della cucina mentre lei appunta gli spilli all’abito rosso che indosserò per la mia prima festa. Come tante altre volte, lei maestra, si cimenta con ago e filo e ne tira fuori capi graziosi che io indosso dall’infanzia all’adolescenza e anche oltre. La vedo china con gli spilli incautamente fra le labbra, che osserva prima l’orlo e poi l’insieme del vestito, visibilmente soddisfatta di sé. Così come quando finisce un maglione da sci stile jacquard, con le renne e i pini colorati che mi terrà caldo sulle piste.
La guardo con sconforto mentre, dimentica di me, incurante delle ferite che si producono sul mio corpo, versa i suoi fluidi, incontinente. Sento la sua fame di vita, della mia vita. La vedo mentre scavalca la montagna della sua paura attraverso il mio ascolto, grazie al mio orecchio, al mio timpano a brandelli. La osservo mentre si accarezza l’anima ormai rassicurata, riorientata nel suo tramonto.
Ora mi corregge i compiti e con la testardaggine della maestra mi convince a riscrivere tutto da capo, in bella calligrafia, ad essere brava, sempre più brava. Lei che la scuola ha dovuto implorarla con le lacrime, vuole che io studi, che ottenga ottimi risultati, che realizzi sogni…. io che posso.
Asciutta, scattante, angolosa, con quel che di arrogante sul fondo, quello sprezzo simil nobiliare che segna come un marchio le donne della sua stirpe confligge con l’immagine di madre accogliente, magari un po’ grassottella, rassicurante, avvolgente, silenziosa, serena che un tempo, nella furia di guadagnarmi un posto nel mondo, avrei liquidato come remissiva e scialba.
Ogni giorno mi presidio e mi propongo di non concedere nulla al suo crepuscolare lagnarsi e ogni giorno le consento di infilarsi nel mio spazio intimo, suo luogo d’elezione, melliflua, spargendo germi che non so arginare. Allora divento ostile, carica di una rabbia impotente che si spegne in tristezza.
Ed ecco che lei, eludendo il mio sguardo, fa la sua mezza giravolta e, come se avesse parlato di cucina, con il suo sguardo sicuro, intavola una chiacchera sull’opportunistico nulla quotidiano.
Sopporto il mio castigo consolandomi al pensiero che di lei conosco anche il non detto mentre lei di me sa poco e nulla. Ma non basta per continuare a fare da materasso delle botte.
Cerco di guardarmi come potrebbe vedermi un altro, di pensare ciò che un estraneo penserebbe di una donna attempata ancora ostaggio di sua madre. Ma ho troppa intimità con me stessa per potermi guardare a distanza. Un accenno di sorriso sghembo si fa strada al pensiero che lo faccio per lei, nel disonesto tentativo di spacciare per amore filiale l’incapacità di difendermi, di mantenere una distanza di sicurezza.
Ma nelle sue mani legnose affondano le mie radici, in quella terra scura in cui ha germogliato l’algida donna che è stata sua madre e l’austera vecchia che è stata sua nonna. Una genealogia femminile così poco femminile, orfana di dolcezza, incapace di carezze, maestra di regole, di sobrietà e di decoro. Quanto di quelle donne arcigne scorre nelle mie vene? Quali angoli mi è stato consentito smussare e quante le timidezze e le ritrosie che ho potuto solo sopportare?
I miei rami si allungano verso l’azzurro dove le mie figlie germogliano, stupende nella loro sfaccettata trasparenza. Quanto so di loro? Quanto sanno di me? Quanti baci ho saputo concedere e quanti negare?
Quanto ingombrano nei loro giorni le mie radici, quelle di mia madre, di mia nonna e di sua nonna? So per certo che di queste radici hanno consapevolezza e questo per ora mi basta.
Cerco di mettere la sordina ai ricordi ma lei compare sugli sci con il suo pullover azzurro cielo, o mentre cammina sui pendii di montagna o distesa al sole come una lucertola, o impegnata nel vano tentativo di imparare a nuotare. Eccola che sfodera la tovaglietta a quadretti bianca e rossa sul tavolino da picnic issato sulla neve. Ecco noi bianchi e rossi dalla fatica che ci godiamo le tagliatelle al ragù al sole d’inverno. E poi ancora neve, ancora sci e freddo secco sul viso e sole e tutto il bello e il buono dell’esser bambini.
Cerco le mie tracce mentre mi appoggio con i gomiti alla mia immagine sbiadita, tiepida e priva di coraggio, smentendo la mia propensione al taglio. Nel mio corpo si fa strada un’eco che non so decifrare ma che si sente sul fondo mentre increspa le onde, lì dove i sospiri si fanno supplica. Vado a caccia di vento e osservo il mio inutile insabbiarmi nell’autobiografia, in un’epoca del mio vivere che dista millenni dall’infanzia e che non mi dà titolo di appellarmi ad un’allora paleolitico.
Provo ad archiviare ciò che è stato, a interrompere quell’insensato ricordare, interrogare, attribuire responsabilità e meriti che non mi porterà da nessuna parte. Non ci sono matasse da sbrogliare, bisogna lasciare tutto lì dov’è, prendere quel denso magma che chiamiamo passato e metterselo in tasca, tenerlo lì senza continuare a stuzzicarlo a tormentarlo. Tenerlo lì con le sue grinze, con le sue spine e i suoi arcobaleni, a contatto con il corpo da cui non può separarsi.
Con mansuetudine, il mio cuore invertebrato e polveroso arrotola le mie scintille di irritazione, il mio impotente nervosismo che si distende come ragnatela sulle sue parole e sulla mia fiacca rinuncia a tenermi presente a me stessa. Liquido sommariamente le mie perplessità in un ennesimo avvitamento, amputando le mie possibilità di oggi e forse anche quelle di domani, nell’estremo tentativo di uscirne viva.
Cerco in me il perdono, per lei e per me. Cerco un po’ di tregua, provo a raschiare via gli strati di rancore dall’anima, a lasciare andare, prestando ascolto ad altro, nella ricerca di quel grembo che ho abitato, di quel confine incerto fra il nascere e il morire, in quel tempo irrecuperabile alla memoria in cui il suo desiderio mi ha messa al mondo.
Ma i nodi non si sciolgono nel mondo visibile e, nel mio confuso annaspare, cerco un ormeggio in quel miscuglio di bene e di male, di tentativi e di rinunce, arrendevole come l’acqua. Ascolto il risuonare del silenzio, guardo il disordine del mio presente, il mio quotidiano scacco totale. Lascio emergere la mia opacità impermeabile che per ora posso solo osservare.
Cerco in qualche mio doppio fondo un po’ di compassione per lei, per me, mentre sento la sua vita gocciolare via, e con la sua la mia.