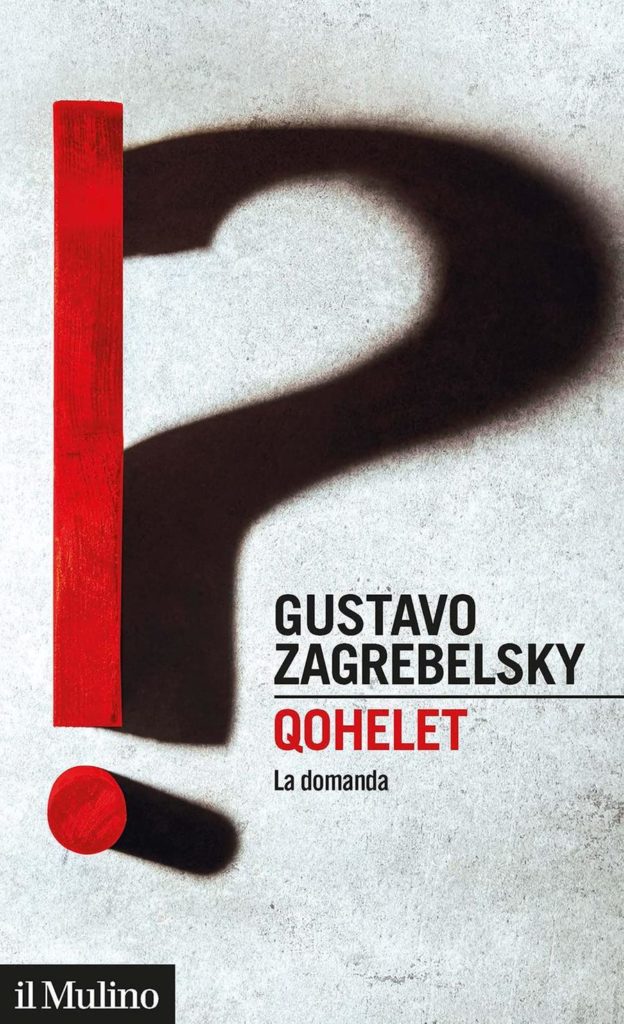
Gustavo Zagrebelsky, Qohelet. La domanda, il Mulino 2021 (pp. 162, euro 14)
“V’è tempo di nascere, e tempo di morire”, “di piangere e di ridere”: chi non ha sentito, o detto, in occasioni e contesti diversi, massime simili, magari dimentico della loro fonte? Il Qohelet – o Ecclesiaste, in quanto immaginato dal suo ignoto autore, fra il III e il II secolo a. C., come un seguito di proposizioni da proporre a un’assemblea di uditori – è una miniera di citazioni, assemblate senza un ordine preciso, a volte contraddittorie, ma collegate da un concetto preciso: tutto è vanità, comprese la vita e la morte, compresa la meditazione che su di esse si può fare. E questo proprio perché la morte azzera ogni significato, ogni scopo.
Buona parte del discorso di Zagrebelsky, appassionante nonostante la stringente consequenzialità degli argomenti e il rigore dell’analisi, logica e filologica, è dedicato a leggere un testo interpretato nei modi più disparati, un testo che ammette in effetti di essere letto secondo culture, posizioni filosofiche e religiose, ma anche propensioni individuali fra loro differenti e divergenti e che si presta certamente ad essere attualizzato nel tempo che viviamo, il tempo del disincanto: come critica di ogni idea di progresso, come presa di distanza da un mondo che insegue la buona vita se non la felicità in una produzione e in un consumo incontenibili di merci, come controcanto al dilagante rifiuto della vecchiaia, e della morte. Ma attenzione: ogni attualizzazione è al fondo la “pretesa che testi antichi siano stati scritti per parlare non a noi, ma di noi”, per cui “Le operazioni attualizzanti sono sospette, strumentali, fastidiose. Non servono a penetrare nel ‘significante’, ma a strumentalizzarlo a favore di un ‘significato’ che sta a cuore a colui che attualizza. Più che a capire, servono a giustificare, a usare parole altrui per rafforzare, duplicandole, le proprie. Sono strumenti retorici per coprire difetti di argomenti: ‘vedi, non lo dico solo io’”.
E dunque? Non resta che storicizzare, contestualizzate il Qohelet? No, non occorre affatto rigettare le risonanze che il testo ha per noi che lo leggiamo oggi, a patto che non si faccia dell’autore un sociologo ma se ne ascoltino le parole come ammonimenti e constatazioni che ci riguardano in quanto uomini, come risposte – variamente interpretabili, discutibili – a domande che in condizioni del tutto diverse gli uomini hanno continuato a porsi. E tra queste la domanda: “Si può vivere nel corto circuito della paura di una morte che ostacola la vita?” Perché questo è il dato di fondo, che rende (sempre) “attuale” questo testo: “La disperazione di Qohelet è l’incombenza della morte sulla coscienza. Non è la morte in sé. (…) Parla della morte come ‘prospettiva’ e degli effetti, per così dire, retroattivi che tale prospettiva produce nella vita dei viventi”. La morte come “un’immagine velenosa che grava sulla vita quotidiana”, di fronte alla quale la nota formula di Epicuro per sfuggire alla paura della fine (“quando noi siamo, non c’è la morte, e quando c’è la morte, noi allora non siamo”) si rivela “uno sberleffo intellettualistico”. Perché “La morte sconvolge il gusto della vita”, e la “paura invincibile della morte è l’altra faccia della fame insaziabile di vita”, tanto più in un tempo nel quale nessuno giunge mai ad ammettere di aver vissuto abbastanza. In un tempo nel quale è ormai un’eco lontana e non un’esperienza vissuta – per i più, almeno – la raffigurazione della morte come un “ricongiungimento al ritmo naturale della vita” o “a una vita che ci attende oltre la morte”. Nel nostro tempo, il tempo dell’individuo, la morte è “la totale debellatio della pretesa centralità ed esclusività dell’Io”, “un risucchio dalla vita al nulla”, “un’azione uguale e contraria” alla nascita che fa della vita una parentesi fra due identici nulla.

Una domanda senza risposta, perciò, quella che ci percorre e la lettura del Qohelet stimola? O la prospettiva di lasciare ricordi negli altri può attenuare la paura della morte? Ma “quanto dura il ricordo”, si chiedeva già Norberto Bobbio nel suo De senectute?
La risposta – dal momento che i ricordi sono labili quanto i sogni – è da cercare nei “segni” che ognuno lascia “impressi nelle vite seguenti”. È questo “accumulo di segni” che chiamiamo “umanità”: “Il risultato degli innumerevoli segni che sono venuti depositandosi nel corso delle generazioni è l’umanità quale essa è e alla quale partecipano i viventi. Essi, che ne siano consapevoli o meno, portano in sé la vita dei predecessori, dei quali hanno per lo più perduto il ricordo, ma che non per questo sono assenti dalla loro vita”. Pensarlo, mi permetterà di non considerare “vuoto, futile il tempo che mi è dato di vivere. Non è tutto ma, rispetto al niente del Qohelet, è moltissimo”.
Trovata la soluzione dunque? Un saggio a lieto fine, questo di Zagrebelsky? No, e non solo perché aderire alla sua conclusione sembrerebbe richiedere una sorta di atto di fede, lo sforzo di credere nonostante tutto, nonostante l’inconsapevolezza dei posteri, ma anche perché il “diritto al segno”, “un diritto umano e fondamentale e universale” quanto quello alla vita, è in molti casi, in intere parti del mondo, in interi strati della popolazione, negato. Ma non è tutto: anche nelle nostre società, anche in tempo di pace e di benessere e di democrazia, “perché si possa parlare di umanità occorre un “contesto adeguato”. “Una somma di indifferenti non crea società e, al tempo stesso, nega il diritto al segno”. Altrimenti il “diritto di non passare sulla terra invano (…) è privo di significato”, e “La significanza appartiene non alla legge e ai tribunali, ma alla morale collettiva”.
E qui siamo fuori, oltre il Qohelet. L’autore lo dice esplicitamente del resto: la sua conclusione non appartiene a quel testo: “È una meditazione a partire da”. Una meditazione – ecco la conclusione vera – il cui “punto di partenza e d’arrivo (…) è il rigetto della visione lugubre della vita”, un “atteggiamento” che non si basa su riflessioni né implica fedi, “un atteggiamento spontaneo di chi sa provare le gioie che s’incontrano lungo i giorni della vita e le pregia più dei dolori che immancabilmente incombono. È un atteggiamento che tuttavia, deve fare i conti con l’inesorabilità della morte”, avendo però presente che “Chi avrà la fortuna, o la grazia, di dire sì [alla vita] avrà sconfitto la tristitia con un sovrappiù di laetitia fino al momento estremo della vita”.
È questo innanzitutto il “segno” che possiamo lasciare, che più tardi di altri segni si dissolverà?
Questo testo compare anche nel sito della nuova libreria Rinascita di Brescia, alle cui attività culturali Carlo Simoni collabora.
