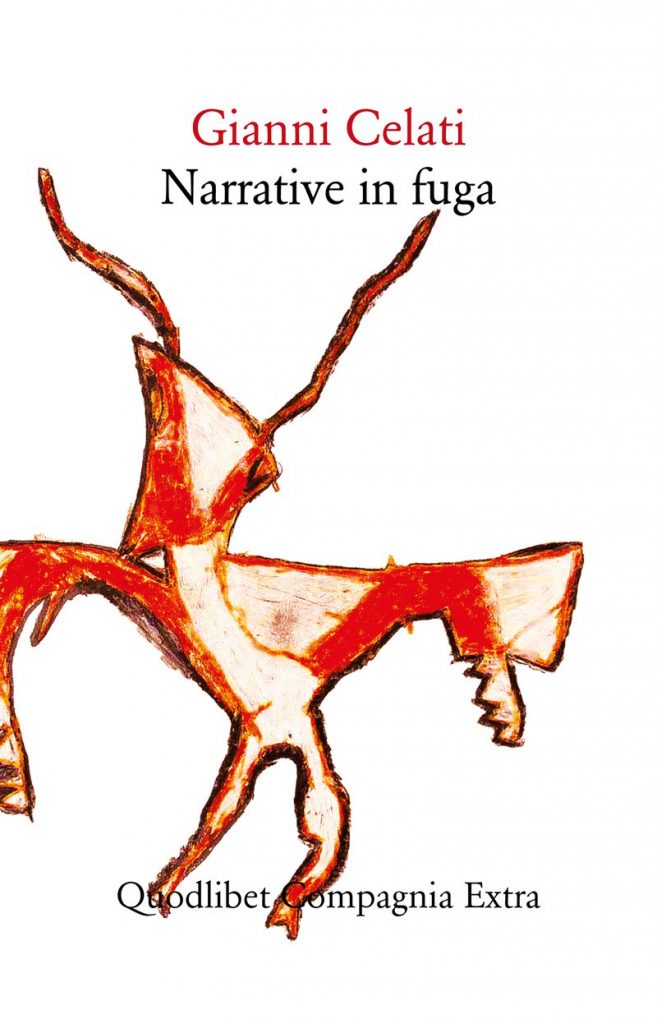
Gianni Celati, Narrative in fuga, Quodlibet Compagnia Extra 2019 (pp. 342, euro 18)
Testi critici che assumono a tratti l’andamento del racconto, una saggistica che si fa narrativa senza mancare il suo obiettivo critico: solo uno scrittore come Celati, traduttore oltretutto (di Céline come di Joyce, di Swift e di tanti altri), può scrivere in questo modo dei suoi autori. Una scrittura che appare il seguito naturale di un incontro con gli autori maturato nella lettura e nella rilettura. Più giovane di Calvino, Celati ne riprende il modo di parlare delle opere lette, e rilette. Forse anche in forza del legane intellettuale e umano che li legava (ampiamente documentato nelle note contenute nel Meridiano che raccoglie gli scritti di Celati, pubblicato nel 2016).
Scorriamo alcuni passi nei quali appare evidente quel di più che uno scrittore sa mettere nei suoi commenti, riuscendo ad arrivare fulmineamente, con pochi tratti, sintetici ed esatti, a delineare personaggi e autori: prerogativa del Tom Sawyer di Mark Twain non è una generica arte di arrangiarsi, ma una vera e propria “alleanza con il mondo”; il narrare di Jack London ha “la fluidità del racconto panoramico – il racconto immerso in un tempo vago e dilatato, che attraversa rapidamente gli eventi. È il modo più semplice di narrare: quello dell’epica e delle fiabe, senza elaborate costruzioni, senza presentazioni psicologiche”; “L’improvvisazione è il metodo compositivo adottato da Stendhal in tutti i suoi libri, senza piani di lavoro preordinati (…) Si tratta di affidarsi a un estro estemporaneo, irriflesso e non programmabile, in cui la rapidità di scrittura serve ad evitare quel congelamento delle parole che nasce da una dissociazione tra il pensiero e la cosa che si sta scrivendo”, e si cita a conferma lo stesso Stendhal: “Non riesco a fare piani di lavoro se non dopo, analizzando quello che ho trovato. Il piano di lavoro fatto in anticipo mi agghiaccia. (…) Io ho sempre scritto come Rossini scrive la sua musica…”; “La cura céliniana consiste nel rompere la concatenazione scontata tra le frasi, attraverso l’uso dei tre puntini che indicano le pause ritmiche in cui la voce rimane sospesa. (…) Céline elabora un modo di scrivere dove la scrittura diventa una specie di spartito, capace di notare ritmi e tonalità delle parole. (…) Se confrontiamo questa lingua con quella standard dei libri di successo, viene da pensare che gli attuali libri di successo corrispondano ai cosiddetti non luoghi (luoghi uguali in qualsiasi parte del mondo si trovino), mentre quelli di Céline corrispondono a un’isola oceanica poco accessibile, quasi disabitata”; “Swift scrive come un alieno che vede l’umanità come una specie votata al falso, presa all’amo da tutti gli inganni. Il suo è un tono così innaturalmente distante che lascia di stucco; ma anche con improvvise invettive o sarcasmi che mettono a disagio il lettore in cerca di conforti nella carta stampata”; il modo di narrare di Flann O’Brien, Joyce, Beckett non è “più consacrato alle rappresentazioni della coscienza, ma a qualcosa che le perturba e le disperde nel silenzio; ed è un modo di narrare che si rivolge a lettori che non credono più alla falsa concretezza dei fatti, del fattibile, del verosimile, dell’attualità…”. E su Joyce, in particolare, e il suo Ulisse: “Il punto focale della peregrinazione di Mr Bloom è la vita qualsiasi, la vita senza niente di speciale, la vita come un sogno o un lungo chiacchierare con se stessi.”
È tuttavia nei due saggi che aprono e chiudono la sezione dedicata agli americani che la lettura di Celati si fa scrittura che coinvolge, quanto le opere di quelli.
Bartleby innanzitutto, e il suo “avrei preferenza di no”: perché “questa vicenda ci lascia più pensosi di ogni altro racconto moderno?” Per via dei caratteri del personaggio: “imperturbabile e laconico, sordo ad ogni ragionevole persuasione” ma anche, si badi, “inespugnabilmente mite”, e “figura di ciò che non può essere salvato” e allo stesso tempo “di chi non ha nessuna voglia di farsi salvare”, chiuso in “austero riserbo” venato di una “sbiadita altezzosità”. E via di questo passo: lo conoscevamo, lo scrivano di Melville, ma è come se lo incontrassimo solo adesso, riportandone una lezione che va al di là del personaggio e dalla sua ritrosia a parlare trascorre al significato dello scrivere: “La potenza della scrittura non sta in questa o in quella cosa da dire, ma nel poco o nel niente da dire, in una condizione dove si annulla il dovere di scrivere. Ogni voler dire e dover scrivere è la patetica vittima delle proprie aspettative. La potenza della scrittura sta nella rinuncia al dovere di scrivere, nella sospensione delle aspettative…”.
La centralità di Bartleby nell’esperienza – non solo letteraria e culturale, ma anche umana e professionale – di Celati trova conferma nella sua presenza del personaggio anche nel saggio più ampio del libro, le Storie di solitari americani”, in cui non un singolo autore ma il filo che li lega costituisce il tema di fondo: la solitudine. La solitudine, il suo dilagare, il suo assumere forme diverse nel XIX e XX secolo, in America ma non solo.
In Hawthorne – nel suo inimitabile racconto Wakefield, in particolare –, in Poe, in Melville, appunto, “si profila uno stretto legame tra la solitudine in cui [i personaggi di questi autori] si sono smarriti e l’inevitabile caduta cui tutti siamo destinati. Quello è il legame che i linguaggi consolatori debbono spezzare, per nascondere l’angoscia che produce; ma per farlo debbono stimolare una perpetua fuga dal pensiero della nostra caduta. Il laconismo di Bartleby è invece un modo per aderire alla caduta, allo smarrimento dei traffici quotidiani, al destino di alienazione da se stessi, e infine alla propria morte” e rappresenta così una “figura non mitica ma fraterna, che riporta la vita alla sua insignificanza naturale, perché la fa coincidere col semplice scorrere del tempo ed esaurirsi delle forze.”

Dopo i racconti di Hawthorne, Poe e Melville, che “trascinano verso una riflessione sull’ordine sociale, sui suoi limiti, sui suoi margini di estraneità e pericolo”, in cui “la solitudine prende un senso nuovo”, si diffondono le short stories, nelle quali tutto è “casalingo, familiare” e l’umanità che vi compare “facilmente comprensibile”: è “l’invenzione della normalità”, l’affermarsi di una narrativa rassicurante. Unico a non piegarsi al nuovo corso, Henry James, che continua la riflessione sulla solitudine moderna e “non (cede) alla tentazione di spiegare che cosa c’è nella testa degli altri”. La sua reticenza è una forma di resistenza alla “volgarizzazione moderna (che) fa tutt’uno col mito della comunicazione sociale, che seppellisce l’incomprensibile della vita sotto strati di parole morte” e ridefinisce la solitudine, la quale “non sta più nell’essere soli, ma nel non poter evadere dalla sterilità dei copioni che dovunque si recitano per dovere” tornando “sempre agli stessi incastri nevrotici che coincidono con i costumi delle società civili.”
Jack London, consapevole di questa involuzione, crea storie ambientate nei “deserti artici come esperimenti mentali per immaginare cosa può essere la vita fuori dagli schemi immunitari delle società moderne che la riducono a un insieme di meccanismi previsti”, quando invece è una “radicale incertezza sulla propria morte che segna tutta la vita dell’animale umano.”
L’eredità di London sarà raccolta da scrittori come Hemingway, caratterizzati da “un laconismo che indica una solitudine di fondo, ma anche (da) un riserbo dettato dalla difficile condizione dell’esperienza individuale”, destinata a una sostanziale cancellazione non colmata da “mitologie della libertà interiore”, ma piuttosto – come in uno dei primi racconti di Gertrude Stein – da un’identificazione con una socialità in cui ciò che avviene è “l’annientamento dell’individuo”. Come in Stein, così in Sherwood Anderson e in Hemingway “troviamo personaggi che sembrano estranei a tutto, con cui non possiamo identificarci; ma personaggi che lasciano il segno del loro laconismo e della loro solitudine nella forma narrativa, nel tono delle parole che parlano di loro; per cui quei racconti diventano come verbali della loro estraneità e assenza d’espressione”. E insieme denuncia della “chiacchiera” che serve “ad abolire i silenzi mascherando la solitudine con una parvenza di integrazione in un gruppo; e siccome è un parlare che ripete ciò che è stato già detto da altri, come se tutto fosse sicuro e scontato, la chiacchiera estende ad ogni incontro un’idea di normalità come regola di vita”, una vita “ovvia, prevista o prevedibile, risolta o risolvibile nel migliore dei modi”, in ogni caso obbediente all’”imperativo categorico di mostrarsi agli altri sempre felici della propria situazione”, all’“imperativo ‘Smile!’”, “segno d’un’integrazione sociale di rappresentanza”.
Celati parla di autori del passato, ma è il nostro mondo a emergere dalle sue parole.
Questo testo compare anche nel sito della nuova libreria Rinascita di Brescia, alle cui attività culturali Carlo Simoni collabora.
