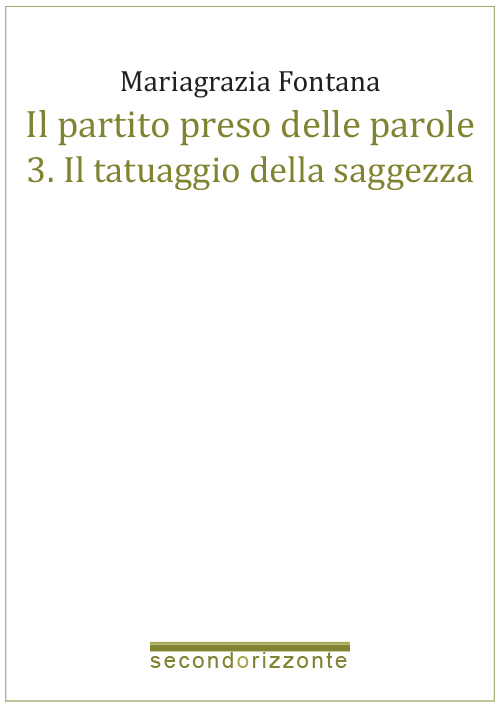
3. Il tatuaggio della saggezza
Sei in ritardo, non è che stanotte ti sei data alla pazza gioia? – le chiede Paola con quel sorrisetto malizioso di una che sa bene come si sta al mondo. Gioia non proprio, diciamo che non è andata malissimo – le risponde Angela, il viso struccato e pallido.
Lavorano insieme da anni e, si sa, lavorare gomito a gomito, inspirare lo stesso vapore, sopportare il peso del ferro da stiro professionale, sudare insieme facilita la confidenza e si diventa un poco amiche.
Le donne poi non ci mettono molto a sbottonarsi, a raccontare tutti i fatti loro. Sembra che non vedano l’ora di vuotare il sacco, come se a nominarle, le cose si facessero più lievi. Anzi a volte le ammorbidiscono loro intenzionalmente, ci mettono quel dolce che fa romantico e che nei fatti, nudi e crudi, non c’era proprio.
Dimmi che questa volta non è uno dei soliti sfigati, ti prego. Dimmi che è un ragioniere, un commesso, almeno un benzinaio – chiede Paola, che da anni spera in cuor suo che Angela si dia una mossa, che esca da quel pantano di tristezza, di svogliatezza in cui è sprofondata. Se la vede sfiorire davanti lentamente, senza piangere, senza lamentarsi, senza mettersi contro una vita che va storta da tempo, incapace di sintonizzarsi sulla frequenza dell’ottimismo.
E lei a spingerla, a tenerla su, a ripeterle che ha chance da vendere, che solo non sa vederle, come se non volesse darsi un futuro. Ma le parole, quando una è a quel punto, sono vento che corre senza lasciare traccia. Magari a forza di ribadirle, almeno un’eco nella testa di Angela sarebbe rimasta – si ripeteva Paola che non riusciva a smettere di provarci.
Un tempo era diversa, era una ostinata, una da bicchiere mezzo pieno. Di legnate ne aveva prese parecchie, ma aveva sempre rialzato la testa, orientando il corso dei suoi pensieri verso il meglio. Poi, a un certo punto, s’era afflosciata come un budino tremulo, le fibre del suo cuore s’erano fatte fragili, come se nella sua vita interiore si fosse esaurita la speranza. Aveva cominciato ad accompagnarsi solo con sbandati, con gente che bivaccava ai margini dell’esistenza. Cattivi no, solo pieni di guai, di garbugli che lei s’ostinava a provare a dipanare. Come se i suoi guai non fossero sufficienti!
Un intellettuale non è di certo, neanche un impiegato, mai visti impiegati così mal ridotti.
E rieccoci con un altro perdente, chi te lo fa fare di metterti sempre con uomini sconfitti dalla vita? Mica li devi salvare proprio tutti tu – ribatte Paola cui si srotola davanti un film già visto, destinato a un finale da schifo.
Non è che Angela li scegliesse apposta gli uomini tormentati, è che ne era attirata come un’ape da un fiore, è che le sembravano gli unici con un po’ di fascino.
Che cosa se ne sarebbe fatta di uno sbruffone, di un vincente sicuro di sé, di quelli che ti pagano la cena in un bel ristorante e ti fanno fare la bella vita? Che poi uno così, mica avrebbe perso tempo con una come lei, che di lavoro stirava, che non poteva neanche farsi crescere le unghie perché le si spezzavano maneggiando i panni, che aveva i capelli sempre crespi per via di tutto quel vapore.
In realtà uno buono ce lo aveva pure nel suo curriculum, uno per bene, intelligente, ma senza il becco di un quattrino. Allora si era offerta lei di lavorare per due, di prendersi anche i turni di notte all’hotel di suo cognato che venivano pagati bene, e un poco riusciva anche a dormire.
Così stirava di giorno e lavorava alla reception di notte, intanto che lui si impegnava a finire l’università. Era una buona causa, e poi lui era così bello, così dolce, e la trattava come una regina. Era durata quasi quattro anni la faccenda del doppio lavoro e lei non l’aveva fatta pesare mai, perché lui gli esami li passava, studiava e non si perdeva in chiacchiere.
Si trattava di tenere duro solo qualche anno, poi lui si sarebbe laureato, avrebbe trovato un posto come ingegnere con uno stipendio dignitoso, e lei si sarebbe riposata. Magari avrebbero anche messo su famiglia, casa con giardino e pure un paio di figli o tre, che a lei i bambini piacevano un mondo.
Era andata diversamente, ovviamente. Non perché lui dopo la laurea l’avesse mollata, non si era montato la testa e la gratitudine non gli era mancata. Era stata lei ad andarsene, come se si sentisse fuori posto al fianco di un laureato che indossa camicia e cravatta.
A decidere era stata quella storia della gravidanza che aveva rotto l’incantesimo. Lei il figlio l’avrebbe tenuto, non le sembrava vero, mettere al mondo un altro essere umano, fare qualcosa di buono, di indiscutibilmente buono. Che cosa c’è di meglio, di più di una vita?
Era lui che non si sentiva pronto, diceva che era presto, che ora lui avrebbe dovuto pensare al lavoro e alla carriera, che lei avrebbe dovuto avere pazienza. Ma lei la scorta della pazienza l’aveva esaurita da tempo e quel figlio lo voleva. Certo non l’aveva cercato, ma se era arrivato voleva dire che andava bene così, che era ora. E lei si sentiva pronta, pronta e felice.
Alla fine era andato tutto storto. La sua versione dei fatti era che il bambino, anzi quel grumo di cellule che sarebbe potuto diventare un bambino, si fosse sentito mal accolto, che avesse capito che era solo lei a volerlo, mentre lui, il figlio, li voleva tutti e due, un padre e una madre. Allora s’era sciolto in un flusso di sangue e in una decina di contrazioni dolorose.
Non era riuscita a perdonarlo, non aveva avuto la pazienza di aspettare, di riflettere, perché lei dentro lo sapeva che era stato lui a mandare via il bambino, che se ci avesse provato solo un poco, magari il piccolo si sarebbe lasciato convincere a venire al mondo. E poi ci avrebbe pensato lei, non avrebbe chiesto niente, gli avrebbe lasciato tutto il tempo per il suo lavoro e la sua carriera. Che in fondo c’era da capirlo, tanto studio per poi non farne niente, non c’era neanche da pensarlo.
E’ che sotto l’ingegnere non c’era più il ragazzo che lei aveva amato, quello che un figlio l’avrebbe tenuto caro. Ora s’era fatto serio, sempre concentrato su qualcosa. Niente sorrisi, di ridere poi non se ne parlava. Forse gli uomini, quelli responsabili, sono fatti così. Forse per lei andavano bene solo i ragazzini o gli spiantati. Perché a lei ridere piaceva proprio, soprattutto la sera quando era sopraffatta dalla stanchezza, aveva voglia di aprire un’ultima parentesi d’allegria nello sfinimento quotidiano.
Una mattina, dopo che lui era uscito per il lavoro, lei aveva raccolto i suoi quattro stracci e se n’era andata, così, senza parlarne, senza provare a ricucire, senza lasciare due righe.
Da lì in poi, o era rimasta sola o s’era accoppiata solo con perdenti, gente senza speranza, da tenere a galla. E lei era un portento nel dare aiuto, e non solo agli uomini.
C’era sua madre che invecchiava e aveva sempre più bisogno che qualcuno le facesse la spesa, le pulisse la casa e la stesse a sentire.
Quando la guardava attraverso la pellicola gelatinosa che le velava le iridi, Angela non aveva scampo, si rimboccava le maniche e ci dava dentro con scopa e straccio.
Poi c’era il figlio di sua sorella, quello piccolo, che aveva qualche problema, non era ben chiaro quale, ma non imparava né a leggere né a scrivere. Era Angela che passava le serate a farlo scrivere e riscrivere, a leggergli fiabe, perché sua sorella ne aveva altri due di bambini, e questo quasi non lo voleva vedere, così tonto.
Era la fatica a dar forma alle sue giornate, un mattoncino sopra l’altro, fino a tirare sera.
Quest’uomo, quello della sera precedente, con capelli e barba rossicci, non si smarcava dal prototipo in uso. Era uno con la sconfitta alle calcagna.
Abbigliamento assemblato a casaccio, occhi reticenti, graffiati dalla delusione, fra l’impaurito e il malinconico e quegli scatti di repentina impazienza, come fosse stato scoperto, come se qualcuno avesse squarciato la cortina dei suoi pensieri. Poi subito una conchiglia chiusa, serrata nella morsa di uno sguardo duro, dell’istinto atavico di difesa del territorio.
Ma quegli occhi celesti lasciavano trasparire un bagliore particolare, qualcosa che lei aveva intravvisto solo per un istante. Poi, lui aveva distolto lo sguardo nervoso, come spegnendo una luce in fretta e furia.
Certo aveva capelli e barba rossi, e il rosso si sa, non porta niente di buono.
E la casa, che desolazione: un materasso, una sedia, un’asse su due cavalletti come tavolo, niente armadio, vestiti accatastati ovunque, puliti e sporchi insieme. Non un quadro, nemmeno un poster alle pareti, i vetri dell’unica finestra resi opachi dalla pioggia e dalla polvere di anni.
C’era di buono il cane, lurido pure lui, ma bello, educato, con l’aria sveglia di uno che capisce. Gli occhi un poco obliqui lo facevano sembrare triste, o forse era solo intelligente, più intelligente del rosso silenzioso. Cenciosi erano cenciosi tutti e due, magari a stare insieme si finisce per assomigliarsi.
Alla fine è stato gentile – raccontò a Paola, come per salvarlo dentro di sé.
Non fece parola della dolcezza, di quell’infanzia che gli si leggeva sotto pelle, di quello sguardo in cui pareva di annegare, di quelle lacrime spremute dal suo abbraccio che lui continuava a chiamare sudore, del suo accarezzarla senza fretta, senza pretese, come fosse l’unica cosa che gli importasse fare. Era un uomo che parlava con gli occhi e con i gesti, non con le labbra che non sapevano scollarsi per articolare parole. Rifuggiva le parole come la peste, come se le parole avessero preso partito contro di lui, come se gli corressero incontro imbracciando un moschetto per stanarlo, come fossero state loro, le parole, a mandargli a gambe all’aria l’esistenza. Sembrava avesse la testa ricolma dei cocci delle parole, di sillabe pensate e mai proferite.
Eppure un centro doveva averlo pure lui in quell’arcipelago di frasi smozzicate, di sentimenti sbandati, in quell’odore di selvatico, in quel dormire agitato come vela sbattuta dal vento.
Gliele avrebbe insegnate lei le parole, lei che, con quello giusto, poteva parlare per due, lei che sapeva scovare nel cesto del vocabolario quelle che colpiscono nel segno, che affondano il coltello, e poi quelle che addolciscono, che consolano, che aprono spazi.
E poi non si parla solo con le parole, ci sono messaggi, dichiarazioni, pensieri profondi che si mutano in sguardi, carezze silenziose, gesti imprevisti.
Angela non aveva dubbi, aveva ricevuto il segno, quello che non mente: quando l’aveva visto, le spalle curve, una faccia che promette solo guai, la birra che gli galleggiava nel sangue, lei aveva sentito le farfalle nello stomaco.
Solleva quella manica, tira su la maglia e fammi vedere quel tatuaggio – le chiese con voce imperiosa Paola. Che cosa mi avevi detto che significava questa roba cinese o giapponese? Saggezza, mi sembra. E dov’è questa saggezza nella tua vita se continui a cadere dallo stesso gradino, se ripercorri lo stesso tratto sempre con lo stesso passo da vittima? Perché mi viene il dubbio che tu stia bene nella parte della vittima, che ti piaccia sanguinare.
Angela non rispose, non sapeva cosa dire.
Forse Paola aveva ragione, forse lei si ostinava a soffiare su tizzoni spenti?
Ma come uscire da se stesse? Non è che quando sai che sei fatta male, ti puoi rifare da capo. Sei così e basta. E non ti difendi da te stessa, magari ti lecchi le ferite, ti dai dell’idiota da sola, ma poi ricominci le tue giornate male, come sei capace. Tiri la carretta al lavoro, pulisci la casa di tua madre, cerchi di volere bene al tuo nipote svergolo e ti innamori dell’uomo sbagliato, ammuffito dentro, e ti condanni all’infelicità.
Eppure, nel profondo, lei in quel rosso ci vedeva qualcosa, ci sentiva un humus fertile, una possibilità. Probabilmente era sempre così all’inizio di una storia, lei ci immaginava quello che non c’era affatto, ce lo metteva. Perché era dell’amore che lei era innamorata, anche se un uomo che valesse la pena di amare davvero ancora non l’aveva incontrato, perché forse gli esseri umani non possono essere all’altezza dei sogni. E lei non smetteva di sognare come un’adolescente, sognava un amore magari non perfetto, ma quasi perfetto, uno di quelli in cui non devi fare la piega, in cui c’è molto del tutto che vorresti.
Non ci sarebbe ritornata quella sera al bar del quartiere. Non c’era da dargli troppa biada al rosso. Doveva starsene da solo, con il suo cane, aspettarla, girare il capo ogni volta che s’apriva la porta, nella speranza di vederla entrare e poi deglutire amaro. Doveva berci sopra alla sua assenza, assaporare il desiderio e la mancanza.
Gli avrebbe dato due sere libere, poi sarebbe ricomparsa. Si sarebbe truccata come si deve, avrebbe indossato gli orecchini e i bracciali della fortuna, quelli che allargano i campi di forza del destino, si sarebbe seduta al tavolino in fondo, avrebbe ordinato un caffè macchiato e l’avrebbe aspettato.
Lui non avrebbe mollato, i suoi occhi sfuggenti non l’avrebbero omaggiata con uno sguardo, lo sapeva, troppo coraggio ci voleva per ingarbugliarsi l’animo. E lui il coraggio l’aveva smarrito. Magari l’avrebbe raggiunta il cane e lui, con la scusa di riprenderselo, si sarebbe avvicinato come un sughero che galleggia in acque agitate, il volto infarinato dall’imbarazzo.
Eccoci qui – beh sì – già. Le parole erano troppo grandi per lui, gli andavano larghe, forse perché aveva solo silenzio nelle vene.
Allora sarebbe toccato a lei invitarlo a sedersi, gli avrebbe offerto una birra e gli avrebbe raccontato la sua giornata, così, per rompere il ghiaccio. Che se fosse stato per lui il silenzio sarebbe durato in eterno. Poi, come per sbaglio, gli avrebbe sfiorato un polso, forse una carezza di sfuggita. Magari lui ce l’avrebbe fatta a prenderle la mano.
