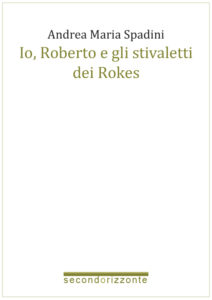
“Non ci posso credere… Roberto ha comprato gli stivaletti dei Rokes!!”
Eccolo lì, in classe a pavoneggiarsi con quegli stivaletti di camoscio chiaro, a punta e con il tacco rientrante, che fino a quel momento avevo visto solo in televisione e sulle copertine dei 45 giri, indossati dai “complessi beat”, come allora venivano chiamate le timide avanguardie musicali italiane di quella rivoluzione, generazionale, culturale e poi anche politica, che nella seconda metà degli anni ’60 già stava scuotendo iI mondo. Le nostre compagne, che già normalmente gli rivolgevano solo sguardi adoranti, gli stavano intorno completamente ammaliate, facendo di tutto per attirare le sue attenzioni, mentre noi maschi lo squadravamo tra l’incredulo e il frastornato, come pugili appena raggiunti da un improvviso montante alla punta del mento. Non che tutti sapessimo chi diavolo fossero i Rokes e da dove saltassero fuori quelle strane calzature, ma era così evidente l’effetto che facevano sulla parte femminile della classe…
Io ero tra quelli che li conosceva, i Rokes: l’immagine di quei quattro ragazzi con i lunghi capelli a caschetto, i pantaloni stretti e il cravattino sottile che, con le loro chitarre dalle forme strane, cantavano canzoni in un Italiano improbabile non me la ero più scrollata via fin dalla prima apparizione televisiva a cui avevo assistito. Non sapevo ancora bene cosa, ma mi rendevo confusamente conto che loro e gli altri “beat” stavano muovendo qualcosa di importante nella mia testolina…
Da lì a chiedere ai miei genitori di acquistarmi un paio di quegli stivaletti ce ne passava, altro che se ce ne passava… Neanche riuscivo ad immaginarmi mentre formulavo una tale richiesta a mio padre, forse perché potevo invece a prevedere benissimo la reazione che avrebbe prodotto… Non è nemmeno tanto strano, a pensarci: in fondo avevo 9 anni e frequentavo la quarta elementare di una scuola cattolica dì provincia, mica un liceo londinese di Chelsea o di Kensington… Non mi ero ancora affrancato nemmeno dai pantaloni corti, che indossavo anche in inverno, tranne che nei giorni più freddi, figuriamoci… Ma ora eccoli lì, ai piedi di Roberto… Allora era possibile… “Osare lottare, osare vincere”, come diceva lo slogan del Presidente Mao che avrei imparato qualche anno dopo in manifestazione…
Roberto non era un compagno di classe qualsiasi, era anche il mio migliore amico. Condivideva questo dubbio privilegio con Gianluigi, il mio compagno di banco.
Loro non potevano essere più diversi, come del resto la qualità dell’amicizia che mi legava a ciascuno dei due. Non l’intensità però… Quella no, era la stessa. Era un legame che sentivo forte, assoluto, come solo le amicizie di quegli anni sanno essere (e i grandi amori, naturalmente, ma questa è un’altra storia…).
Roberto sembrava il vincitore della lotteria organizzata dal buon Dio per stabilire l’ordine di distribuzione delle doti e delle virtù. Fisicamente era bello, biondo, di altezza normale e di corporatura atletica. Nei giochi durante la ricreazione e la pausa pranzo risultava quasi sempre il vincitore, che si trattasse dì bandiera, mondo, nascondino, biglie o semplicemente darsele di santa ragione. Tutto questo sarebbe già stato più che sufficiente a spiegare l’adorazione che gii rivolgevano tutte le bambine della classe… Ma lui, per non farsi mancare niente, era anche dotato di una naturale simpatia e di un certo carisma, oltre ad essere molto sveglio ed intelligente. Risultato; era il capo del branco, il primo della classe e il cocco di suor Riccarda, la nostra maestra.
La nostra amicizia era fatta di condivisione, complicità ma anche competizione, con le inevitabili tensioni che ciò comportava. Non è sempre semplice recitare la parte del secondo. E, in quella classe, a me era toccata quella: nei giochi, nel rendimento scolastico, nelle preferenze della maestra. Era sopportabile solo perché il primo era Roberto e perché, talvolta, capitava che riuscissi a stargli alla pari. Era la concreta possibilità che questi momenti lasciavano intravedere che rendeva vitale e proficua la nostra relazione, stimolo forse illusorio ma necessario all’esistenza del nostro rapporto.
Gianluigi quella lotteria non l’aveva vinta. Forse San Pietro non gli aveva nemmeno venduto il biglietto. Con l’ipocrisia dell’età adulta, oggi lo potrei definire, dal punto di vista estetico, “un tipo”: aveva occhi, capelli e carnagione scuri, con una fronte che sembrava non finire mai e dei dentoni che la sua bocca faticava a contenere. Era alto, un po’ goffo, ed era dotato di una forza fuori dal comune, di cui è stato a lungo inconsapevole. La sua bontà e il suo straordinario candore lo esponevano spesso agli scherzi altrui, a cui raramente sapeva opporsi efficacemente. Purtroppo, all’epoca non era neanche particolarmente sveglio e la sua lentezza nell’apprendimento doveva essere parecchio frustrante per suor Riccarda, almeno a giudicare dalla quantità di ceffoni che gli rifilava quasi quotidianamente e che lui incassava con stoica indifferenza. Era però un amico leale e generoso a cui ho voluto molto bene e che ho sempre cercato di proteggere. Poi, visto che forse era lento di comprendonio ma certamente non era uno stupido, ha imparato a difendersi da sé, come ancora ricorderà qualcuno di quegli spiritosoni che si divertivano a sfotterlo…
C’era però almeno una cosa che accomunava i miei due amici e li riportava su un piano dì parità; nessuno del due veniva mai invitato alle mie feste di compleanno.
Ho sempre odiato le feste dì compleanno, soprattutto le mie e, in particolare, quelle che organizzava mia madre quando ero bambino. Sono certo che lei lo facesse con le migliori intenzioni, ma proprio non ne azzeccava una, a cominciare dalla cosa più importante: gli invitati.
Non riuscivo proprio a capire perché si ostinasse a radunare per quell’occasione solo ed esclusivamente i compagni di classe più antipatici, quelli con cui non avevo assolutamente nulla da spartire se non qualche sberla durante la ricreazione… In compenso Roberto e Gianluigi brillavano sempre per la loro assenza. Quando poi gliene chiedevo conto, mia madre offriva spiegazioni vaghe e incomprensibili, tipo “non sono riuscita a mettermi in contatto con le loro mamme perché non hanno il telefono” o “li ho invitati ma le loro mamme mi hanno detto che non potevano venire”. Traccheggiava, mi menava per il naso…
Mi ci è voluto qualche anno ma poi ho capito: mia madre invitava solo i bambini di “buona famiglia”, selezionati secondo la sua personale classificazione sociale, perciò benvenuti i figli di impiegati e tappeto rosso per i figli di dottori e di avvocati. Gli altri, bè … Gliene ho chiesto conto qualche tempo fa e lei, che ora se ne vergogna, me lo ha confermato.
Gianluigi era figlio di meridionali, che si erano trasferiti qualche anno prima a Pavia alla ricerca di lavoro. Suo padre credo che fosse operaio, di sua madre non ricordo, come dei suoi numerosi fratelli. Forse il telefono non ce l’avevano davvero, ma un bigliettino in cartella…
La situazione familiare di Roberto era invece più sfuggente, misteriosa…
Lui non ne parlava mai, ma non era certo uno dei nostri argomenti di conversazione prediletti…Vuoi mettere la formazione dell’Inter campione di tutto da recitare come un rosario o le discussioni su chi fosse il ciclista più forte tra Gimondi, Motta, Anquetil e tutti gli altri la cui immagine era immortalata nelle nostre biglie di plastica colorata?
E che dire dell’appassionante confronto tra i rispettivi album di figurine con le doppie da scambiare, “Ce l’ho, ce l’ho, ce l’ho, non ce l’ho, me la dai che ti do queste due in cambio?”
Comunque, non ho mai visto i suoi genitori venirlo a prendere a scuola o a colloquio con la maestra. Al loro posto, una zia, sempre la stessa, graziosa, sulla trentina, che gli somigliava moltissimo. Era una persona semplice, non sembrava un medico e nemmeno un avvocato. Non ho mai saputo se venisse lei solo perché i turni di lavoro dei suoi genitori non fossero compatibili con l’orario della scuola o per motivi magari molto più seri… Ma allora non me lo domandavo nemmeno. Lui era Roberto, eravamo grandi amici e pensavo che tanto bastasse per averlo alle mie feste di compleanno…
Ma torniamo a quegli stramaledetti stivaletti.
Io ero allibito. E furioso. “Non si fa così… sei il primo della classe, tutte le nostre compagne sembra che vivano solo per un tuo sguardo, anche Milena che mi piace da morire… i nostri compagni ti stanno sempre intorno scodinzolanti… suor Riccarda ti fa i complimenti anche quando non te li meriti… hai già tutto, che bisogno c’era?” Certo, le scarpe erano belle da morire e avrei dato non so cosa per averne un paio uguali, ma quella piccola crepa che si è in quel momento insinuata nella nostra amicizia non è dipesa dalla mia invidia. Mi è solo sembrato troppo, come se quegli stivaletti rappresentassero la formalizzazione dì una gerarchia che mi vedeva ormai definitivamente relegato in un ruolo subalterno. Niente più competizione: amici sì, ma buono lì a scodinzolare insieme agli altri…
E quella crepa a poco a poco si è trasformata in frattura. Senza nessun litigio, silenziosamente…Troppo difficile, allora, trovare le parole per tentare di spiegare ciò che mi si agitava dentro… Un progressivo, lento allontanamento, piuttosto… Un rapporto di amicizia che è diventato prima amichevole e poi di indifferenza…
Al termine delle scuole elementari ci siamo definitivamente persi di vista. Non ho saputo più nulla di lui, nemmeno in che scuola media si fosse iscritto.
L’amicizia con Gianluigi mi ha invece accompagnato sino alla fine della quinta. Poi l’iscrizione in scuole medie diverse e lontane ci ha separato e la vita ha fatto il resto. Ero ormai al liceo quando sono venuto a sapere di quante difficoltà avesse dovuto affrontare anche in quella scuola, terminata solo a prezzo di un paio di bocciature. Naturalmente di proseguire gli studi non se ne parlava, perciò aveva trovato lavoro come operaio in una delle grandi fabbriche che all’epoca ancora esistevano a Pavia. Un giorno, dopo anni che non lo incontravo e che non avevo sue notizie, me lo sono improvvisamente visto comparire accanto durante una manifestazione. Sorreggeva sorridente un grande striscione rosso con la scritta “Avanguardia Operaia”. Eccolo qua, il bambino lento di comprendonio…