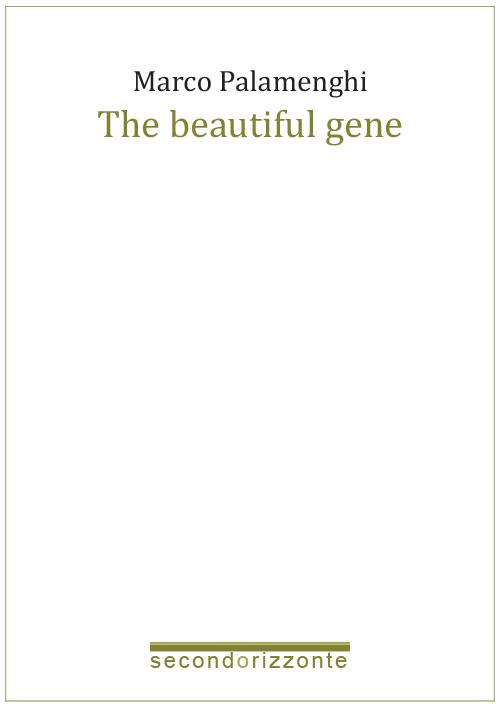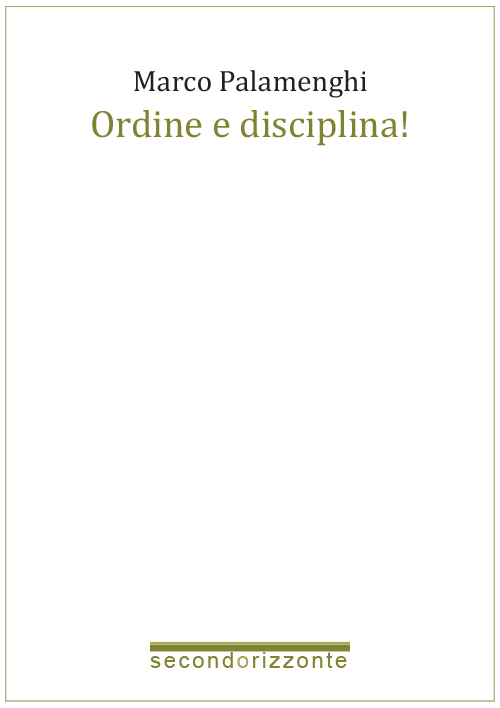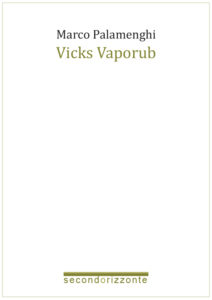Rivoluzione (dal dizionario Devoto – Oli) – Ri-vo-lu-zio-ne
sostantivo femminile (potrebbe non essere un caso)
dal latino: revolutionem, da revolutus, participio di revolvere composto da re- ancora e volvere volgere. Voltare di nuovo.
1. Movimento organizzato e violento col quale si instaura un nuovo ordine sociale o politico (rivoluzione francese, rivoluzione di ottobre, …).
2. Ogni processo storico, anche graduale, che finisca per determinare il mutamento di un assetto sociale o politico (rivoluzione agricola del neolitico, rivoluzione scientifica, rivoluzione industriale, rivoluzione digitale…).
3. Sconvolgimento di costumi (rivoluzione sessuale), di abitudini (i miei figli hanno portato la rivoluzione in casa) o funzioni fisiologiche (ho l’intestino in rivoluzione…).
4. Il giro completo descritto da un corpo in movimento intorno a un altro corpo; anche, il relativo moto (rivoluzione terrestre).
“Morire per delle idee, l’idea è affascinante
per poco io morivo senza averla mai avuta,
perché chi ce l’aveva, una folla di gente,
gridando “viva la morte” proprio addosso mi è caduta¹…
Non credo di averlo mai veramente voluto, ma l’idea di morire per delle idee, per quanto, per l’appunto, sia affascinante e mi abbia, in qualche modo, affascinato (almeno a parole), mi ha sempre, nel mio piccolo, colpito. La retorica combattentistica e militaresca è pervasiva nel dna dell’umanità, in particolare maschile. Un richiamo all’eroismo inculcatoci fin da bambini, soprattutto dal sistema scolastico allora predominante.
La mia adolescenza e gioventù, come quella di molti altri della mia generazione, è stata pervasa da eroi, più o meno mitici, più o meno coerenti, che indicavano la via del sacrificio nel nome dell’IDEA.
La vita di noi tutti è stata toccata da morti, vicine e lontane, che hanno segnato dolorosamente la nostra storia collettiva e personale.
Su, lottiamo! L’ideale nostro al fine sarà…
Ma quanti dei numerosi morti per un’idea, magari per la nostra idea, o, peggio, per l’idea di qualcun altro, avrebbero preferito non morire, e non è giusto che siano morti.
Ma quanti, numerosi, hanno scelto, e quanti, ancor più numerosi, sono stati condannati a morire per un’idea, magari per l’idea di altri.
Ma quanti, se potessero, si chiederebbero ora: “Ne è valsa veramente la pena?”
Che grande ingiustizia quando, per sostenere le proprie idee, si è condannati a essere uccisi o a uccidere.
Non sarebbe meglio se tutti potessero morire per delle idee, ma di morte lenta?
La lettura di Manuel Scorza, uno dei miei autori preferiti, mi riempiva di orgoglio per Garabombo, Raymundo Herrera, Agapito Robles ….
Ma fu La danza immobile, il suo ultimo libro prima della morte improvvisa, che mi mise di fronte, all’inizio con fastidio, solo poi con più consapevolezza, ad un dualismo irrisolto, che ognuno di noi, forse, si porta nel sacco senza mai veramente risolverlo:
Il romanzo è un contrappunto fra un guerrigliero e un ex guerrigliero. Sotto un altro punto di vista, un conflitto fra due uomini che devono scegliere fra l’Amore e la Rivoluzione. L’uno sceglie la Rivoluzione. L’altro l’Amore. Al termine della loro vita entrambi credono che l’altro abbia scelto il meglio.²
…perché forzando il passo succede che si muore
per delle idee che non han più corso il giorno dopo.
Ora se c’è una cosa amara, desolante,
è quella di capire all’ultimo momento,
che l’idea giusta era un’altra, un altro movimento…
Ho ancora in mente mio zio Evaristo (nome orribile che porto con orgoglio come secondo nome), alpinista, socialista, partigiano, imprigionato, torturato e condannato a morte. Salvatosi quasi per caso, perché il giudice del Tribunale Speciale Fascista non fece eseguire la condanna illudendosi, inutilmente, che questo gli avrebbe salvato la vita.
Lo vedo ancora con l’amarezza della disillusione negli occhi, di fronte al craxismo che avanzava e distruggeva tutto quello per cui avevano lottato e messo in gioco la propria vita.
Messo in un angolo, gettato via come anacronistico, non sapeva più distinguere se erano gli ideali ad essere stati traditi o se erano gli ideali in cui aveva creduto che lo stavano tradendo. E si domandava: “Ne è valsa la pena?”. E’ morto ottantenne senza sapersi dare una risposta.
…Gli apostoli di turno che apprezzano il martirio,
lo predicano spesso per novant’anni almeno.
Morire per delle idee sarà il caso di dirlo
è il loro scopo di vivere, non sanno farne a meno…
E li vediamo ancora oggi in giro, i nuovi profeti dell’Italia agli italiani, del non passa lo straniero, dell’Italia 2.0 o i profeti della lotta continua, convinti che un po’ di guerriglia urbana e qualche bomba carta siano la migliore soluzione ai problemi.
Tutti pronti, con linguaggio rabbioso e guerresco, a perorare il linciaggio del momento, ad eliminare il nemico che gli si oppone o, più semplicemente, chi non si adegua al loro pensiero “unico”.
Alcuni di loro pronti tra qualche tempo, consapevolmente o meno, al cambio di bandiera. Che predicano con veemenza di come quello che pensano ora è giusto, e se cambieranno opinione sarà di nuovo giusto, mentre tu che vuoi ragionare, pensare, capire, cambiare idea alla fine di un percorso, sei solo uno che rimane ancorato all’antico, un nostalgico, uno da eliminare… perché cerchi un po’ di coerenza tra quello che fai e quello che pensi e non ti lasci usare.
E ti senti inerme.
…E sotto ogni bandiera li vediamo superare
il buon matusalemme nella longevità
per conto mio si dicono in tutta intimità
moriamo per delle idee, va bè, ma di morte lenta,
ma di morte lenta.
Man mano che passa il tempo, trovo sempre più fastidio, insofferenza, per chi grida e urla, togliendo spazio al ragionamento. Anche quando la pensa come me. Anche quando condivido l’obiettivo.
Più i toni si fanno retorici e feroci, i richiami evocano battaglie e lotte, più mi raffreddo.
Film già visti. A volte percorsi obbligati, più spesso corse verso il baratro.
Sono diventato, ho quasi paura a dirlo, un moderato?
A scanso di equivoci, chiarisco subito che il mio non è un invito al disimpegno, a non portare avanti le proprie idee, a non indignarsi, a non manifestare il proprio dissenso, a non agire. Ma, caso mai, ad agire in modo diverso, rinnegando il culto del martirio, la retorica dei richiami militaristi e combattentistici. Possibile che non ci sia un modo diverso?
Le grandi idee rivoluzionarie le ho abbandonate da tempo. Credo di averle sostituite con le piccole rivoluzioni del quotidiano, se così possiamo definirle. Richiedono impegno e non fanno sconti alle incoerenze: chi ti è vicino sa chi sei veramente, non puoi nasconderlo.
Non mutano in maniera eclatante la realtà, ma modificano ciò che ci circonda e, forse, mi illudo che siano un granellino di sabbia nell’ingranaggio del potere e di resistenza alla maggioranza non più silenziosa, al becero, o peggio, al fascismo che avanza.
Un piccolo vivaio in cui curare e coltivare i semi di un futuro, forse migliore, magari non per noi, ma per i nostri figli. E non è forse proprio questo il cuore di ogni Rivoluzione?
E’ per questo che, alla fine, penso di aver capito che l’unica vera rivoluzione in cui credo ancora, è quella che, nel suo continuo movimento, sembra non cambiare nulla, che ogni volta ti riporta al punto di partenza, ma diverso da prima, magari impercettibilmente, ma diverso.
Puoi cambiare camicia se ne hai voglia
E se hai fiducia puoi cambiare scarpe
Se hai scarpe nuove puoi cambiare strada
E cambiando strada puoi cambiare idee
E con le idee puoi cambiare il mondo
Ma il mondo non cambia spesso
Allora la tua vera Rivoluzione sarà cambiare tè stesso³
Vivere la vita, come una danza.
Corpi che ruotano su sé stessi e tra loro.
Un continuo attrarsi e allontanarsi.
Un continuo cambiare posto, per tornare nello stesso o in un altro punto, ma con un nuovo sorriso sulle labbra, con il sudore che cola, con una intimità che è vita.
Che sia un movimento irrevocabile o un ciclico ripristino di condizioni precedenti, le rivoluzioni, volute coraggiosamente o ineluttabilmente subite – così come quelle dei moti dei corpi celesti – segnano un nuovo punto di partenza, che ora è un nuovo anno, che ora è un nuovo spirito del tempo, avendo ripreparato il terreno per una nuova evoluzione – al modo dell’aratro che rivolge le zolle e permette la nuova semina4.
La Rivoluzione è come vivi il tempo che trascorre.
Che cambia e trasforma te.
Che cambia e trasforma chi hai intorno.
Che cambia e trasforma il mondo.
Evviva la rivoluzione
Evviva le rivoluzioni terrestri!
—
[1] Morire per delle idee, di George Brassens, tradotto da Fabrizio de Andrè.
[2] Manuel Scorza, La danza immobile, Feltrinelli 1983
[3] Vivere la vita di Alessandro Mannarino
[4] https://unaparolaalgiorno.it