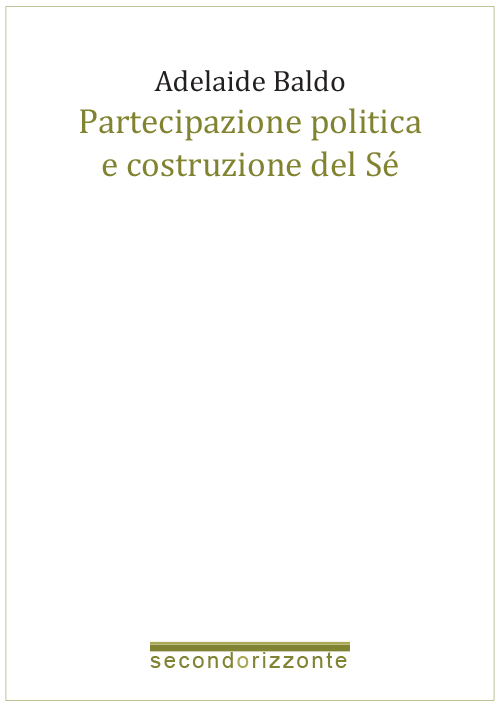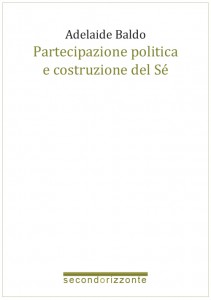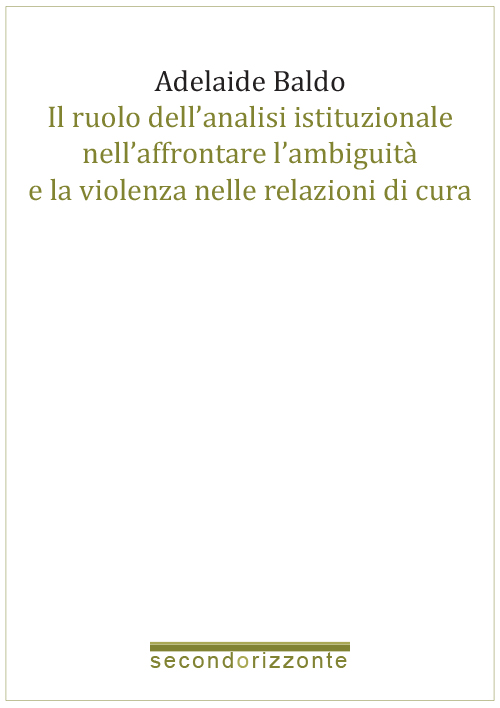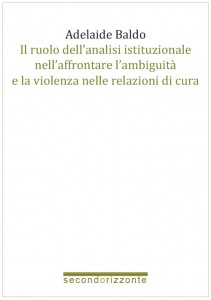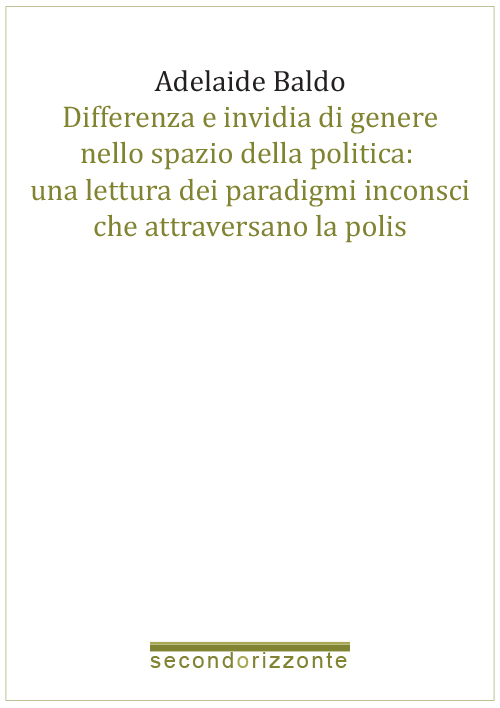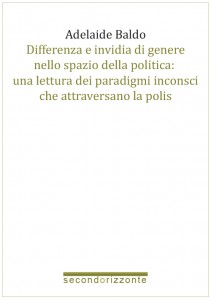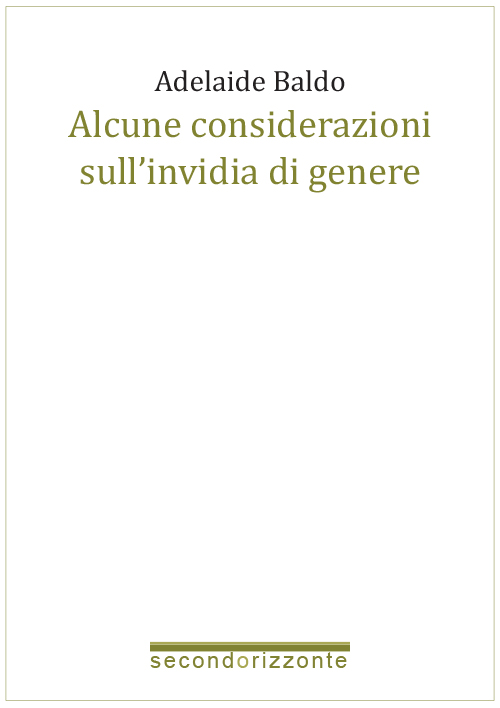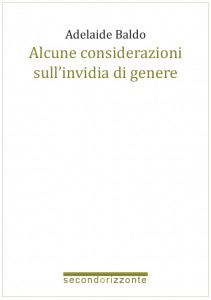Ci sono luoghi che ti chiedono di fare scelte.
1
La strada che da Addis Abeba porta verso sud, di fatto l’unica grande arteria di collegamento del paese, esce dalla città attraversando una periferia in espansione.
Ai lati palazzine in costruzione già rivelano la loro futura bruttezza.
Sulle impalcature, semplici lunghi pali inchiodati tra loro e senza alcuna protezione, lavorano gli operai, spesso bambini sugli otto, nove anni.
E’ in costruzione anche la strada di questo quartiere, ma per il momento è uno sterrato fangoso tutto una buca.
Sul tubo dell’acquedotto si aprono qua e là rubinetti a cui la gente, in lunghe file, attinge acqua con taniche da benzina.
Taniche di tutti i colori e misure.
Taniche grandi e taniche piccole.
Taniche da adulto e taniche da bambino.
Perché tutti ne hanno una, se vuoi bere, se vuoi portare a casa l’acqua.
Tutti, anche i bambini più piccoli che devono subito imparare le leggi della sopravvivenza.
E la prima legge è che, dovunque ci sia acqua, tu devi essere attrezzato per prenderne la tua parte.
Ci si lava anche a questi rubinetti, ma, quando la fila è troppo lunga, può andare bene anche una pozzanghera per una rapida toeletta.
Un mendicante espone le piaghe.
Capre.
Via vai di gente che trasporta sulle spalle sacchi, legna, fagotti.
Nibbi bruni volteggiano sopra di noi.
Benvenuti in Africa.
Un’Africa in bilico tra voglia di progresso e contraddizioni sociali, tra mondo rurale e urbanizzazione senza controllo.
Ora la strada è asfaltata e trafficatissima.
Camion stracarichi entrano o escono dalla città sparando nubi nere dai tubi di scarico, mentre si fanno strada fra la gente a piedi e i carretti.
Parallelo alla strada vi è una sorta d’avvallamento dove pascolano mucche e capre.
Due bambini a guardia del bestiame salutano festosi il passaggio del nostro pulmino, sporgendo le faccine sorridenti ad altezza dei tubi di scappamento.
Allontanandosi dalla città il paesaggio diventa rapidamente una piana sconfinata su cui la strada disegna un lungo nastro rettilineo che scende fino al profondo sud, fino al confine col Kenya e poi ancora oltre, fino a Mombasa.
La nostra meta è, però, molto prima: siamo diretti a Gighessa, distretto di Shashamane, dove ormai da diversi anni è attivo un progetto chirurgico ortopedico che si avvale del supporto logistico della missione locale.
Due volte l’anno un gruppo di volontari, che a rotazione garantisce la presenza di medici ortopedici, anestesisti e infermieri, scende a Gighessa portando con sé tutto il materiale necessario per allestire una sala operatoria e farmaci per la degenza successiva.
Per due settimane la sala operatoria sarà attiva per garantire tra i cinquanta e i sessanta interventi.
Dopo di che, il gruppo si dà il turno con altri volontari che si occuperanno della fase riabilitativa.
E’ un piccolo progetto, nato e gestito in modo snello e in totale autonomia, che si propone di portare chirurgia ortopedica in una realtà sguarnita di strutture sanitarie.
In Etiopia, infatti, la situazione sanitaria ed ospedaliera è drammatica: gli ospedali sono pochi e i più qualificati sono solo nella capitale; il costo è a totale carico dell’ammalato e questo rende impossibili le cure per la maggior parte delle persone che vivono in condizioni economiche d’assoluta povertà.
L’ammalato deve non solo pagare degenza e farmaci ma, spesso, provvedere anche al vitto e addirittura alla biancheria del letto.
Le cure chirurgiche, inoltre, anche per la cronica mancanza di chirurghi, sono di fatto improponibili.
Sono bambini e adolescenti i destinatari di questo progetto, con patologie ormai inesistenti nel mondo occidentale: patologie legate alla povertà, alla mancanza di prevenzione adeguata, alla mancanza di una cultura della salute e a condizioni ambientali che richiederebbero radicali trasformazioni.
Bambini che a causa della loro patologia resterebbero per lo più un peso per la famiglia, senza la possibilità di autonomia di movimento.
Ormai si è sparsa la voce che due volte l’anno i bambini potranno essere operati e curati gratuitamente a Gighessa e qui arrivano anche da lontano, magari dopo giorni di viaggio, le mamme giovanissime o le nonne, più raramente i papà, con i loro figli a volte neonati, a volte già grandicelli.
Veniamo informati che a Gighessa già c’è una piccola folla in attesa, ma prima bisogna fermarsi in altre due missioni a visitare anche qui possibili pazienti.
L’arrivo dei medici dall’Italia crea un’attesa ed un’aspettativa che in molti casi saranno deluse.
Non è facile far capire che i “medici italiani” non sono onnipotenti e hanno competenza solo per alcune patologie, non altre, e che spesso ci sono limiti oggettivi ad impedire il “miracolo”.
Una prima valutazione dei casi è fatta dal personale delle missioni, ma capita che molti giungano alla visita con una speranza che non potrà avere seguito.
Continua la lettura nel pdf: