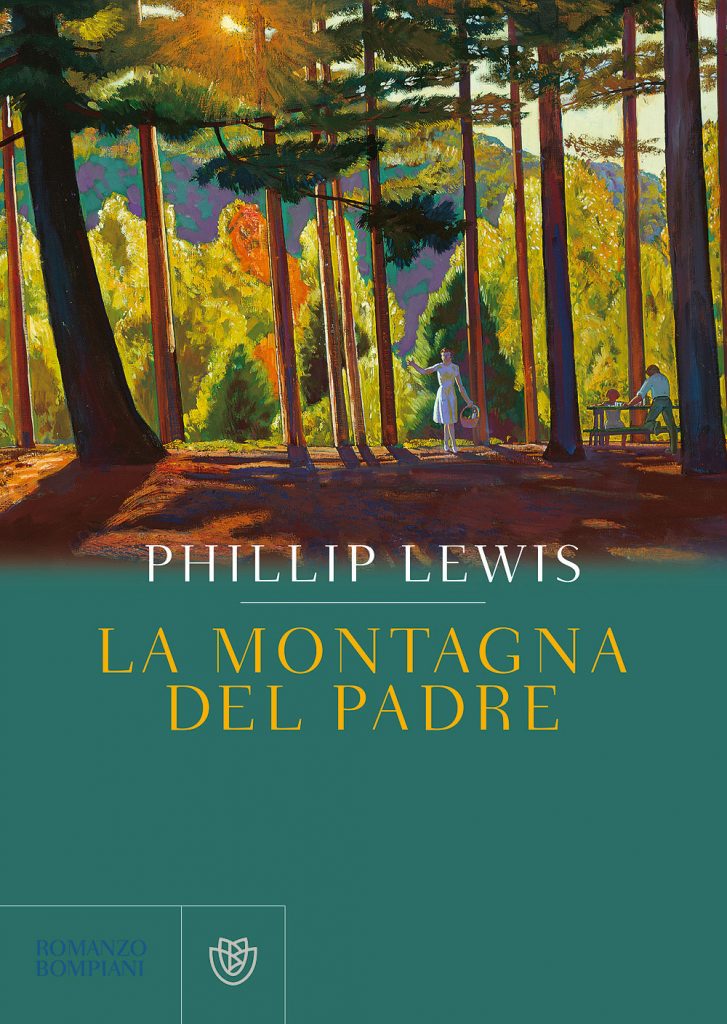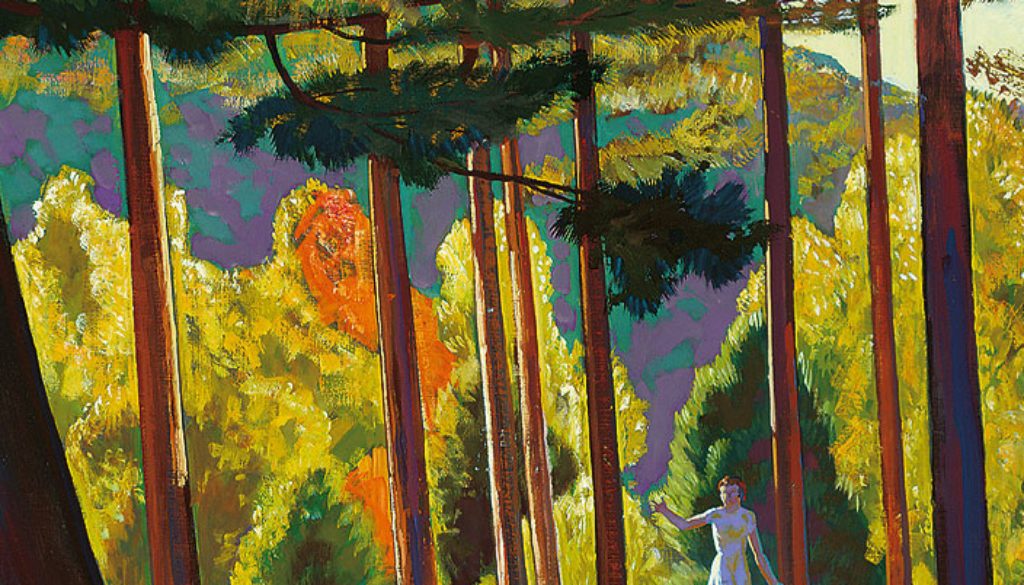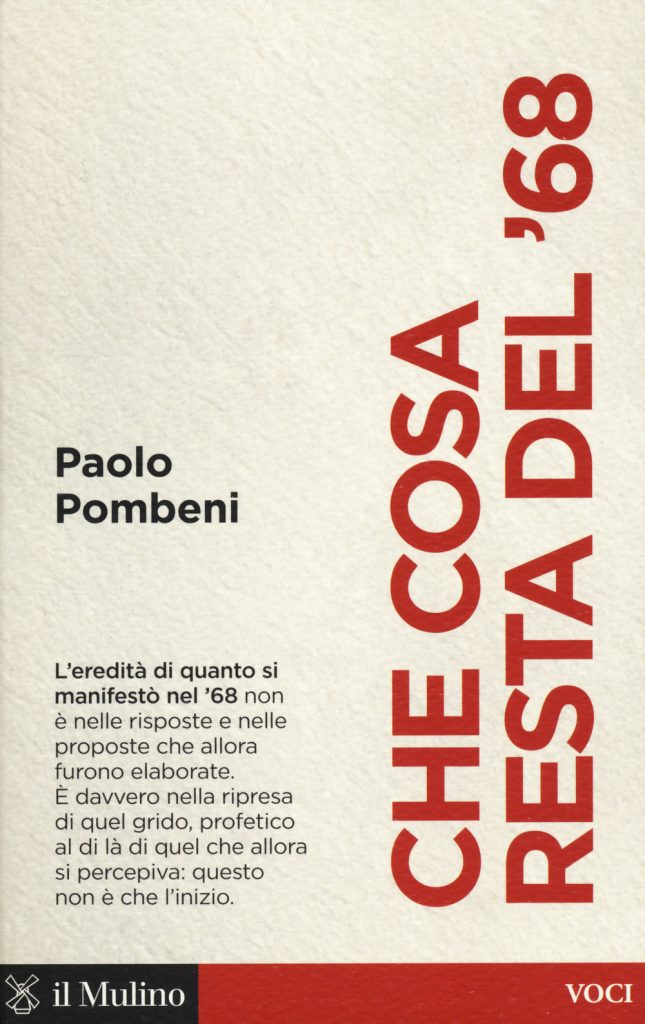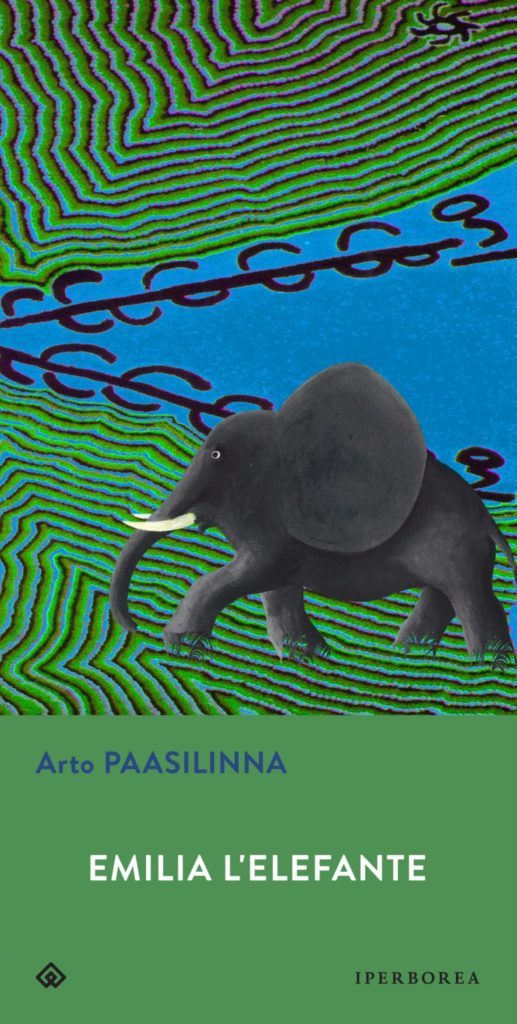Daniel Mendelshon, Un’Odissea. Un padre, un figlio e un’epopea, Einaudi 2018 (pp. 312, euro 20)
“La nostra Odissea l’avevamo vissuta – per la durata di un semestre avevamo navigato insieme, per così dire attraverso quel testo, un testo che a me, seduto lì a osservare la figura di mio padre, sembrava sempre più relativo al presente che al passato”.
L’incontro tra un figlio e un padre, un incontro a lungo rimandato, che poi si realizza in circostanze imprevedibili per entrambi. Un corso universitario e poi una crociera.
Quanti romanzi sono usciti su questo tema in questi ultimi tempi, tempi di “evaporazione” del padre? (Giusto la scorsa settimana si parlava in questi Appunti di quello di Lewis). Qui però non sono state solo le inevitabili complicazione che attraversano ogni famiglia a dividere il genitore dal figlio, ma anche il fatto di essersi entrambi arroccati in punti di vista sul mondo molto diversi, ricercatore scientifico uno, scrittore e professore di letteratura l’altro. Ma è proprio un’opera letteraria il luogo dell’incontro. Jay Mendelshon, ormai ottantunenne, decide di frequentare il seminario che Daniel terrà sull’Odissea. Se l’autore avesse voluto far filtrare per allusioni e metafore l’analogia fra la loro vicenda e quella di Telemaco con Odisseo, e di quest’ultimo con il vecchio padre Laerte, il risultato non sarebbe probabilmente stato così convincente, e coinvolgente. Mendelshon sottolinea invece, esplicitamente, il parallelismo tra la vita sua e della sua famiglia e quella raccontata nel poema omerico, ci torna sopra ad ogni passo della narrazione, stimolato dalle osservazioni degli studenti e da quelle, spesso beffarde, del padre (poco propenso a vedere in Odisseo il grande eroe che si dice), in un andirivieni che mima la circolarità che governa l’esistenza umana ma anche il racconto. Entrambi dominati da un “andamento ad anello” che si realizza nei ritorni che le età della vita comportano e la memoria ordinariamente impone così come nei flashback e nei flashforward, nelle riprese di fatti passati e nell’anticipazione di altri non ancora avvenuti che l’arte del racconto contempla: “giunta esattamente a metà, l’Odissea compie un maestoso giro di trecentosessanta gradi su se stessa e, dopo tutto quel viaggiare, torna al suo punto di partenza”; da poco superati i cinquant’anni, l’autore recupera l’infanzia propria e insieme la giovinezza del padre.

Ma non solo: è l’intero romanzo – uno di quei romanzi che sono anche saggio –a seguire lo stesso modo di procedere offrendo un esempio concreto di “quella straordinaria tecnica narrativa capace di intrecciare presente e passato dilatando un episodio specifico nella vita di un personaggio fino ad abbracciare la sua intera esistenza”. Tecnica narrativa, ma anche arte del vivere: quel che l’Odissea ci dice è che “per poter avanzare nel futuro, bisogna prima riconciliarsi col passato”, ed è utile allora ricorrere alle storie, al racconto, perché “abbiamo tutti bisogno della narrazione per dare un senso al mondo.”
Questo testo compare anche nel sito della nuova libreria Rinascita di Brescia, alle cui attività culturali Carlo Simoni collabora