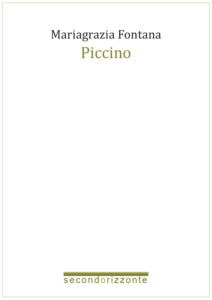
Se ne stavano seduti sotto un cedro assonnato, nella speranza che quell’ombra ampia attenuasse la calura, ma la loro pelle brillava di sudore misto a quella polverina bianca, sabbiosa e sottile che si solleva dalle strade sterrate anche se solo la si calpesta.
Hassan non mi piace questo posto che chiami città, fa troppo caldo, un caldo che si suda, non come da noi su in montagna.
Devi avere pazienza piccino – rispose il fratello – ancora poco, poi tutto andrà a posto.
Non gli piaceva quando lo chiamava piccino. Era vero Hassan era il maggiore, quasi un padre, ma lui Jaued aveva appena compiuto tredici anni ed era ingiusto continuare a chiamarlo piccino. A volte credeva che suo fratello diminuendolo lo tenesse lontano, gli attribuisse un posto basso nella gerarchia della famiglia, per restare lui sopra, a fare il capetto. A giorni invece era portato a credere che fosse l’affetto a muovergli la lingua, un affetto muto e ruvido, ma vigoroso.
Erano gli sguardi di Hassan che parlavano per lui, sguardi che lo tenevano d’occhio, che lo accudivano a modo loro, attento a che non si mescolasse con brutta gente. Era lui che gli aveva insegnato a lanciare sassi per difendersi dalle bande dei ragazzini tagiki che non vedevano l’ora di insultare e di deridere. Lo affiancavano quando usciva da scuola, sempre in gruppo. Bel coraggio, sei contro uno. Ma a lui veniva richiesto di dimostrarlo il coraggio, e lui, anche grattando nelle tasche, ne trovava pochino. Era la paura che abbondava, che fluiva a fiotti, come il sangue che colava dal naso al primo impatto con il bastone brandito dai cuccioli della tribù ostile.
Perché era fatto così il suo paese: poveri, straccioni e tutti divisi a farsi la guerra. Che forse la maggior parte di loro s’era pure scordata la ragione dell’odio, era un litigare che aveva messo radici nelle ossa, uccidersi per puntiglio, più che per quel pezzo di deserto che non dava frutti. Perché quando comincia un conflitto, poi è dura fermarlo, va avanti di generazione in generazione, di offesa in offesa, si incancrenisce e avvelena la vita di chi perde e di chi vince.
Era Hassan che gli aveva insegnato ad incassare, a proteggere la pancia, che se colpivano quella si poteva morire, così come la testa. Meglio che si ostinassero sul naso, che non era mai stato gran che diritto. Ma fuggire no, ne andava dell’onore della famiglia, della tribù, dell’Afghanistan tutto. Perché loro erano pashtun e bisognava andarne orgogliosi.
Jaued era un ragazzino sottile, i capelli neri incollati alla fronte, occhi vivaci puntati come spilli mentre osservava il mondo sempre a bocca aperta. Curioso ma fragile, da sembrare a momenti un pulcino sperduto. Era Hassan che aveva il potere di farlo sentire tranquillo.
Jaued scavava con le scarpe nella sabbia e, giusto per farlo arrabbiare, la ammonticchiava sui piedi del fratello che continuava a vederlo piccolo. E lui allora faceva il piccino dispettoso.
Hassan lo guardò storto, arricciando un poco il suo naso adunco che sembrava gocciolargli in bocca e, sotto il cielo lattiginoso, la sua faccia si fece seria lasciando affiorare la preoccupazione, o forse proprio la paura.
Hassan anche tu a volte hai paura? gli chiese a bruciapelo, parlando a precipizio, un po’ per mortificarlo, un po’ per sentirsi meno solo nel fiume della sua paura.
Hassan guardava la terra, e stringendosi nelle spalle rispose Sì, quando cala il coprifuoco e tu e gli altri fratelli continuate a giocare in cortile, ho paura perché tocca a me proteggervi, tenervi in vita finché tornerà nostro padre. Sono io l’uomo in sua assenza.
Mamma mia quante arie che si dava, pensò Jaued, solo perché aveva qualche anno di più faceva il gradasso. Ma lo sguardo del fratello non aveva nulla del pavone, aveva più del coniglio braccato, al massimo della lepre. Sì la lepre andava bene per lui che amava correre come un pazzo, che sgattaiolava il mattino presto fuori casa per allenarsi e migliorare i tempi, come diceva lui sognando le olimpiadi. Che poi tornava fradicio con le braghe lunghe sdrucite, perché da tempo neanche i maschi potevano indossare i pantaloni corti. Femmine a capo e viso coperto e chiuse in casa, e maschi barbuti con maniche e pantaloni lunghi.
E neanche se li cambiava dopo l’allenamento, perché non è che le braghe in casa abbondassero. Al massimo le stendeva sul ramo del frassino in cortile, giusto il tempo di sciacquarsi al pozzo. Gli restava sempre addosso un odore di sudore acido, che emanava dalle ascelle e che loro dovevano annusare la notte intera, nell’unica stanza in cui dormivano tutti: sei figli, quattro maschi e due femmine e, dietro una tenda i genitori. Ora solo la madre. Del padre non si sapeva più nulla.
In casa anche il pavimento di terra battuta era sovrastato da quello strato di polvere sabbiosa del deserto che si spingeva anche ad alta quota. Proteggevano i materassi con stuoie di paglia, ma d’inverno la terra mandava su un freddo gelido da spaccare le ossa e le pareti di fango impastato con gli arbusti non fiaccavano il vento secco, che infuriava pungente come schegge di cristallo.
E nostro padre quando torna? chiese titubante, mentre sferrava un calcio ad una pietra e girava il capo a osservarla rotolare, per non guardare Hassan negli occhi.
Aveva scelto la parola padre, non tanto per rispetto, ma perché sapeva che se avesse pronunciato l’altra, quella che serbava il tepore di casa, la parola papà gli si sarebbe attaccata agli occhi fino a spremerne lacrime. E lui voleva esser un uomo, non più un piccino. Ma uomo o bambino che fosse, suo padre gli mancava come l’aria, come un riparo, una nicchia asciutta e sicura. Ne sentiva l’assenza sulla pelle, un dolore sordo gli pesava sulle palpebre e una solitudine nuova gli si alzava intorno come un muro liquido, rendendo i giorni monchi, inospitali.
Aveva nostalgia della sua sagoma lunga, secca e curva che caricava sull’asino la gerla vuota per la legna. Gli mancavano i suoi occhi immobili colore dell’acciaio, la pelle un po’ floscia sulle guance, il suo mezzo sorriso incastrato nella mascella robusta, tesa sotto il naso sottile, le sue mani ruvide, nodose e forti, il rumore della legna che si concedeva ai suoi colpi.
Hassan sembrò sconfitto da quella domanda, la bocca si tese in una linea secca e un leggero rossore si sparse pigro sulla sua faccia. Il suo sguardo divenne più opaco, ma le parole, quelle tanto sperate, quelle non arrivarono.
I pensieri di Jaued si fecero vorticosi, e lo prese il timore di non rivedere più suo padre, il dubbio che fosse morto, che l’avessero ammazzato, magari quei barbuti che arrivavano sgommando nel cortile su cui si affacciavano le case delle loro cinque famiglie.
Era su quell’unico braciere in cortile che cucinavano tutti quanti a turno: riso e patate, pane e raramente spiedini di trippa e intestino di capra di montagna. Era sempre ai margini di quel cortile che si ergeva la latrina comune, un buco fetido contornato da frasche. Era su quello sterrato che correvano a perdifiato, che giocavano sotto la quercia secolare, che si facevano dispetti, si raccontavano storie, celavano segreti da poco alle mamme.
Erano arrivati su una jeep, otto miliziani integralisti sul cassone, con le canne delle mitragliatrici che gli spuntavano da dietro la schiena. Uno aveva picchiato il pugno sul tettuccio dell’abitacolo e la jeep si era arrestata con una frenata violenta che aveva sollevato altra sabbia, altra polvere che era finita nel paiolo, sui muri delle case crivellati dai colpi di fucile, sui loro volti atterriti. Due erano uomini fatti, ma gli altri erano ragazzini, avranno avuto la sua età, ma avevano occhi spiritati. Subito aveva pensato che avessero assunto della droga, era comune prima di ogni incursione per alimentare il coraggio, o forse per trasformarlo in crudeltà. L’uomo con la cicatrice in fronte, quello più smilzo, aveva raggiunto suo padre e suo zio e li aveva caricati sulla jeep già in moto, spingendoli e minacciandoli con la voce aspra.
La pelle di Jaued vibrava di paura e i brividi gli scuotevano le gambe, mentre una tenaglia gli stringeva il cuore.
Li libereranno presto, aveva detto sua madre, fanno sempre così quelli per tenerci nella paura, ma poi li rimandano a casa. Che cosa vuoi che se ne facciano di due come loro che neanche sanno sparare?
Lui non era riuscito a crederle, troppo forte era il timore che quelle fossero solo parole per consolare. E la notte l’aveva a sentiva piangere dietro la tenda lacrime d’ansia e di dolore.
Aveva provato a scrollarseli di dosso gli uomini con la barba, ma loro tornavano in sogno per prendere anche i bambini e imprigionarli in quella casa mezzo abbattuta dalle granate al margine del paese. E già si immaginava la madre sola, arrampicarsi stanca sulla collina delle vedove.
Erano loro i barbuti che avevano vietato di ascoltare la musica, in strada e anche in casa, e non c’era più nulla a consolare, a riempire le assenze, a scaldare speranze.
Hassan ho fame, disse con tono lagnoso, la faccia lunga di tristezza.
Suo fratello estrasse un sacchetto sgualcito e gli offrì una patata. Mangiala piano che deve durare. Poi quelle che restano te le darò per il viaggio.
Il viaggio? Quale viaggio Hassan? Dove andiamo? chiese il piccolo, mentre gli frugava il viso con gli occhi e il cuore cominciava a battergli sempre più forte.
Hassan gli appoggiò un braccio sulla spalla e restarono così per pochi minuti senza fine.
No, io non vado da nessuna parte, rispose, io devo pensare agli altri. Sei tu che parti piccino. Abbiamo raccolto i soldi poco per volta, ma sono bastati solo per te fino ad ora. Poi arriveremo noi e tu ci avrai già preparato la strada.
Hassan incassò le spalle codarde, il viso gli si fece grigio dello stesso colore della polvere della strada, solcato da precoci fenditure, mentre si ripeteva che quel viaggio poteva salvare il fratellino, poteva rivoluzionarne l’esistenza, aprire una flebile speranza almeno per lui. Proferire di getto quelle parole gli dava la sensazione di essersi cavato una spina profonda dalla pianta del piede.
Un’improvvisa folata di vento spazzò veloce la strada sollevando la solita polvere mista a sabbia.
Jaued cambiò faccia e gli colò addosso un’espressione di desolazione e di sbigottimento. Sentì qualcosa che gli si strozzava nel petto, una costrizione invincibile che gli succhiava via il sangue dal viso, mentre la bocca si spalancava per fare posto a un urlo che non riusciva ad emettere.
Ma come? Ma dove? Ma quando e con chi? chiese d’un fiato con voce stridula, quasi implorante, mentre in cielo le nuvole avevano preso a correre veloci.
Fra un’ora degli uomini verranno a prenderti. Jaud devi essere bravo, devi essere forte, ormai come dici tu non sei più un piccino. Vedrai non è difficile: da Kabul in tre giorni di cammino, passando tra i monti arriverete in Iran, poi in macchina proseguirete verso la Turchia fino a Smirne, dove vi aspetta un gommone, poi la Grecia e poi l’Italia. Jaued ricorda: tu sei la nostra speranza, sei la nostra rivoluzione. E pensa, tu per primo vedrai il mare.
Lui Jaued era la rivoluzione. Provò a ripeterlo dentro di sé, per riuscire ad esserne orgoglioso. Strinse gli occhi a fessura per immaginare il mare, ma la paura era come un grumo che cancellava i pensieri.
Ma io non lo so bene che cos’è il mare, io sono uno di montagna. Cioè lo so che il mare è solo acqua, ma così tanta acqua mi fa paura. E se quel mostro liquido mi inghiotte e io non so nuotare? E se si alza verso il cielo e mi porta sotto? Come faccio Hassan a respirare? rispose il piccino col fiato già corto per tutto il peso del grande mare che gli gravava sul petto. E poi non voglio andare, voglio tornare a casa con te, voglio giocare sotto la quercia, voglio svegliarmi e vedere le montagne, voglio la sabbia del deserto fra i denti, voglio la mamma, voglio il papà.
E come sempre la parola papà aprì le dighe del pianto.