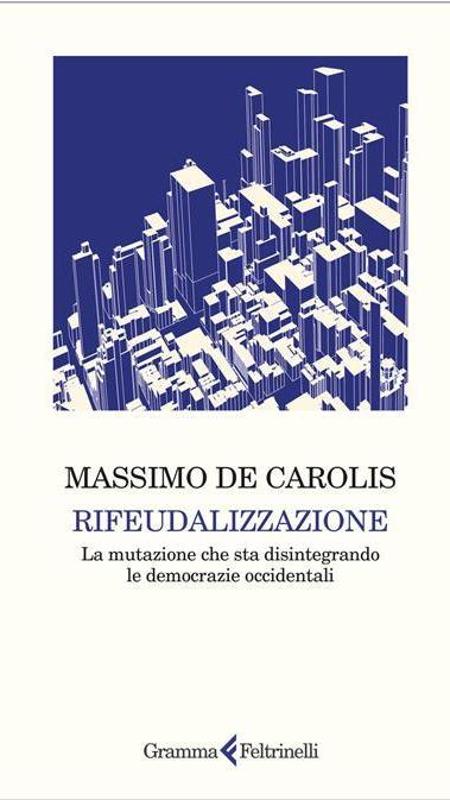
Massimo De Carolis, Rifeudalizzazione. La mutazione che sta disintegrando le democrazie occidentali, Feltrinelli 2025
Innanzitutto il quadro. In ambito economico-sociale: “un numero di compagnie finanziarie che si conta sulle dita di una mano controlla quasi tutte le aziende quotate sui principali listini. La totalità degli scambi che hanno luogo quotidianamente sulla rete è veicolata da un numero altrettanto esiguo di piattaforme digitali.
E il denaro non sgocciola affatto verso il basso ma, al contrario, si concentra al vertice, ampliando sempre di più la distanza tra una cerchia ristrettissima di miliardari e la stragrande maggioranza della popolazione, il cui accesso alla ricchezza si va riducendo da decenni”.
“In ambito politico, lo scollamento non è meno eclatante. Parliamo ancora degli stati nazionali come degli unici depositari del diritto all’uso della forza. Eppure da decenni i teatri di guerra vedono in prima linea formazioni irregolari, milizie armate e gruppi combattenti che agiscono non solo contro, ma anche alla testa degli eserciti regolari, con il pieno consenso delle autorità statali. Del resto, molto spesso queste autorità non rappresentano che segmenti parziali della popolazione”.
La figura che da questo quadro emerge ha, per il momento, contorni non ben definiti, è quella di “una mutazione sotterranea”: “è come se le istituzioni moderne si stessero riducendo a un guscio sempre più sottile, al cui interno cresce un coacervo di forze di cui avvertiamo la distruttività, senza però riuscire né a disinnescarle né, banalmente, a spiegarle con i concetti che ci sono familiari”.
Come precisare quei contorni, allora? “Occorre un’immagine nuova o, come minimo, una nuova lente concettuale” che si può individuare nell’“ipotesi di una rifeudalizzazione della società”. Ma attenzione, non si tratta semplicemente di evocare questo processo per “avanzare un dubbio critico sulla modernità, sfidandola a combattere le degenerazioni interne per tornare sulla via di un pieno affrancamento dai retaggi feudali”. È necessario, e possibile, andare oltre la critica, o meglio: mettere a fuoco fenomeni in corso che sostanzino la critica: “Nelle frange più radicali dell’anarco-liberalismo, nei gruppi di estrema destra più fantasiosi e in alcuni settori tecnocratici della galassia digitale si sta diffondendo la tendenza a rivendicare in positivo valori e miti dal sapore neofeudale, con l’intenzione esplicita di rompere i ponti con l’ideale moderno di uguaglianza e con le pratiche consolidate della democrazia”. “La rinascita di forme neofeudali è rivendicata in positivo, come un mezzo per sottrarsi alla sovranità dello stato e ai vincoli della democrazia” e imporre “un modello di ordine sociale di segno opposto, basato su una feroce selezione e sulla rigida spaccatura tra vincenti e perdenti, privilegiati ed esclusi, signori e servi”. Ma, ancora una volta, attenzione: non ci troviamo di fronte a estremismi puramente ideologici: “le mitologie del presente sono parte integrante di una macchina politica potente, che sta dilagando in tutto il mondo occidentale” e che tendenzialmente rende “l’ordine istituzionale nel suo insieme (…) uno strumento nelle mani degli interessi privati più forti e organizzati (…). A creare un simile accavallamento tra privato e pubblico concorrono, in particolare, due tendenze parallele, due tratti riscontrabili (…) tanto in economia quanto in politica.
Il primo tratto è il proliferare di relazioni asimmetriche di affiliazione e vassallaggio, basate su un particolare scambio fra autorità e fedeltà. (…) secondo tratto basilare della rifeudalizzazione [è] la crescente simbiosi tra la circolazione del denaro e quella del potere”, del mercato e della politica, il cui esito è lì da vedere: “La distanza tra il vertice e la base della società non fa che dilatarsi”, ma diversamente dal passato “a mediare tra i due poli non è più un apparato burocratico, una gerarchia di partito o un qualunque altro insieme di ‘corpi intermedi’. Un tratto basilare della rifeudalizzazione è anzi la spinta alla disintermediazione, estremizzata fino alla furia iconoclasta contro partiti, banche, burocrazia e mediatori di ogni genere e classe. Al loro posto entra in scena una specie di patto diretto tra il vertice e la base, che vincola l’autorità dell’uno e la fedeltà degli altri a una medesima promessa: l’accumulazione di più denaro e più potere”. Una logica totalizzante e pervasiva: “Oggi non c’è angolo del pianeta che non sia attraversato dalle dinamiche globali del denaro e del potere. E i loro effetti condizionano ormai gli aspetti più intimi della vita umana e alterano in profondità persino i processi generali di riproduzione della vita nella biosfera terrestre”. Ma a rendere drammatica la situazione è il fatto che “il sistema si scopre incapace di tenere a freno le sue spinte distruttive e rischia di precipitarci tutti in una condizione di insicurezza cronica, senza lasciarci alcuna via di fuga”. Altrimenti detto: “per difendere a oltranza i privilegi occidentali non c’è oggi altra via che voltare del tutto le spalle agli ideali di civiltà moderni, spacciando per necessità ontologiche la disuguaglianza e il dominio”.
Senonché, “Una volta che tutto è incluso nel sistema, il sistema non può non curarsi del tutto come tale. E questo è invece esattamente ciò che i centri di dominio generati dalla rifeudalizzazione non possono fare”. Il loro è dunque necessariamente “un dominio senza egemonia, in cui i problemi strutturali non vengono affrontati ma solo cronicizzati, accrescendone i costi pur di guadagnare tempo”. “Incapace di governare le nuove spinte, il meccanismo istituzionale le porta a confluire negli unici due canali di emergenza contemplati dal congegno: il confronto militare e l’arricchimento privato. (…) la difesa dell’ordine costituito ne sta esasperando la distruttività”, in termini ambientali e sociali.
Non casualmente l’autore evoca il contributo di Nancy Fraser che nel suo Capitalismo cannibale (in queste note il 3 novembre 2023) “sostiene che il capitalismo dei nostri anni stia manifestando un’attitudine al cannibalismo in tre sensi distinti e correlati. In primo luogo, una ristretta classe dominante “divora le risorse di tutti gli altri”; in secondo luogo, l’economia capitalista “cannibalizza” le dimensioni non economiche su cui poggia il suo sviluppo (l’ambiente, i legami sociali, le istituzioni pubbliche come la sanità o l’istruzione, le risorse estorte alle popolazioni indigene del mondo intero); in terzo luogo, distruggendo le sue stesse condizioni di possibilità, il capitalismo sta divorando in pratica se stesso come un uroboro, il serpente dei miti arcaici che ingoia la propria coda”.
Niente da fare, dunque? No: “un quadro simile non è affatto l’esito necessario e definitivo della storia”
Come spesso accade ad analisi come questa, documentate e radicali, si profila, in conclusione e con una lucidità assai inferiore a quella che ha guidato fino a quel punto il discorso, uno spiraglio: “Prima o poi è presumibile che la macchina si inceppi. Riemergeranno così i problemi mai risolti, legati tanto all’accumulazione illimitata del capitale quanto al monopolio della violenza nelle mani delle singole entità statali. A quel punto, la pura e semplice difesa dei privilegi dovrà cedere un qualche spazio alla cura del mondo nel suo insieme. Con tutta probabilità, non sarà una conversione a costo zero. Prima però sapremo riconoscerne la necessità, e minore sarà il prezzo”.
Ammesso che un’evoluzione di questo genere sia ipotizzabile, la crisi ambientale e la pratica della guerra le lasceranno il tempo di realizzarsi? Una domanda, questa, che – c’è da presumere – l’autore ritenga opportuno, o inevitabile, sottintendere…
Dopo questa sintesi, il libro ne articola i punti essenziali, non di rado attraverso digressioni storico-politiche necessarie quanto impegnative e dense di riferimenti al punto da non essere sempre alla portata del lettore medio.
Innanzitutto, un approfondimento circa i “diversi fenomeni catalogati in questi anni come forme di rifeudalizzazione”, di cui l’allargarsi della “forbice fra ricchi e poveri” è l’evidenza più lampante, ma che – occorre considerare – procede insieme a una “centralizzazione del capitale che non ha precedenti nella storia del capitalismo” (basti ricordare il caso dell’hi-tech, “dominato a livello globale da cinque grandi piattaforme americane e tre cinesi”) e ha come correlato il fatto che “i ricchi sono portati a separarsi dal resto della società (…) a incastellarsi in rifugi off-shore reali o virtuali, paragonabili ad altrettante fortezze medievali”.
“Ulteriore effetto collaterale della crescente polarizzazione è che, in tutti i paesi avanzati, si tende a privatizzare in modo crescente i beni pubblici (…) col risultato che i diritti, di regola previsti dalle carte costituzionali, si trasformano di fatto in privilegi riservati a chi possa pagarli”.
“Il rischio è che, moltiplicandosi i centri di potere, la dimensione pubblica sia sopraffatta e cannibalizzata dagli interessi privati più forti. E che, di conseguenza, l’autorità centrale si indebolisca a tal punto da non essere più che l’ostaggio (o al limite il mediatore) tra potenti interessi di parte sempre più organizzati, indipendenti e rivali tra loro”.
A traghettare a livello politico questa mutazione sono stati e sono i populismi, nei quali l’identità collettiva si risolve nell’affiliazione all’uno o all’altro di schieramenti per i quali vale non tanto l’adesione a determinati valori e concreti programmi quanto la fedeltà alla persona del leader, forte del “vantaggio di non avere vincoli ideologici (…). Suo unico vincolo è la costante necessità di premiare i più fedeli”, consensualmente catturati entro una “rete di vincoli asimmetrici tra un polo dominante da un lato, e una pluralità di seguaci, affiliati e vassalli dall’altro”.
Essenziale è farsi consapevoli che “non ci troviamo di fronte a semplici retaggi del passato, destinati col tempo a sparire da soli, ma a tendenze emergenti, portate a rafforzarsi e capaci di erodere le istituzioni dall’interno”. La rifeudalizzazione, insomma, non è “un processo puramente regressivo”, ma non solo: “l’aspetto che più colpisce è che la sua accelerazione ha avuto luogo in perfetta coincidenza con l’evoluzione della crisi, di cui i presunti fenomeni di rifeudalizzazione sono il precipitato”. Si può affermare che “Le spinte alla rifeudalizzazione provengono dall’interno dell’apparato istituzionale: dagli stati sovrani, dai mercati finanziari, dall’innovazione tecnologica e dagli strumenti giuridici adottati o imposti alla comunità internazionale. L’erosione dell’ordine moderno ha dunque i tratti di una paradossale autodistruzione, che ripropone nel cuore delle pratiche istituzionali la complessa dialettica dell’Illuminismo denunciata da Horkheimer e Adorno quasi un secolo fa”. (I quali, non caso – si potrebbe osservare – non sembrarono individuare vie d’uscita dalla situazione che avevano preconizzato…).
Efficace risulta la sottolineatura di come finanziarizzazione (ossia “un modello di accumulazione in cui la realizzazione del profitto avviene primariamente attraverso canali finanziari piuttosto che attraverso il commercio e la produzione di merci”) e crescente digitalizzazione di ogni ambito siano fenomeni strettamente correlati, condizione uno dell’altro e terreno di coltura dei processi di rifeudalizzazione. Senza che si possa dimenticare tuttavia che “la ‘svolta’ che ha rimodellato il mercato intorno agli anni Ottanta [ed] è regolarmente ricondotta al dominio ideologico del neoliberalismo” non è “il frutto intenzionale di un programma, messo a punto dai think tank neoliberali e realizzato da politici come Ronald Reagan e Margaret Thatcher” e loro eredi: “È poco verosimile però che a ritagliare un ruolo da protagonista alle imprese finanziarie e digitali possano essere state decisioni altrui, concepite all’esterno delle imprese, nei cenacoli accademici o nelle commissioni parlamentari. La cronaca insegna piuttosto il contrario. Negli ultimi decenni, l’iniziativa politica ha regolarmente rincorso le novità imposte dall’evoluzione tecnologica e dall’intraprendenza delle aziende. (…) D’altra parte, sarebbe ugualmente riduttivo ricondurre la trasformazione del mercato a un qualche piano concepito dalle grandi imprese o dalle lobby finanziarie.” Conviene piuttosto convincersi che “il mutamento generale è per lo più qualcosa di molto diverso da quanto i singoli attori avessero preventivato e nasce più dagli automatismi e dalla logica interna delle strutture istituzionali che non dai progetti consapevoli degli uni o degli altri”. Ciò non toglie che il processo della rifeudalizzazione registri “l’intensità con cui il mercato ipermoderno si sta spogliando delle sue vesti ideali, per esibire proprio i tratti che la modernità, a torto o a ragione, aveva relegato nel deposito oscuro dei retaggi feudali”. Non ultimo il privilegio di pochi soggetti privati di agire quali “custodi della soglia di un ecosistema al di fuori del quale è sempre meno concepibile che possano aver luogo sia la produzione sia lo scambio”, mantenendosi tuttavia a distanza “dalle transazioni che materialmente avvengono al suo interno, fino a raggiungere una sostanziale indifferenza per quello che è di volta in volta il loro contenuto effettivo.
Sta di fatto che “agendo in parallelo, finanziarizzazione e digitalizzazione dell’economia hanno prodotto un effetto congiunto di portata dirompente: quello di spingere tutte le aziende – nei limiti in cui possono permetterselo – a smaterializzarsi, cedendo ad altre imprese (spesso affiliate o vassalle) gli aspetti materiali della produzione, a cominciare dalla gestione della forza-lavoro. (…) Con l’avvento delle piattaforme digitali, svalutazione del lavoro e compressione dei diritti si sono ulteriormente accentuati”: “l’immaterialità dei flussi di denaro e di attenzione [attraverso la rete] rende le grandi corporation relativamente immuni dai limiti territoriali, creando un vantaggio esorbitante rispetto a un sistema politico ancora rigidamente vincolato ai confini materiali dello stato nazionale”.
Ma a rafforzarli “contribuisce in modo risolutivo il sostegno spesso entusiastico degli investitori e degli utenti, portati a condividere e difendere l’interesse delle corporation anche contro il governo e le associazioni sindacali del proprio paese”. A vincerla è “la generica pulsione a migliorare la propria condizione (…) equiparata al desiderio di ricchezza e di successo, fino a coincidere con l’interesse ad aumentare in modo indefinito il proprio capitale di denaro, popolarità e potere vero e proprio”.
L’ombra di un radicale pessimismo antropologico è comunque sventata dall’autore: “Non c’è motivo di credere che gli esseri umani siano diventati più egoisti o più cinici che in passato. (…) Il punto è che (…) ciò che rimane fuori dal mercato e dallo scambio collettivo resta qualcosa di semplicemente privato: uno spreco, quindi, o un lusso, che può al limite rientrare in gioco come segno di distinzione e di prestigio, attirando così di nuovo, quasi suo malgrado, denaro e attenzione; ma che, molto più spesso, si esaurisce invece senza dare frutti, intaccando le riserve di capitale e avvicinando così l’onnipresente minaccia di indigenza, invisibilità ed esclusione”.
A mettere in luce la debolezza di chi si oppone ai processi in corso è la sempre più accentuata “svalutazione del lavoro, divenuto negli ultimi decenni sempre più precario, frammentario, mal retribuito e privo di tutele. (…) Nei limiti in cui resta una potenza materiale, parte integrante del mondo reale, il lavoro subisce lo stesso destino di ogni altra risorsa naturale: diventa un combustibile della valorizzazione, da comprimere e consumare al costo minimo, per estrarne il massimo potenziale di denaro e di potere”, creando così nuove e più rilevanti diseguaglianze”. Rispetto alle quali “nessuno dei partiti democratici occidentali ha davvero proposto una soluzione alle disuguaglianze, all’erosione dello spazio pubblico e a tutta la costellazione di problemi che è al cuore del paradigma della rifeudalizzazione. Ci si è limitati a fingere una soluzione, fino a che la finzione è divenuta insostenibile”.
Osservazioni, queste, che nella sostanza concordano con quelle espresse da Guido Mazzoni nel suo Senza riparo (in queste note il mese scorso).
In conclusione, “Il problema basilare delle forze attualmente dominanti è che, per quanto possano trincerarsi in spazi artificiali e zone off-shore, la loro sussistenza resta comunque vincolata al mondo della vita, ai suoi bisogni e ai suoi equilibri interni. Più avanza perciò il processo di accumulazione, più rischia di distruggere le sue stesse condizioni di esistenza. Considerate sotto questa angolatura, l’indifferenza per il mondo e la potenza distruttiva scatenata dalla rifeudalizzazione si mostrano per quello che sono: sintomi di impotenza, non di forza, che mascherano a stento la crescente incapacità di coordinare le diverse componenti del sistema-mondo in una configurazione stabile”.

Quello che alla fine si ripresenta è “un dilemma cruciale che, nelle sue linee generali, era stato avvertito e diagnosticato già ai primi segnali di quella che Gramsci definì la ‘crisi organica’ dell’ordine istituzionale moderno. Adesso come allora, la chiave di tutte le difficoltà è che, una volta raggiunta un’estensione planetaria, la sussistenza del sistema-mondo genera problemi di ordine sistemico che non sono più compatibili né col sistema di imprese private previsto dal capitalismo, né con la sovranità dei singoli stati nazionali su cui poggia tuttora il diritto moderno. La differenza principale rispetto al passato è che una simile incompatibilità, oggi, non suona più come un’ipotesi azzardata o rivoluzionaria, ma come una constatazione che si avvicina all’evidenza. La devastazione ambientale ne è un esempio palmare. È difficile in effetti anche solo immaginare una risposta adeguata alle sue tante sfaccettature – dal cambiamento climatico allo sperpero delle risorse naturali – senza prospettare un modello di economia circolare irriducibile alla semplice massimizzazione dei profitti e incompatibile con la rivalità incondizionata tra i singoli stati nazionali. Un quadro analogo si ripropone per le grandi migrazioni, rese inevitabili da un ordine globale che esaspera allo stesso tempo tanto l’interdipendenza tra i diversi paesi quanto la loro intollerabile disuguaglianza. Per giungere infine all’uso sistematico del diritto alla guerra, incompatibile con la potenza distruttiva non solo delle armi nucleari ma anche delle tante modalità di aggressione che impropriamente continuiamo a definire “convenzionali”.
Il meccanismo di espansione, con cui in passato la società moderna ha tamponato questo genere di difficoltà, non risulta più riproponibile, a meno di non immaginare un’espansione extraplanetaria che, al momento, rientra nel novero delle semplici fantasie distopiche”.
