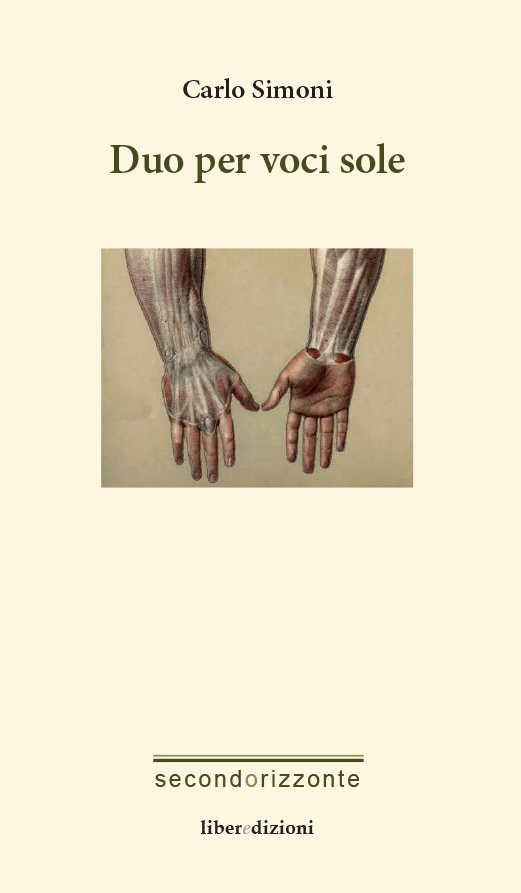
Carlo Simoni, Duo per voci sole, Secondorizzonte-Liberedizioni 2025 (pp. 368, euro 16)
In tutto diversi, per storia personale, cultura, condizione sociale, i due protagonisti, il grande concertista e il diseredato, sono accomunati dalla solitudine che abita i loro giorni.
Le loro vite scorrono parallele, distanti anche se si svolgono nella stessa città. Fra la notorietà dell’uno e l’anonimato dell’altro, tuttavia, si lasciano percepire risonanze che sembrano preludere a un avvicinamento. Un incontro, casuale e insieme presagito, avverrà infatti e si risolverà per entrambi in una catastrofe.
Le loro voci, che si erano per un attimo incrociate, tornano ad echeggiare sole, più di quanto lo fossero mai state. Fino a spegnersi.
Al di là delle vicende dei due personaggi principali, e di altri che pure svolgono ruoli decisivi, la storia è attraversata da alcuni temi essenziali: la musica innanzitutto, la sua specificità e i destini che l’hanno segnata a partire dal primo Novecento, ponendo interrogativi, non solo di carattere estetico, che attraversano la sensibilità contemporanea.
Le idee e le speranze degli anni Sessanta e Settanta, in secondo luogo; la fiducia in un superamento delle disuguaglianze, a partire da quella che si annida nei dislivelli culturali.
Ma è anche un altro il fulcro attorno al quale la voce narrante si focalizza: la pratica dello scrivere, le scelte che la costruzione di un romanzo implica, in un crescendo nel quale vicenda e scrittura, personaggi e autore si incrociano fino a confondersi.
Quelle che seguono sono alcune pagine tratte dal romanzo:
Sono quei giorni che a ogni bivio cominci a chiederti se andare a destra o a sinistra: giro di qui o giro di là? attraverso la strada o vado avanti su questo marciapiede? arrivo fino al parco o giro prima? So che bisogna smetterla e lasciar fare alle gambe: farsi andar bene la prima cosa che viene in mente, non perder tempo con le alternative, andare. Tanto è lo stesso.
Venivo giù da via Torino. Camminavo piano, come faccio quando sono così. Guardavo. Guardavo la gente che guardava le vetrine, le vetrine con dentro babbi natale e renne, i festoni di stelline illuminate, guardavo qualche donna che valeva la pena di guardare, o un bambino che mi guardava dal tram che passava.
Guardavo senza vedere niente. Non è che non volessi – vedere, dico. È che ti sembra che non ci sia niente da vedere quando sei così. È come se cercassi ma senza fiducia. Come se cercassi, anzi, per esser sicuro che tanto non troverai, perché non c’è proprio niente da cercare. Fuori di casa almeno. E difatti ti guardi in giro come se fossi ancora nella tua stanza davanti al computer a cercare le parole da scrivere. Solo quelle.
Perciò ho fatto un salto – dentro, dico; dentro di me – quando l’ho visto. Era come se di colpo si fosse fatto buio intorno e solo lui fosse in luce, quasi non ci fosse altro da vedere.
Ho ripreso a camminare ma continuavo a pensarci. Non sapevo togliermelo dalla testa. Cosa ci faceva lì? Non era un caffè per gente come lui. Uno può andare dove vuole, certo, non è che lo buttano fuori. Però in genere sa dove andare. Uno così lo puoi vedere in un bar di periferia, in piedi al banco, o seduto che legge la gazzetta, o in una sala d’aspetto alla stazione dei treni. O su una panchina ai giardini, a fumare. La barba fatta male, quei pochi capelli scarruffati. E poi quel maglione slabbrato, e il cappotto: di quelli dei tempi di mio padre, che lui chiamava paletò. Pesante, col collo fatto come quello delle giacche ma più grande. Era fuori posto insomma. Mica per l’età, no: in un caffè del genere non ci vanno i ragazzi, e neanche quei giovani con le scarpe lunghe e la punta quadra e l’auricolare del telefonino sempre attaccato all’orecchio che li fa parlare da soli. No: era un caffè per signori e signore d’una certa età e lui stesso avrà avuto una sessantina d’anni, o qualcosa di più, perciò niente da dire su questo. È che era un poveraccio, come si dice. Fuori posto.
Ero arrivato alla Colonnetta: giro per San Lorenzo o vado giù per Porta Ticinese? Vado di qua, no, tiro dritto. Avevo rallentato per decidere e mi è venuta in mente una cosa. Una cosa che avevo visto e che credevo di aver già dimenticato, invece no, e non sapevo perché ma mi sembrava importante. Un indizio. Un particolare che poteva spiegare tutto. Anche se non sapevo che cosa ci fosse da spiegare.
La mano. La mano di quell’uomo.
Era una manona, di uno che ha sempre fatto lavori pesanti. Del resto era grande e grosso, e la mano era in proporzione, ovviamente. Ma non era questo. Il fatto è che la teneva sul tavolino appoggiata con il palmo rivolto verso l’alto, e le dita un po’ piegate: un granchio. Uno di quei granchi rossicci, che si mangiano aprendoli come scatolette. Mai mangiati io, mi fanno impressione. Comunque ne ho visti. Ecco: un grosso granchio girato sulla schiena con le zampe verso il cielo. Morto. No: vivo ma inerte. Come volesse sembrare una cosa, o non gli importasse di sembrare una cosa, o fosse davvero lì lì per diventare una cosa.
(…) Be’, sono tornato indietro. (…) Ho accelerato il passo. Non mi ero neanche accorto della strada che avevo fatto.
E intanto che tornavo indietro mi è venuta in mente un’altra cosa: lo sguardo, gli occhi di quell’uomo. Mi era sembrato in un primo momento che avesse visto qualcosa che l’aveva sorpreso, o meglio: allarmato, e infatti mi ero girato per vedere cosa, e non avevo visto niente di strano. Ma adesso capivo che quello era il modo in cui guardano occhi dietro i quali non c’è niente. Era lo sguardo di un uomo vuoto. Completamente vuoto.
Quando sono arrivato là lui non c’era più. Non c’era nessuno, al tavolino dietro la vetrina del caffè.
Si può raccontare, la musica, ma non è come raccontare con le parole…
È vero: è come se venisse prima, concorda pensoso lui.
La musica va a prendere i suoi racconti dove non ci sono ancora le parole, conclude Lena.
Ma dove, che cosa c’è là?
I sentimenti…
Ma ci sono sentimenti senza le parole?
C’è il silenzio là. E il silenzio… Il silenzio è la casa dei sentimenti. Quando se ne parla, quando li si nomina, è come se li si portasse alla luce, gli si desse voce, e nello stesso tempo li si gelasse, li si imbalsamasse. Quando li si toglie dal silenzio per metterli in parole diventano subito il ricordo di quello che sono stati, non sono più vivi…
È lei stavolta a restare pensosa, e Andrea invece ad arrivare a quella che a tutt’e due sembra un’intuizione luminosa: suonare allora vuol dire far uscire la musica dal silenzio, ma senza uccidere i sentimenti di cui è fatta: la musica è il mezzo con il quale i sentimenti si possono conservare vivi nel mondo delle parole…
(…)
La velocità lo inebria. Anche in questo valzer di Chopin. Alle prime battute sa rendere bene l’indecisione, quel riflettere perplesso, ma poi si lancia in quelle cascatelle di note che seguono e le esegue come se dovessero raggrumarsi in un’unica frase.
(…) Non sarai mai abbastanza veloce, gli dice lei, quasi sussurrando: mai quanto vorresti.
Non so far diversamente, risponde Andrea asciutto: è un discorso che abbiamo già fatto, non porta da nessuna parte.
Ricordi quello che dicevamo qualche mese fa? Non avendo risposta, prosegue: dicevamo che suonare è far uscire la musica da dov’è, dal silenzio.
E dunque?
Tu ce la vuoi far tornare al più presto.
Che cosa intendi dire?
Che non accetti fino in fondo il miracolo che rappresenta: ti adegui al fatto che i suoni rompano il silenzio ma molto meno accetti che il silenzio torni a inghiottirli, e allora preferisci che la cosa si concluda al più presto e non ci sia più da soffrire.
Ma, mentre suono… tenta di argomentare lui.
Ecco: mentre. Hai detto bene. Suonare è stare in quel mentre. La musica è questo mentre. E ha il suo tempo. È il suo tempo. (..) la musica è esattamente come la vita. È il mentre che sta fra due nulla, un prima e un dopo che non sono altro. È il miracolo quotidiano di questo librarsi senza motivo. Senza il motivo che la musica invece sa cercare, e trovare, in sé stessa. La musica è il sogno della vita, dice ad alta voce. E Andrea la guarda, senza comprendere appieno queste parole ma avvertendovi il sapore di una verità, enigmatica.
(…) la boxe sembra uno sport violento e basta, e invece impari un sacco di cose. Certo che ci si può far male, ma solo se ci metti rabbia, cattiveria. Se non la lasci giù dal ring, la rabbia, è meglio che non ci sali, perché quello che volevi era picchiare, non fare boxe, capisci?
(…) E poi, se hai dentro la rabbia non credere di ottenere qualcosa: se sei arrabbiato non sei lucido, e nella boxe bisogna usare la testa, ricordatelo sempre. La boxe ti insegna a vivere: il vero combattimento non è quello che fai quando sei sul ring. È quello che devi fare ogni giorno, nella tua vita, uscito dalla palestra, e stare nel modo giusto sul ring ti aiuta a comportarti come si deve quando sei fuori, perché anche fuori ti devi mettere in gioco, capisci? Sempre. Mettersi in gioco: accettare quello che arriva e cercare di parare i colpi, e quando è il tuo momento non lasciartelo scappare, capisci?
(…) Il baricentro può essere spostato in avanti o indietro. Modesto tiene la seconda posizione, istintivamente. Non è il pugile aggressivo. La sua mole potrebbe far pensare che sia uno di quelli che si gettano sull’avversario e cercano di aver la meglio con la pura forza. Invece no: anche quando prende qualche colpo (…) non si fa prendere dalla rabbia, non reagisce. Si direbbe lasci libero l’avversario di sentirsi superiore, ma non si comporta così per furbizia. Non è dissimulazione la sua: è umiltà. Di tutti gli insegnamenti che gli ha dato Germano questo è quello che l’ha segnato più a fondo, e che lui ha sentito subito congeniale: bisogna essere umili, e poi ha aggiunto, ridacchiando: non modesti. Modesto lo sei di nome ma non devi esserlo di fatto, perché chi fa il modesto lo fa solo per sentirsi fare complimenti dagli altri. Essere umili è una cosa tutta diversa: vuol dire guardarli, gli altri, vedere cosa ti offrono, imparare, tutti i momenti, sia che facciano bene sia che facciano male. Bisogna essere forti, avere fiducia in sé stessi per essere umili. Non credere di essere chissà chi: sapere chi si è, fin dove si può arrivare, e non dimenticarsene mai. Se pensi così puoi fare progressi davvero, se no avrai solo la soddisfazione di sentirti dire bravo anche se non lo sei stato. Se sei umile sai incassare i colpi, senza sentirti offeso, e sei capace anche di non lamentarti, dopo: lamentarsi non serve a niente, non cambia niente. Serve solo a restare attaccato a quello che ti ha fatto male, invece di andare avanti.
(…) Modesto spesso anticipa le indicazioni del maestro, che allora tace e lo osserva, anche quando evita i colpi, più che bloccandoli con il guantone facendo un passettino indietro, o curvandosi, sempre sull’esterno del braccio che ha cercato di colpirlo, in modo da non trovarsi esposto all’altro.
(…) Per l’allenamento al sacco ha poi una vera passione: tre minuti di colpi e poi un minuto di riposo, e a ogni ripresa un numero di colpi maggiore che nelle precedenti: fino a una mitraglia di dieci colpi. Al sacco Modesto sembra perdere la sua calma, il suo distacco: mena pugni con tutta la sua forza, fa quasi paura.
Ordini

Se vuoi leggere il libro nella sua interezza lo puoi acquistare alla nuova libreria Rinascita di Brescia (16 euro).
Via della Posta, 7 – 25121, Brescia – Tel. 0303755394
libri@nlr.plus
Se vuoi riceverlo a casa puoi inoltrare il tuo ordine indirizzandolo a: ordini@secondorizzonte.it
e segnalando l’avvenuto versamento dell’importo indicato tramite bonifico sul conto corrente della libreria (IBAN: Unipol Banca – Agenzia di Brescia: IT 10 B 031 2711 20000000000 1851).
La spedizione non comporta aggravi di spesa.
Recensioni
Da “Brescia si legge”, letto e recensito da Candida Bertoli.
L’ultimo romanzo di Carlo Simoni Duo per voci sole (Liberedizioni, 2025) coinvolge il lettore fin dalle prime pagine.
Il racconto, ambientato principalmente a Milano con un intervallo in Austria per uno dei protagonisti, inizia intorno agli anni ‘40 del Novecento per svolgersi principalmente negli anni ‘70 e narra in parallelo la storia di Andrea Ramelli e di Modesto Natali.
Andrea Ramelli nasce in una famiglia agiata, che gli consente di intraprendere lo studio del pianoforte e di proseguirlo, dopo il diploma al Conservatorio, in una scuola di specializzazione a Salisburgo. Andrea è generoso, convinto che
quanti vivono ai margini siano i migliori, che la disuguaglianza non sia riuscita a corromperli, che a loro sia affidato il compito di mostrare che il mondo è innocente. Inconsapevole se mai, non maligno. E che dunque sia possibile, e stia a noi, a ciascuno di noi, gettare ponti tra i privilegiati e i miserabili, i visibili e gli invisibili, coloro che trovano dimora nella vita e quelli che la trascorrono da stranieri, senza nome.
Benché la sua carriera sia ricca di soddisfazioni – arriverà ad aprire la stagione alla Scala di Milano e a conseguire numerosi premi – il suo animo non è mai appagato. La sua ricerca, musicale e interiore, è continua ed il suo percorso artistico attraverserà la storia della musica, da Mozart ai compositori dei primi del Novecento, come Alban Berg, Arnold Schönberg e Anton Webern. Nello stesso tempo, è un uomo che vive di passioni umane, civili, che si fa carico della sorte dei diseredati al punto da sovvertire il programma di un concerto alla Scala per partecipare al lutto per un naufragio di un barcone di migranti, affondato vicino a Lampedusa. Ma anche un altro lutto lascerà un solco profondo nell’animo di Andrea, quello per la morte di suo padre: quando viene a mancare, si rende conto di aver sempre suonato per lui, per affetto, per gratificarlo di ciò che il genitore non aveva potuto avere. Ha sempre sentito su di sé il suo sguardo soddisfatto ed orgoglioso, al suo giudizio era sempre subordinato quello degli altri; la sua assenza lascia un vuoto incolmabile, come se Andrea non sapesse più per chi suonare.
Il secondo protagonista del romanzo è Modesto Natali, che all’età di tre anni viene abbandonato dalla madre davanti ad un convento in cui trascorrerà tutta la vita. Modesto è una persona mite, con talenti che non vengono coltivati. Chi sceglie per lui, decide di non farlo studiare ma di iscriverlo ad un percorso di avviamento professionale: in seguito si dedicherà all’orto del convento, sarà addetto alla legatoria e stamperia interna e, in parallelo alle vicende del collegio gestito dai monaci, diventerà boxeur e poi istruttore di boxe e massaggiatore sportivo. Lui non beve, non gioca, non fuma, ma lavora e non si risparmia mai:
Ecco com’è stata. Modesto, adesso che aveva preso passione al mestiere di legatore ha dovuto tornare a fare anche il giardiniere. Metà e metà. Solo che poi ha voluto mettere conigli e galline. Ha chiesto al Padre Superiore e quello gli ha detto di sì. Lui con le bestie è bravissimo. Gli mette il nome a tutte, gli parla insieme, e poi, quando è il momento, tira il collo alle sue galline o dà quel colpetto che ci vuole per ammazzare i conigli, tranquillo che sembra che non li abbia mai neanche visti prima. E poi l’orto: mica solo patate cipolle carote e coste. Ha messo anche le angurie e ha voluto provare con le fragole. Insomma, si è aumentato il lavoro da solo e ci sono interi periodi che la mattina non ce la fa ad andare da Tomaso. Quando era là con lui avrebbe dato chissà cosa per stare con Fausto. Adesso un po’ gli spiace perché anche stare alla legatoria è bello. Proprio vero che non si è mai contenti, e che quello che hai desiderato magari poi arriva ma quando ormai sarebbe meglio di no.
Mettici poi che se si rompe un rubinetto chiamano Modesto, se c’è una lampadina che occorre la scala per cambiarla è lui che deve farlo. E nei momenti liberi sta mettendo a posto il suo laboratorio, che sembra quello di un idraulico, di un elettricista e di un falegname insieme.
Ci sono dei giorni, a fine pomeriggio, che lo vedi ancora lì, dietro il finestrone, che aggiusta qualcosa, fa di tutto, insomma. Tutto fuorché guidare.
Le vite dei due personaggi si sfioreranno presto, già da quando il maestro di musica del convento porterà Modesto ad un concerto di alunni del Conservatorio in cui un Andrea giovanissimo è tra i talenti nascenti. L’ascolto della musica, le mani di Andrea, l’atmosfera del concerto si imprimeranno nella memoria di Modesto, che dieci anni dopo riconoscerà il pianista nella copertina di un disco. La musica saprà parlare anche al suo animo e Modesto ne raccoglierà i frutti: avvertirà nuove emozioni, percepirà dall’ascolto della musica ottimismo, positività, energia.
Due personaggi diversi, che l’autore conduce nei reciproci percorsi fino all’inatteso epilogo.
Per me è mettere in pratica – ammesso che lo scrivere si possa definire qualcosa che ha a che fare con la pratica – la mia convinzione che una vera differenza tra le vite non ci sia. O meglio: non ce n’è una uguale all’altra, non c’è dubbio, ma questo non impedisce di credere che, al fondo, abbiano lo stesso valore.
Nel romanzo i protagonisti principali sono Andrea e Modesto, ma intorno a loro si muovono molte altre figure – amici, mogli, famigliari, compagni di vita o di lavoro – che realizzano così una scena teatrale composita, in cui l’autore stesso è coinvolto.
Il romanzo è una lettura estremamente piacevole, la storia è coinvolgente e ben strutturata; lo stile è più ricercato quando lo sguardo è su Andrea e più colloquiale quando invece si posa su Modesto.
Nel libro sono contenute riflessioni e digressioni sulla musica contemporanea, che se da un lato saranno apprezzate compiutamente dai conoscitori, dall’altro stimoleranno il lettore interessato all’approfondimento dell’argomento. Un bonus track è infine contenuto nelle ultime pagine del libro, in cui sono indicati i brani musicali citati in ognuno dei capitoli.
Si può raccontare, la musica, ma non è come raccontare con le parole…
È vero: è come se venisse prima, concorda pensoso lui.
La musica va a prendere i suoi racconti dove non ci sono ancora le parole, conclude Lena.
Ma dove, cosa c’è là?
I sentimenti…
Ma ci sono sentimenti senza le parole?
C’è il silenzio là. E il silenzio… il silenzio è la casa dei sentimenti. Quando se ne parla, quando li si nomina, è come se li si portasse alla luce, gli si desse voce, e nello stesso tempo li si gelasse, li si imbalsamasse. Quando li si toglie dal silenzio per metterli in parole diventano subito il ricordo di quello che sono stati, non sono più vivi…
È lei stavolta a restare pensosa, e Andrea invece ad arrivare a quella che a tutt’e due sembra un’intuizione luminosa: suonare allora vuol dire far uscire la musica dal silenzio, ma senza uccidere i sentimenti di cui è fatta: la musica è il mezzo con il quale i sentimenti si possono conservare vivi nel mondo delle parole…