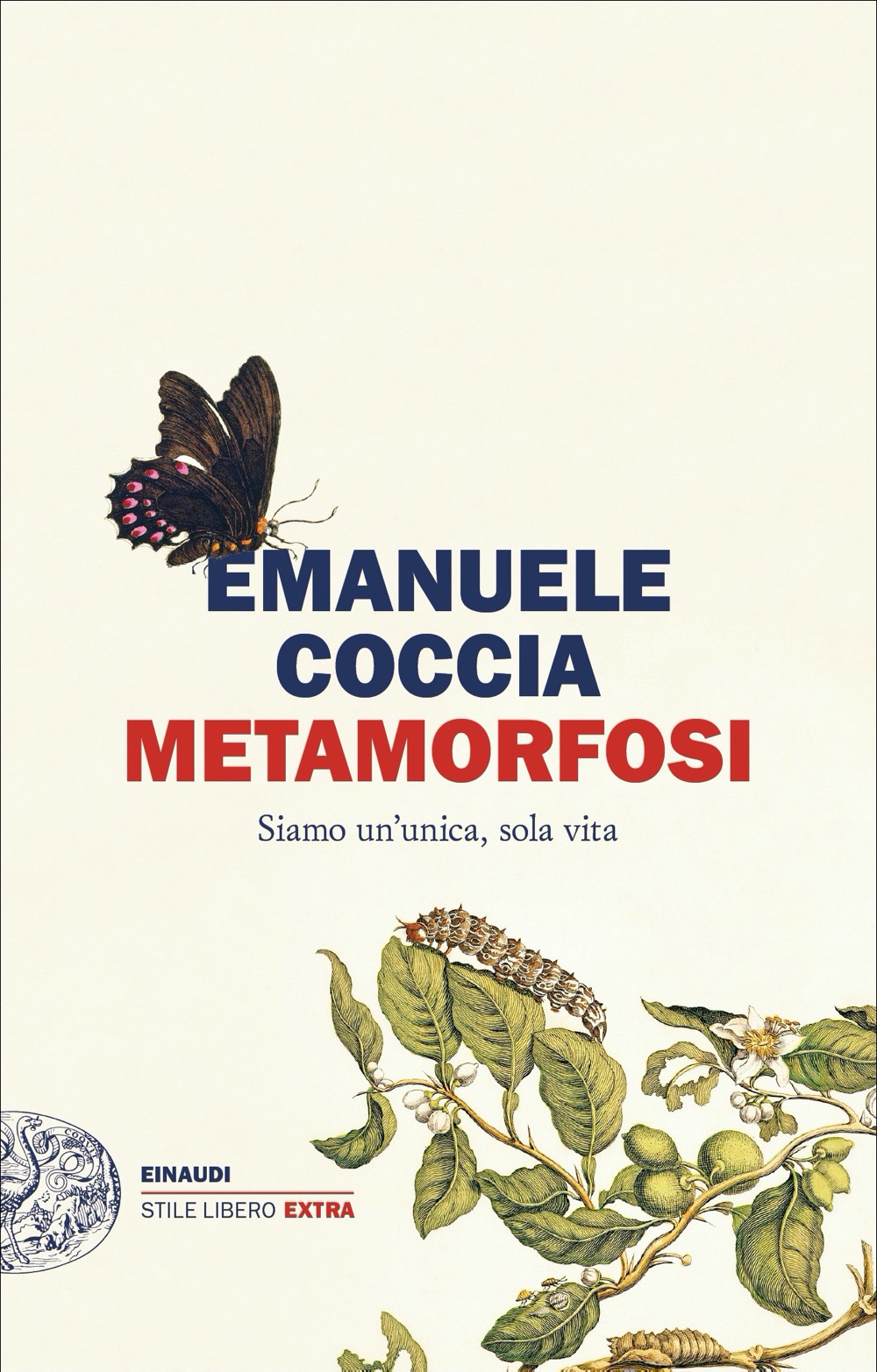
Emanuele Coccia, Metamorfosi, Einaudi 2022 (pp. 196, euro 17)
“Tutte le forme di vita sono figurazioni di una medesima sostanza, modi accidentali che non smettono di crearsi l’uno dall’altro e di distruggersi l’un l’altro”: la premessa richiama – quasi letteralmente – Spinoza, ma rimanda alla filosofia antica (dai presocratici agli atomisti, da Anassimandro ed Empedocle a Epicuro e Lucrezio) e in generale alla tradizione filosofica che vede la morte come l’esito di un naturale avvicendarsi di fasi, ricombinarsi di elementi, variamente definiti, che costituiscono il Tutto, di cui siamo parte.
Si nasce in conseguenza della temporanea congiunzione di alcuni di questi elementi e si muore per la loro immancabile disgiunzione. “Nulla muore nel grande mondo (…) tutto muta e cambia volto – secondo Ovidio –; si chiama nascere cominciare a essere un’altra cosa rispetto a ciò che si era, e morire il contrario”.
Che rientri nel Tutto o sia vittima della specie, l’individuo, in quanto tale, è sostanzialmente un epifenomeno di un rivolgimento ininterrotto che lo ingloba e lo sovrasta. Una visione tragica che può tuttavia essere letta in modo opposto: essendo parti del Tutto, da cui veniamo a cui ritorniamo, di fatto non nasciamo né moriamo.
È su questo secondo versante che si dispone Coccia portando argomenti che attingono al sapere filosofico così come a quello scientifico, soprattutto quando si sofferma sulla natura degli insetti o delle piante (tema al quale aveva dedicato uno specifico contributo con La vita delle piante. Metafisica della mescolanza, il Mulino 2018): “Abbiamo moltiplicato le forme e i modi di essere [nel corso dell’evoluzione], ma ancora oggi siamo tutte e tutti la stessa vita. Da milioni di anni questa vita si trasmette da corpo a corpo, da individuo a individuo, da specie a specie e da regno a regno”: i confini sono dunque solo momentanei e apparenti, anche quelli fra inorganico e organico, perché non c’è nulla che sfugga alla grande incessante totalizzante metamorfosi. Per cui “La nostra vita comincia ben prima della nostra nascita e finisce molto tempo dopo la nostra morte. Il soffio vitale che è in noi non si esaurisce nel nostro cadavere, ma nutrirà tutti quelli che troveranno in esso un pasto da celebrare” [fossero anche soltanto i batteri e i microrganismi che producono la decomposizione del corpo sigillato in una bara – espressione del “bisogno di impedire al ‘corpo umano occidentale’ di diventare cibo per altre specie”]. Alla fin fine, in ogni caso, dopo il disfacimento dei tessuti molli, la scheletrizzazione e il più o meno parziale sfaldarsi anche delle ossa, così come dopo la cremazione – scelta dettata dall’“illusione che il nostro corpo resterà intoccabile” – il tutto finisce a mescolarsi alla terra, minerale fra minerali. [Al di là del modo in cui il cadavere è trattato per separarlo – fisicamente e simbolicamente – dagli altri viventi, è dunque solo questione di tempo perché si giunga a questo esito: “la mortalità è la dimostrazione che al cuore di ogni vita c’è una materia minerale, quella di Gaia (…) materia minerale, indifferente alle forme e tuttavia disponibile a tutte”].
Non è tanto sul dato materiale del processo che Coccia insiste tuttavia, quanto sull’inevitabile riconoscimento del fatto che “la nostra umanità [non] è un prodotto originario e autonomo: è prolungamento e metamorfosi di una vita precedente” che non si identifica soltanto in quella della specie, perché anche “le specie non sono sostanze”, ma “configurazioni instabili e necessariamente effimere”, implicate esse stesse nella metamorfosi che non contempla “contrapposizione tra il vivente e il non vivente”, sicché “la vita è sempre reincarnazione del non vivente, un bricolage del minerale, un carnevale della sostanza tellurica del pianeta”. [La pulsione dell’organico a tornare all’inorganico, ipotizzata da Freud, non sarebbe dunque a senso unico].
Una simile impostazione comporta che il punto di vista si sposti, di fatto, dalla morte alla nascita, o meglio: destituisca l’una e l’altra del significato di soglie iniziale e finale dell’esistenza: “restiamo [o quantomeno restavamo, fino a poco tempo fa, prima dell’affermazione dell’ideologia giovanilista, nelle sue diverse declinazioni] ammagliati dalla visione della forma del vivente nell’età adulta. Attribuiamo a questo stadio una perfezione e una maturità che neghiamo agli altri stadi”, mentre invece “ogni vita, per dispiegarsi, ha bisogno di passare attraverso una molteplicità irriducibile di forme” che vanno considerate “in termini di metamorfosi e non di evoluzione, di progresso o di involuzione”, e neanche di “conversione” o “rivoluzione” (distinzioni, queste, su cui insisteva anche da Ulrich Beck nel suo ultimo libro, in queste note il 24 settembre 2017). In gioco è la possibilità di liberarci “di ogni deriva teleologica” e persuaderci che “ognuna di queste forme ha lo stesso peso, la stessa importanza e lo stesso valore”, perché “la metamorfosi è il principio di equivalenza tra tutte le nature”, tra tutte le condizioni, identità, appartenenze. Che si rivelano infatti pluriappartenenze, in quanto ognuno di noi, nascendo, porta in sé “il corpo e la vita [non solo dei genitori, ma anche] di un’innumerevole serie di viventi, nati tutti da altri viventi, fino alle frontiere dell’umanità e oltre ancora. (…) Esistevamo già, ma in modo diverso: la nascita non è un inizio assoluto” e “l’io non è che un veicolo di materia straniera che viene da un altro luogo ed è destinata ad andare oltre di me”: “io veicolo un passato ancestrale e sono destinato a un futuro inimmaginabile”.
Evidente l’effetto di discorsi simili sul pensiero della morte e, come si diceva, sul posto assegnato alla nascita: “consideriamo la morte come un evento assoluto perché abbiamo elevato a feticcio la nostra personalità e la nostra natura puramente umana”, ma “siamo ossessionati dalla morte e dalla vecchiaia” anche perché siamo portatori di “una cultura prodotta e dominata da chi, per definizione, non ha mai fatto l’esperienza di mettere al mondo qualcun altro: i maschi”. Per questo “le nostre riflessioni sulla morte occupano intere biblioteche [e] la nascita, invece, resta un mistero e un tabù”, un ostacolo a comprendere [a sentire, come accade alle donne] che “la vera antitesi della nascita non è la morte, ma vedere il proprio corpo generare altri corpi”. Ma non è solo il genere a influire sulla percezione della morte: “la teologia cristiana ha contribuito a rendere impensabile la nascita allontanandola da ogni cornice naturalistica, fino ad arrivare a (…) considerarla un miracolo” e la filosofia, con pensatori come Heidegger, ha dal canto suo fatto della morte il destino proprio dell’uomo, suscitando reazioni decise, come quella di Hannah Arendt, che “ha trasformato la nascita nell’evento umano e antropogenetico [umanizzante] per eccellenza”, pur continuando a considerarlo appannaggio solo degli essere umani. La nascita, anche quella umana, è invece un momento della generale metamorfosi, che fa di noi “un pezzo di questo mondo” [non gettati in esso, potremmo quindi pensare, ma in esso temporaneamente affioranti]: “framment(i) che esistevano già ma ai quali abbiamo dovuto cambiare forma”, impadronendoci “di ciò che apparteneva a qualcun altro” e modificandolo. Per cui si è obbligati a “covare l’altro in sé, senza poter mai essere [esclusivamente] sé stessi, ma senza nemmeno potersi confondere o fondersi interamente nell’altro”: l’unicità dell’individuo non è negata (“nulla di ciò che vive oggi in noi ha mai vissuto questa specifica vita”), ma condizionata. Dagli altri da cui veniamo e che non cessiamo di portare in noi, ma anche dalla spinta endogena della metamorfosi che ad ogni età opera: “è giovane ogni vivente che non può riconoscersi interamente nella forma che lo ospita” e dunque non cessa di elaborarla. La giovinezza non è “soltanto una tappa effimera della vita di un corpo, ma una struttura stabile e costante di ogni corpo vivente”, come del resto dimostrato dalla biologia, per la quale “gioventù e vecchiaia sono forze organiche e spirituali che coesistono in ogni istante della vita di un individuo”. “La metamorfosi – infatti – è il ciclo dei diversi ringiovanimenti periodici del vivente” e, sotto questo profilo, “la tecnica è una procedura di ringiovanimento (…) più che una forza che si contrappone alla vita o che la prolungherebbe dall’esterno, la sua espressione più intima, il suo dinamismo originario”.

La visione ottimistica della tecnica e dei suoi poteri trova un corrispettivo – altrettanto scivoloso e unilaterale, a mio avviso – nella implicita presa di distanza dal vegetarianismo (da parte di animali, come gli uomini, per cui “la vita coincide con il fatto di ingerire il corpo di altri viventi”, per cui sarebbe “un errore vedere in questa necessità la prova della negatività e della morte”, essendo che “la morte non potrà mai interrompere la vita, [ma] ne cambia semplicemente modalità di esistenza”) e nella critica all’ecologia, percorsa – a detta dell’autore – da “una nostalgia tutta infantile dell’idea della natura come casa naturale, accogliente e benevola, una famiglia in cui ci sono solo fratelli e sorelle, padri e parenti, e mai veri e propri stranieri. (…) Noi tendiamo [con l’ecologia] puntualmente a proiettare sulle piante e sugli animali la nostra esperienza di socialità” e “l’ecologia non è mai riuscita a pensare al di là del paradigma domestico”, così disconoscendo la violenza reciproca insita nella natura e constatata da Darwin [che per altro, ma questo sembra sfuggire a Coccia, ammetteva anche un fondamentale spirito di cooperazione fra i viventi] e “riassorbendola in una razionalità occulta e più ampia fatta di pace, di armonia e di utilità universale”. Condividendo di fatto, in questo modo, ideologie apparentemente ad essa estranee: “ecologia e capitalismo sono fratelli: appartengono alla stessa famiglia e difendono interesse simili”, è la perentoria conclusione. Perentoria ma non tale da non ammettere – sia pure contraddittoriamente… – la necessità di uno sguardo aperto all’“osservazione del non-umano”. “La scoperta che una parte della nostra vita è identica a quella dei non umani – infatti – ci permette di riconoscere in questi ultimi dei tratti di umanità; viceversa, ogni volta che attribuiamo una caratteristica umana a una pianta o a un animale, riconosciamo che in noi c’è qualcosa che non possiede una natura prettamente umana”: una forma di antropomorfismo è una “necessità biologica” e non si risolve inevitabilmente in un’indebita proiezione. Anzi: la polemica contro l’antropomorfismo nasconde “un’affermazione furba e maliziosa dell’alterità assoluta e sacra dell’umano, che non abbiamo il diritto di paragonare a nessun altro essere vivente”. Antropomorfismo come antidoto dell’antropocentrismo, parrebbe di poter dedurre dunque, dal momento che occorre riconoscere che “in tutto ciò che sperimentiamo possiamo trovare l’esperienza di ogni altro essere vivente”, per cui “dobbiamo estendere l’antropomorfismo (…) uno strumento che ci permette di mescolarci con altre forme di vita e di ritrovarle in ogni nostro gesto”.
Sintesi finale: “non dobbiamo rispettare la Terra per la sua fragilità, dobbiamo invece imparare a viverla in un modo diverso, poiché il pianeta è la nostra futura carne. La carne di domani” e “l’avvenire è la pura forza della metamorfosi”, “il futuro ci impedisce di pensare la nostra identità come qualcosa di stabile, di definitivo”. Dunque, “non abbiamo bisogno di vaccinarci contro il virus del tempo. Sarebbe inutile, la nostra carne non smetterà mai di cambiare”. Né dobbiamo “aver paura di morire. Noi siamo il futuro. Viviamo in fretta. Moriamo spesso”. Un altro modo per dire quanto annunciato in apertura: “Tutte le forme di vita sono figurazioni di una medesima sostanza, modi accidentali che non smettono di crearsi l’uno dall’altro e di distruggersi l’un l’altro”.
