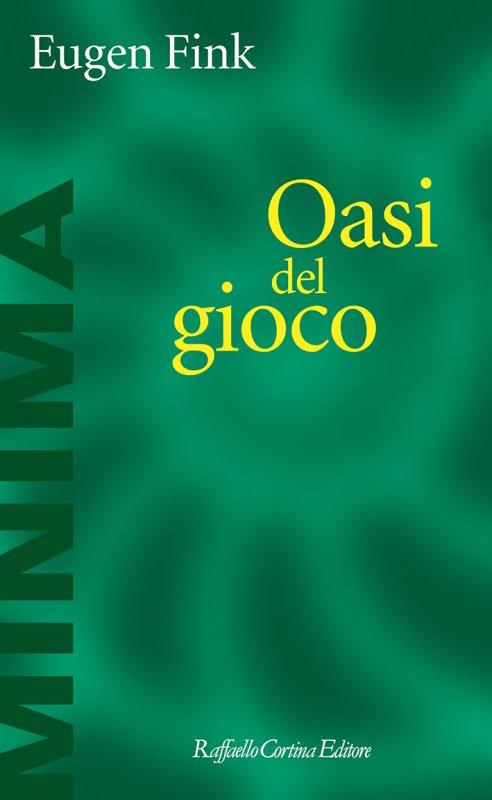
Eugen Fink, Oasi del gioco, Raffaello Cortina Editore 2008 (pp. 78, euro 9,50)
Il gioco può essere una buona cosa, ma non è una cosa seria, nell’opinione comune. Diversamente la pensa il filosofo, collaboratore di Husserl e di Heidegger, per il quale gioco è invece una dimensione esistenziale, una forma fondamentale per la vita quanto il lavoro, il potere, l’amore e la morte. Lo prova il grande spazio che al gioco, alle sue occasioni, alle strutture che lo rendono possibile riservano le società contemporanee, anche se – avverte un altro filosofo, Pier Aldo Rovatti, nella prefazione – altra cosa è il gioco di cui questo libro parla dal “divertimento organizzato dall’esterno” proprio delle nostre società-spettacolo che deformano e industrializzano l’intrattenimento”.
Certo è, e qui è Fink ad ammetterlo, che “nella storia dell’uomo ci furono tempi che vennero vissuti nel segno del gioco più del nostro presente, tempi che furono più sereni, più liberi e giocosi”, quelli cui si riferiva un grande storico, Johan Huizinga, nel suo Homo ludens. Tempi nei quali l’essenza del gioco era forse più evidente, e condivisa. Eppure tutti sanno, anche oggi, che cos’è il gioco, perché tutti hanno giocato, almeno da bambini (sempre che se lo ricordino…). Sanno che il gioco è “in grado di infondere alla vita uno stile diverso – sottolinea Rovatti – perché, diversamente dagli altri esistenziali [le forme fondamentali della vita, di cui si diceva], non è direzionato verso uno scopo finale, anzi si contrappone alla tensione verso il futuro che spinge e tormenta la nostra stessa vita. È un arresto, una pausa, un battere il tempo, appunto un’oasi nel deserto della nostra incessante inquietudine”.
Un’altra differenza non secondaria: il gioco sollecita, anzi: implica, una dimensione sociale: “la dimestichezza con il gioco è una dimestichezza sociale e pubblica. (…) mentre giochiamo avvertiamo con una particolare intensità il contatto accomunante con i nostri simili. Ogni gioco, anche il gioco ostinato del bambino più solitario, avviene in un orizzonte di comunione con gli altri”.
Non stupisce il riferimento frequente al bambino, professionista del gioco per il quale esso non rappresenta una pratica contrapposta a quelle cui sarà chiamato a dedicarsi seriamente, ma rappresenta “il centro felice dell’esistenza”. Meno scontato chiedersi se anche gli animali giochino: potrebbe sembrare, risponde il filosofo, che però precisa subito il suo pensiero: “Noi – e più che un plurale maiestatis, questo noi suona come un preciso richiamo a Heidegger e alla sua concezione dell’animale come povero di mondo – siamo del parere che il gioco umano abbia un senso profondo e genuino e che solo attraverso metafore indebite si possa parlare di un gioco degli animali”. A supportare la propria posizione, Fink offre una penetrante interpretazione del gioco della bambina con la sua bambola: sembra convinta di esserle madre, come se la bambola non fosse una cosa ma un essere vivente, ma al contempo non crede davvero che lo sia. Convincente, ma perché – viene da chiedersi – non osservare allora, con altrettanta finezza, il gioco del gatto con l’oggettino che gli si è buttato e che lui spinge di qua e di là proprio come farebbe con il topo appena catturato? Forse che il gatto confonde la cosa che ha fra le zampe con il malcapitato essere animato che potrebbe esser caduto in sua balia? Non occorre essere etologi per essere convinti di no, e che dunque anche il gatto gioca, e come lui altri animali, perché no?

Ma tornando al saggio filosofico, convince l’idea che il gioco risponda a un’esigenza specifica degli uomini del nostro tempo: quella di “liberarsi dall’angustia del tempo parcellizzato per guadagnare un rapporto più disteso con il tempo, in cui questo può venire sprecato e addirittura diventa così abbondante che lo possiamo di nuovo scacciare con un ‘passatempo’. Una contestazione, pacifica e gioiosa, insomma, del concetto che “il tempo è denaro” e del monito in esso implicito. Senonché, anche questa posizione, pur interessante e accettabile, confina ancora il gioco in uno spazio marginale, sporadico della vita, contrapposto alla sua ordinaria, necessaria serietà. Ne fa, nella sostanza, “un’aggiunta che dà sapore alla pietanza pesante del nostro essere”. Occorre allora cambiare il punto di vista, e constatare “quanta parte di gioco c’è ancora, nascosta, dissimulata, segreta, nei cosiddetti ‘affari seri’ degli adulti, nell’onore, nella dignità, nelle convenzioni sociali, e quanta ‘scena’ nell’incontro fra i sessi!”. Solo così diviene possibile rendersi conto che “il gioco appartiene essenzialmente alla costituzione d’essere dell’esistenza umana”, ossia alla struttura profonda del nostro stare nel mondo”, e ammettere che “l’uomo è essenzialmente un mortale, un lavoratore, un lottatore, un amante – e un giocatore”. Perché è nel gioco che fa un’esperienza altrimenti inattingibile, l’esperienza dell’“esistenza che si muove da sé”, senza essere oppressa dalla preoccupazione di raggiungere un obiettivo e dalla domanda di senso che normalmente la condizionano, e la opprimono, se non giungono ad angosciarla: “il giocare ha piuttosto il carattere di un ‘presente’ tranquillo e di un senso autonomo. (…) Il gioco ci rapisce”, perché “fa emergere una possibilità del soggiornare dell’uomo nel tempo, che non è quella che ci trascina via incessantemente e ci spinge avanti, questa piuttosto realizza un trattenersi, per così dire un istante, un lampo di eternità. (…) Il gioco ci regala il presente. Non quel presente in cui, acquietati nelle profondità della nostra esistenza, percepiamo il respiro eterno del mondo e contempliamo le pure immagini nel flusso del trascorre temporale”. Il gioco non è contemplazione, accettazione del proprio essere parte di un Tutto che non cessa di mutare: “il gioco è attività e creatività – e tuttavia ha una qualche somiglianza con le cose eterne e quiete”. In questo risiede la sua enigmaticità e al tempo stesso il suo senso.
