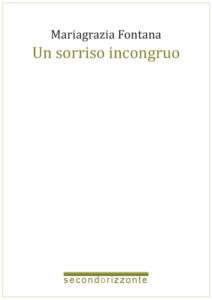
Fatica a dire di lui, ma da giorni le formicola dentro anche l’urgenza di farlo, da quell’incontro serale a fine turno. Ha tentato la strada dell’archiviazione, ma il suo volto pallido torna a sorriderle anche in sogno. E’un ronzio costante nei suoi pensieri, radicato oltre il pensiero, in quel sentire sottile che è la sostanza trasparente su cui poggia il vivere quotidiano. Qualcosa di meno pesante di una stoffa, ma non lieve come una nuvola, forse simile alla corrente che resta attiva nell’impianto elettrico anche a luci spente. In quel flusso galleggiano i suoi occhi chiari spalancati, di un candore sorridente. E’ un sorriso incongruo quello che gli si dipinge in viso mentre il fiato non sale, mentre il debito d’ossigeno costringe i suoi bronchi all’estremo fischio d’aiuto. Allora, quando la saturazione d’ossigeno precipita, tutti i pazienti sbarrano gli occhi, il terrore si dipinge sul loro volto, le mani si stringono a serrare le lenzuola e tutto, proprio tutto il corpo è un unico intollerabile sibilo acuto.
Lui invece sorride. L’aria gli stride nei bronchi, i polmoni non si espandono, la cassa toracica si distende in cerca di un grammo d’ossigeno che gli alveoli agognano e il suo volto, da sempre pallido, si fa bluastro, le occhiaie si demarcano, la cute del torace si marezza di chiazze scure e irregolari che dilagano negli arti.
Glielo avevano spinto in ambulatorio di corsa: codice rosso, non respira più nemmeno con le branchie, dichiarava l’infermiera di triage mentre velocemente dirigeva la barella nello slalom fra un paziente e l’altro, sorpassandoli tutti perché lui, il codice rosso, stava morendo in asfissia. Aveva già in carico il codice rosso di un anziano settico più morto che vivo, e l’idea di giocare su due tavoli, entrambi scivolosi, non l’attirava. Ma non è che si potesse scegliere, ci si doveva attrezzare ad affrontare ciò che capitava, che fossero uno, due o tre. Si fa quel che si deve e niente lagne, semplicemente si corre un poco di più e si spera che la sorte conceda una tregua, prima o poi.
Si erano riconosciuti subito e subito sorrisi. Che fortuna trovare te! Era riuscito a dire fra un sibilo e l’altro. Stai zitto Umberto, non dire nulla, devi concentrarti sul respiro che adesso ti faccio ritrovare, rispose lei mentre appoggiava il fonendoscopio su quel torace scarno e scavato, registrando rantoli in alto e silenzio totale dal campo polmonare medio in giù.
Quel torace annegava nel liquido che accartocciava i polmoni riducendoli a pugni contratti. Armeggiava su quel corpo in affanno bucando, ventilando, somministrando farmaci fino ad allungargli il respiro di quel tanto utile per tenerlo in vita. Riagguantare tutto quel fiato non era pensabile. Intanto lui non aveva smesso un attimo di sorriderle e di parlarle con gli occhi. E più il respiro gli veniva concesso più i suoi lineamenti si distendevano e lui cercava di dire, nonostante indossasse la mascherina dell’ossigeno. Ci parlava dentro. Era un’impellenza che lei non avrebbe fermato, perché lui era colmo di parole che lo chiamavano impellenti, come sapesse di non avere abbastanza tempo per tutto ciò che aveva da dire.
Gli tolse imprudentemente la mascherina e lo lasciò raccontare. Parlava a precipizio, mentre lei lo ascoltava e gli contava i respiri: la sua libreria, l’ulisse, con la u minuscola come lui amava precisare, chiusa da anni, la sua nuova passione per il vino vivo, l’eterno amore per i libri che non l’aveva lasciato mai.
Stentava a mettere insieme frasi lunghe e allora le accorciava, recidendo quel che non gli pareva essenziale, potando aggettivi e avverbi e sempre sorridendo.
Le venne facile rivederlo in libreria, già allora esile, pallido. Un uomo magrissimo, delicato ma non femmineo. Era nello sguardo la sua mascolinità, in quel modo obliquo e sornione di guardarti sollevando un sopracciglio quando aprivi la porta della libreria, di pesare quanto fossi carina e poi di sorriderti, pronto a rispondere alle tue richieste.
La libreria era piccola ma conteneva di tutto: saggi politici ovviamente, ma anche letteratura e poesia. Lui consigliava solo su richiesta, restava sempre un passo indietro, silenzioso, come non volesse turbare la sacralità del gesto di una mano che si allunga verso un libro per sfogliarlo, soppesarlo e forse innamorarsene. Ma se appena gli si rivolgeva uno sguardo interrogativo, ti raccontava vita, morte e miracoli dell’autore e magari commentava anche il testo, sempre con sobrietà, senza acide stroncature.
Ora, accompagnato da un gesticolare fluido, le raccontava invece la sua storia clinica, senza lesinare dettagli, snocciolando prognosi infauste che sembrava giocarsi sulla punta delle dita, come lanciasse la sua stessa esistenza in aria per riprenderla poi come una pallina. Descriveva toracentesi come elencasse l’indice di un testo, senza enfasi, senza preoccupazione evidente, senza un accenno al dolore che gli erano costate, alla disperazione verso una morte non lontana che lui stesso preannunciava con grazia.
Lei nascose gli occhi nelle pagine della sua cartella clinica, dedicando un’attenzione scrupolosa ad ogni ricovero descritto, per reggere la vista di quell’uomo che sorrideva alla sua stessa morte. Un uomo di settant’anni che si confondeva con il ragazzo smilzo e garbato che un tempo aveva tenuto in vita a stento una libreria del centro storico, dove ci si poteva rifugiare a fare due parole o semplicemente ad aspettare l’autobus che fermava proprio lì davanti. I respiri del passato gonfiavano le vele di quelle ore dure, come venendo in soccorso a un presente inclemente, dove il ragazzo s’era fatto vecchio e il suo fiatare era il borbottare di un bollitore.
Non erano mai stati amici, dieci anni di differenza sono molti da ragazzi e poca cosa da adulti incamminati verso la vecchiaia. Ora quel respiro ansante, quegli occhi chiari e sereni parevano tessere come un codice intimo fra di loro che sapevano poco l’uno dell’altra. Eppure essere insieme di fronte a quella fame d’aria, a quell’orizzonte che si chiude, a quell’ombra che si allunga, li avvicinava come un’amicizia di vecchia data.
Lei guardava con rispetto quell’uomo elegante e sorridente, arrendevole come l’acqua che si consegnava in pace al proprio destino, senza protestare, senza mettersi contro al tempo, rispettoso. Mentre lei si sporgeva per captare il suo timbro di voce sottile, lui dichiarava di sentirsi pronto, di essere sereno.
Nelle pieghe dei suoi pensieri lei si trovò a chiedersi come potesse essere vero, come fosse compatibile la serenità con il buio. Per un attimo la sfiorò il dubbio di una posa, di una parte recitata mentre il fiato faceva mulinelli cercando una strada. Ma quello sguardo e quell’instancabile e incongruo sorriso confermavano le sue parole, ne svelavano le ali possenti, così ampie e vigorose da reggere abilmente il significato che trasportavano.
Era così, quell’uomo camminava sulle tracce di una sapienza che lo teneva dritto in piedi, esposto ai venti e alle correnti ascensionali senza temere la sproporzione fra sé e il mondo, senza provare vertigine adocchiando il vuoto, senza cadere. Come se nulla di smisurato gli si spalancasse davanti, come se il vuoto fosse tutt’uno con lui, perché lui era il mondo, era il tempo, era il vivere e il morire, era l’infinito.
Forse per questo nell’ora della debolezza, lui così esile, s’era fatto forte, così forte da prendere il polso dell’ignoto sorridendo a dispetto di tutto, morte inclusa.
Era alla morte che stava sorridendo, forse s’erano già accordati, forse l’aveva intravvista nell’incoscienza dell’anossia e non l’aveva trovata poi così brutta. Forse pure lei, la morte, aveva il suo fascino.
Mentre l’immagine del suo sorriso attecchiva dentro di lei e lei ci si affidava, le parole fluivano ancora più lente e, con loro, il passato. I ricordi s’infittiscono quando il tempo s’accorcia e, a un certo punto, vivere sembra si riduca al solo ricordare.
Lui si stropicciò la faccia mentre lei lo fissava con avidità, come volesse carpirgli le coordinate di quella sapienza che lo rendeva sereno per farle proprie, per intercettarle a sua volta, domando l’eterno tumulto che le ribolliva dentro.
Gli vide i denti balenare ancora in un breve sorriso, disarmante, e sentì di aver attraversato la vita senza capire niente, al ritmo dei martelli del ragionamento. E intanto il suo corpo, a braccetto col tempo, era andato dritto per la sua strada, mentre la sua mente si intestardiva a imboccare un’altra direzione. E il tempo continuava a passare, e lei continuava a invecchiarci dentro.
Sentiva tutta l’insufficienza del suo volo scomposto, c’era più vita nel fiato corto del libraio con la morte nel sangue che nel suo fiato a perdere nelle corse, quando s’affannava a caccia di vento per non offrire il minimo spiraglio agli spiriti della tempesta, nella speranza di seminare l’angoscia correndo in montagna. Era l’ancoraggio che le mancava, era forse quella carenza che le allungava il respiro nella corsa per alleggerirle il ciarpame mentale, per interrompere il ruminare improduttivo e imparare una postura più lieve.
Sentì che gli occhi le si velavano di lacrime, si sistemò i capelli sulla fronte simulando uno starnuto. Poi a fior di labbra lo baciò in fronte. Un gesto d’istinto, che non aveva previsto, ma che stupì solo lei. Lui le afferrò la mano con il suo imperturbabile sorriso. Vieni a trovarmi in oncologia, ti regalerò il mio libro di racconti.
Forse la memoria di quel bacio, o di quella aggraziata carezza cancellarono ogni schermo e, senza ombra alcuna, lei gli confidò dei suoi racconti e si accordarono per uno scambio di parole scritte.
La trama di quel poco tempo trascorso insieme, fra un respiro che manca e un gesto che sostiene le parole, aveva sciacquato via lo scuro dai pensieri e scavato come un incavo tiepido nella sera, mentre le dita del buio s’allungavano ad ospitare un silenzio profondo in cui pareva che tutto fosse al suo posto, che di nulla lei mancasse e nulla dovesse temere, neppure la morte.
Furono forse la memoria della sua sapienza dolce o l’impronta del suo timido tocco ad aprire la possibilità che il buio potesse farsi trasparente, che spegnersi potesse essere un riaccendersi altrove, e a riportarle alla mente i ochi versi di una poesia di Rilke, quel poeta che lui aveva tanto amato fino a rubare dal giardino dello Chateau de Muzot una rosellina, rimasta negli anni accanto ai suoi libri, aggrappata a una resistenza che sfida le leggi della consunzione spontanea dei vegetali:
Come quello, sull’ultima
collina che gli mostra per una volta ancora
tutta la sua valle, s’arresta, si volge indietro, indugia
così viviamo, in un continuo prender congedo.