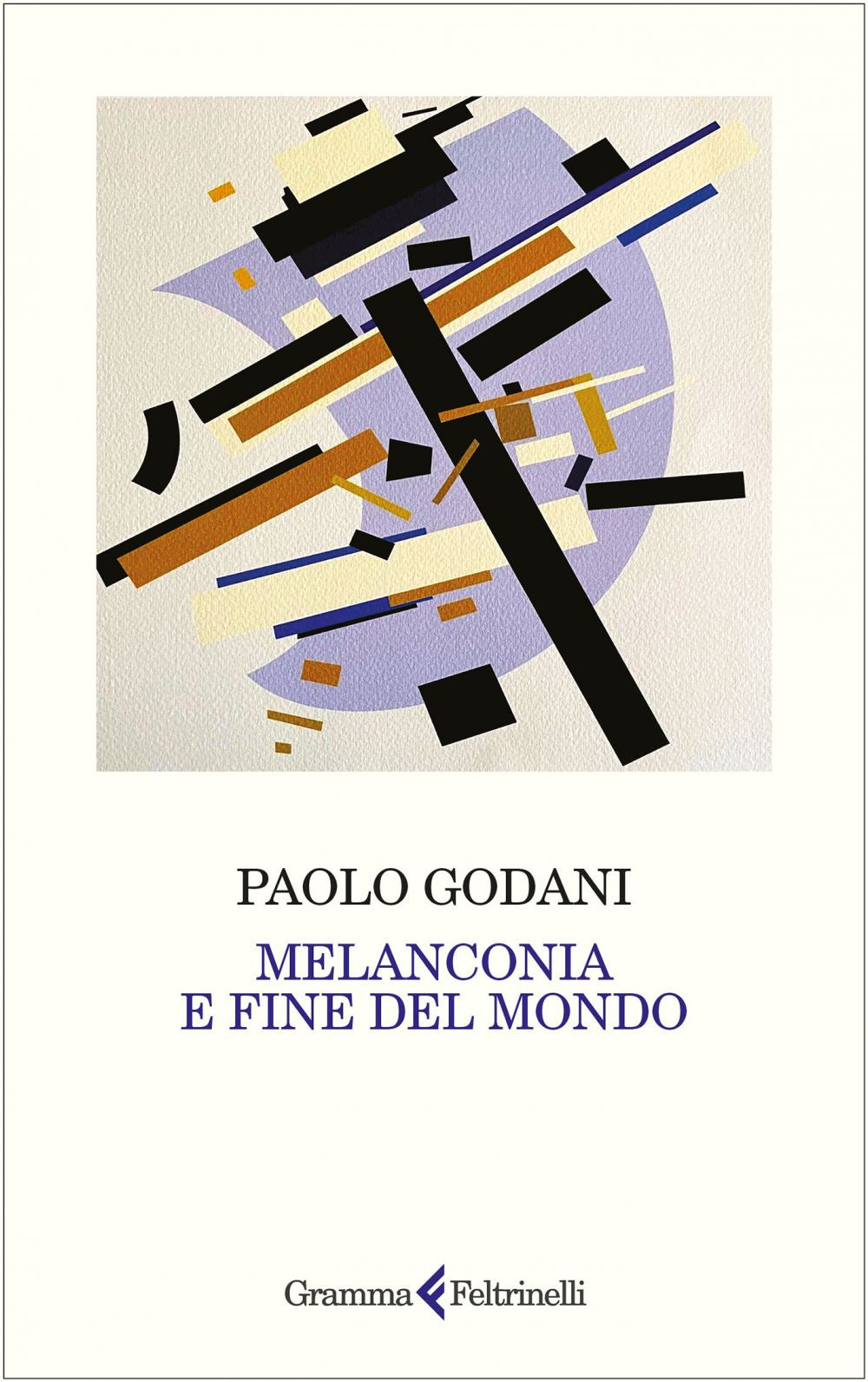
Paolo Godani, Melanconia e fine del mondo, Feltrinelli 2025; Il corpo e il cosmo. Per un’archeologia della persona, Neri Pozza 2021; Sul piacere che manca. Etica del desiderio e spirito del capitalismo, DeriveApprodi 2019
Ernesto De Martino, La fine del mondo. Contributo all’analisi delle apocalissi culturali (Einaudi 2029)
Luca Crescenzi, Melanconia occidentale. La montagna magica di Thomas Mann, Carocci 2011
Sigmund Freud, Caducità (edizioni varie contenenti altre opere; pdf scaricabile da siti come https://www.psychiatryonline.it/psicoterapie/caducita-verganglichkeit-1915-traduzione-di-antonello-sciacchitano/)
Robert Musil, L’uomo senza qualità, Einaudi 2014
Alain Ehremberg, La fatica di essere se stessi. Depressione e società, Einaudi 2010
Emanuele Coccia, Metamorfosi, Einaudi 2022, (pp. 196, euro 17)
Jane Bennett, Materia vibrante. Un’ecologia politica delle cose, Timeo 2023
La tesi di fondo Melanconia e fine del mondo di Paolo Godani – il libro attorno al quale si muove questo percorso di lettura – è che esiste “una forma radicale di melanconia (…) caratteristica del solo mondo moderno, se non del solo sec XX (…) connessa al sentimento di una completa perdita del senso del mondo” e che non si tratta di “un fenomeno di natura personale, ma sociale, culturale, storica e persino metafisica”.
La tesi rimanda, per esplicita ammissione dell’autore stesso, all’opera di Ernesto De Martino, in particolare ai suoi ultimi scritti, raccolti in La fine del mondo. Contributo all’analisi delle apocalissi culturali: “catastrofi interiori di cui poco o nulla si sa”, ma che sono all’origine di quelle che investono la collettività e non possono essere sottaciute, minimizzate, rimosse. Come la paura della bomba atomica negli anni ’50-60, testimoniata anche dalla letteratura (come documentato nel recente L’Italia e la bomba: letteratura nell’era nucleare di Maria Anna Mariani, Il Mulino 2025). Una paura che era sembrata appartenere al passato e invece – fa notare Godani – “è tornata all’ordine del giorno in Occidente, e proprio nel momento in cui sembravamo iniziare a prendere atto della catastrofe ecologica”.
De Martino andava però oltre le cause contingenti del malessere diffuso, parlandone come di una “caratteristica dell’Occidente moderno”, una “melanconia profonda e senza via d’uscita che caratterizza la cultura contemporanea” e – secondo Godani – trova i suoi presupposti fondamentali nel “senso di finitudine di tutte le cose e [in] una certa percezione del corpo”.
Ed ecco allora un secondo possibile richiamo: il libro nel quale Luca Crescenzi (in queste note lo scorso 10 ottobre) ha analizzato La montagna magica di Thomas Mann, vero e proprio monumento – come il titolo sottolinea – della Melanconia occidentale. Ma non solo, proponendosi anche come esempio della possibilità di superare questa stessa postura esistenziale: attraverso un lungo e tortuoso percorso qual è quello vissuto da Hans Castorp nel sanatorio di Davos, ma possibile anche – secondo Godani – intraprendendo un complesso percorso di riflessione sulla visione del mondo oggi dominante, inevitabilmente introiettata e in realtà radicata in alcuni decisivi snodi della filosofia occidentale.
Occorre infatti distinguere tra diversi tipi di melanconia – l’uso del termine al posto di quello più usuale di malinconia vuole sottolineare (come già il melancolia di Crescenzi) la dimensione non puramente psicologica e individuale di questo modo di sentire –: la melanconia che insorge nell’adolescente, portato a credere che “la vita non ha senso” ma la cui “spaesata solitudine incontra [poi] l’esempio di un altro modo di vivere” e si lascia alle spalle quella visione negativa, è diversa dalla melanconia di “chi [vi] si stabilisce durevolmente” e contesta “ogni fede che si presenti come antidoto all’insensatezza” e “contro tutti coloro che ricoprono di un labile velo di illusioni l’innegabile negatività del reale”. Una posizione, questa, che trova una “versione maniacale” nel compiacersi “di presentare il reale nella maniera più cruda”, per cui “la vita non (sarebbe) che sangue e merda”: una “forma morbosa di melanconia” che si manifesta “non di rado nel campo dell’arte”.
Ma “può forse darsi qualcosa come un rovescio della melanconia (…) un altro suo volto, meno malevolo”, che può guadagnare chi aderisce a una nuova visione delle cose, considerandole “non come prodotti del nostro desiderio di dare un senso a ciò che non lo possiede”. Il “melanconico risanato (e non convertito!)” diviene “puro occhio del mondo”, capace di contemplare le cose, e perfino sé stesso, come aspetti di un Tutto, come parti di un “ordinamento cosmico”. Capace, nella sostanza di recuperare – come lo stesso Godani ha illustrato in un altro suo libro, Il corpo e il cosmo – una “consuetudine millenaria” che la modernità ha smarrito: “quella di osservare la natura nelle sue manifestazioni infinitamente variate e di considerarci come una tra esse”. Si tratterebbe quindi di riguadagnare “una postura che assegna al pensiero il compito di rivolgersi al tutto prima che alla parte, al mondo prima che all’io, alla sostanza prima che al soggetto”, abbandonando l’inveterata abitudine di chi “osserva la natura delle cose come se fosse una sua pertinenza”. (Un cambiamento che, nel campo della scrittura, può manifestarsi come privilegiamento della descrizione rispetto alla narrazione).
Un chiarimento è necessario, prima di procedere, per evitare equivoci come quello in cui è caduto niente meno che Freud e che rischiano di compromettere la possibilità di superare visioni riduttive e fuorvianti del corpo e della psiche, della salute e della malattia.
Il testo di riferimento è a questo proposito Caducità, un breve saggio del 1915 nel quale il fondatore della psicanalisi contesta argomentatamente (la bellezza resta tale anche se è transitoria) la melanconia del poeta (Rilke, pare) che lo accompagna in una passeggiata nel verde della montagna, ma secondo Godani non sa vedere che “per il melanconico, un oggetto nuovo – qual è quello su cui secondo Freud si dovrebbe trasferire la libido superando l’attaccamento all’oggetto scomparso – non è meno perduto di un oggetto perduto”. Perché “la melanconia (ha) un suo proprio correlato metafisico nella percezione del carattere essenzialmente effimero di ogni cosa, nella percezione che qualsiasi cosa esistente esista una volta soltanto, per sprofondare poi nel nulla, e dunque in verità sia già, fin dall’inizio e nella sua stessa essenza, nulla”. Sicché “l’oggetto perduto del melanconico è il mondo in quanto tale”: “la melanconia è precisamente questa sensibilità alla caducità delle cose come tali”, ha un proprio irriducibile statuto e non può quindi essere assimilata al lutto, che si appunta invece sulla perdita di un oggetto determinato – cosa, persona, idea o progetto che sia. Ma non solo: a differenza del lutto, o più accentuatamente di quello, la melanconia porta con sé il senso di colpa “per il fatto di non essere riuscit(i) a salvare il mondo dal suo cadere nel niente”. Una condizione indagata a fondo da De Martino, per il quale il melanconico porta la colpa di non saper più attribuire valori alle cose e agli altri, e descritta da Sartre nel suo romanzo più famoso, La nausea – che in un primo tempo doveva non a caso intitolarsi Melancholia –, il cui protagonista non sa più “cogliere nelle cose stesse che il fatto della loro esistenza, il loro esserci puro e semplice, un esserci che, privato delle sue qualità e dei suoi attributi finisce per non distinguersi dal nulla”.
È a questo punto che Godani ci invita a un passo decisivo: riconoscere che proprio chi, come De Martino e Sartre, ha denunciato il rischio che gli uomini corrono di vedere cadere il senso – del mondo, della vita – ed essere travolti da questa caduta nel baratro della melanconia, di fatto mette in conto la possibilità di darlo, un senso, ossia “presuppone ancora, alla sua radice, che la vita e il mondo, lasciati a loro stessi, siano completamente sprovvisti di quel senso”. Perché? Perché in questi pensatori resta viva e operante la concezione “umanistica” che assegna all’uomo “il compito di giustificare l’esistenza”, in questo modo illudendolo di poter contare su “una sorta di antidoto non solo all’umor nero, ma in generale al pessimismo esistenziale, storico e cosmico”.
Pessimismo che, si badi, può “dar luogo a due posture differenti: quella reazionaria, propria di chi non sa elaborare il lutto della perdita dei vecchi valori” e prender atto della “nullità del mondo”, e quella invece progressiva, attiva, disincantata di chi vede in questo nulla la possibilità di una costruzione finalmente autonoma” o, ancora più sostanzialmente, di “(ammettere) la realtà del divenire come unica realtà, e di (vietarsi) ogni sorta di via traversa per giungere a mondi dietro i mondi e a false divinità”.
Ma prima di sfociare in una di queste due posizioni antitetiche, la visione nichilista si manifesta in una percezione del corpo come zavorra, “sorta di residuo inutile”, “abietto e disgustoso” e, oltre tutto, inaffidabile: “un luogo nel quale qualunque cosa può accadere in ogni momento, nel quale ogni cosa che accade è sempre come una sorta di conseguenze senza premesse”, fulcro di un’insensatezza minacciosa, quella stessa che costituisce il carattere precipuo nella depressione, interpretata – e curata – come una deficit da risolvere, una malattia da combattere entro la dimensione individuale, misconoscendo quella sociale, già messa in luce, ancora una volta, da De Martino, che nel “crollo esistenziale” sapeva individuare il nesso con una “tristezza socialmente diffusa” che inibisce l’azione, tanto più quella politica. Un nesso che Alain Ehremberg, nel suo La fatica di essere se stessi, ha sintetizzato nell’“idea che la depressione contemporanea (sia) una reazione di fronte allo stress imposto dalla competizione neoliberale”, e che lo stesso Godani ha altrove analogamente ravvisato – nel suo Sul piacere che manca – in “una società nella quale tende a scomparire ogni forma di vita che non sia volta alla riproduzione della macchina capitalistica” e si verifica la “prevalenza in ogni campo della volontà, dell’appropriazione”. Per questo, si può affermare che “l’homo melanconicus dell’età contemporanea è figlio legittimo dell’homo oeconomicus”.
Il sovvertimento critico di idee ormai acquisite, dopo l’umanesimo non risparmia Marx, a quello assimilato proprio perché nella sostanza succube della concezione di cui l’homo oeconomicus è parte: l’undicesima tesi su Feuerbach – “I filosofi hanno solo diversamente interpretato il mondo; si tratta ora di trasformarlo” – si allinea di fatto con un’idea di prassi intesa come frutto della volontà di dominio dell’uomo sulla natura, della sua pretesa di appartarsi dalla natura come non ne fosse parte o vi occupasse comunque un posto privilegiato e non assimilabile a quello occupato dal resto dell’esistente. Ma questa compromissione è generalmente sfuggita, offuscata dall’esortazione rivoluzionaria che pure la tesi contiene: “Il fraintendimento che presiede all’undicesima tesi su Feuerbach – commenta Godani – ha sviato a lungo il pensiero radicale. (…) la prospettiva marxiana non fa che prender posto in quella struttura melanconica che (si è imposta) nella cultura moderna”, così da giustificare l’affermazione di Foucault, secondo il quale “il marxismo non è stato che una piega dell’episteme moderna”, una variante del modo in cui il sapere e il pensiero si sono strutturati in questa epoca storica. “Per Marx come per Sartre, Heidegger, De Martino e innumeri altri – prosegue Godani –, l’essere umano ha la peculiare caratteristica di trasformare la natura, di farne qualcosa per sé stesso. Feuerbach, di contro, (riafferma), a fronte di questa antropologia umanistica erede della dottrina religiosa della creazione, l’idea che l’uomo altro non sia se non una parte della natura”.
Di qui il passaggio decisivo, l’approdo cui tutto il discorso puntava: “il compito di un’umanità libera consiste nel produrre una nuova forma di vita collettiva fondata sulla contemplazione e sulla conoscenza della natura”.
E non vale evocare, come origine della necessità di una prassi trasformatrice e appropriatrice della natura, la scarsità – la penuria, diceva Sartre nella Critica della ragione dialettica – delle risorse indispensabili all’uomo: “nel pensiero dell’età classica la scarsità di certe risorse non era dovuta alla condizione dell’uomo nel contesto di una natura avversa e di una società di nemici, ma solo al gioco immaginario dei desideri”, e nel mondo contemporaneo occorre riconoscere – sulle orme dell’antropologo Marshall Sahlins – che è “il sistema industriale di mercato (a istituire) la scarsità in maniera completamente nuova e a un livello mai sfiorato prima”.
La prospettiva di una società stazionaria – così come la intende Serge Latouche, sembrerebbe in qualche modo suggerire il testo: una società depuratasi attraverso una fase di decrescita sino a rendersi capace di resistere alla logica del produttivismo riscattandosi dall’ideologia del Progresso – trova del resto un correlativo essenziale nel processo che ha portato al superamento della “forma di vita comune che ha nutrito il marxismo”. La “solidarietà di classe, cioè la comunanza nel lavoro in fabbrica”, infatti, rappresenta ormai un “terreno [che] non è più il nostro. Il lavoro non si presenta più come il germe attuale di un mondo comune a venire” e “tende a diventare residuale tanto nella vita di ognuno quanto nella produzione del valore”, per cui “il compito attuale (…) è di dare consistenza collettiva, ai margini o negli interstizi della società che ci attraversa e ci circonda, a modi di essere, di abitare, di agire che esprimano una vita e un mondo comuni eterogenei rispetto a quelli che dominano nelle società capitaliste”.
Ma in che cosa si rapprende questa eterogeneità, viene da chiedersi: che cosa può segnare una reale alternativa alla società fondata sul principio che “non c’è alternativa”?
In primo luogo “nel separare progresso tecnologico e progresso sociale”, nel non confonderli né nel fare del primo la condizione del secondo: “al miglioramento delle condizioni economiche di coloro che lavorano – sosteneva Raniero Panzieri, testimone critico della società del benessere – corrisponde immancabilmente un peggioramento delle loro condizioni sociali”. Non economiche: sociali, delle quali è parte essenziale il “senso di impotenza” derivante dalla “mancanza di possibilità di decidere circa il modo di condurre la propria esistenza”, con quel che ne segue: perdita di stima di sé, insoddisfazione cronica, depressione.
Posta questa condizione preliminare, e riconosciuto, in secondo luogo, che “i bisogni materiali dell’uomo sono circoscritti e limitati e che dunque possono essere soddisfatti anche con mezzi limitati”, si può intravedere una prospettiva a prima vista extrapolitica, il cui riferimento obbligato è un romanziere, come Godani aveva già segnalato nel precedente Il corpo e il cosmo: Robert Musil, che partendo dalla convinzione che “il progresso sarebbe una cosa molto apprezzabile, purché avesse una fine”, tratteggia nella seconda parte dell’Uomo senza qualità una razionalità “non più unilateralmente sottomessa alla sua funzione pragmatica e utilitaria” ma autonomamente capace di concepire la “prospettiva di una trasformazione del mondo realizzata attraverso la sospensione dell’agire” e dunque la possibilità “di capovolgere l’intenzionalità che va dal soggetto al mondo, per fare in modo che sia il mondo stesso a manifestarsi come tale agli occhi di un soggetto estatico”. Così come avviene nelle nature morte di Cezanne, e di Morandi si potrebbe aggiungere, che – per usare parole dello stesso Musil – “dipingono la vita al sesto giorno della creazione; quando Dio e il mondo erano ancora soli, senza l’uomo”. Le nature morte, appunto, sono l’esempio che permette di dare un’idea non astratta dell’atteggiamento estatico di cui si ragiona: in esse infatti i nostri sguardi, liberati all’obbligo o dalla pretesa di assegnare valori a quanto ci circonda, “ritrovano le cose nella loro impassibile necessità, nella loro fermezza e solidità, nella loro equa perfezione” (la loro equa perfezione: Godani, detto per inciso, dispone anche di una scrittura efficace, suggestiva). Più delle mele di Cezanne sono le bottiglie di Morandi a venirci alla mente: quella che noi chiamiamo la natura morta si dice stilleven in olandese, Stilleben in tedesco, still life in inglese, espressioni che concordano nel rilevare la staticità, la sospensione della vita più che la morte e rendono così evidente che la natura morta “non è solo un genere pittorico particolare, ma è soprattutto stile, cioè un modo di vedere e di raffigurare la realtà, un modo che immobilizza le cose non tanto allo scopo di raffigurarsele, quanto per sottrarle al ruolo che spetterebbe loro in una narrazione storica”, ossia calata nel tempo, anziché in una descrizione che al tempo le sottragga, per un momento sospendendone il fluire anche nell’osservatore.
In gioco è insomma la possibilità di “sottrarre [uomini e cose] al principio antropocentrico, in base al quale le cose hanno valore e significato solo in quanto si presentano come mezzi a disposizione dell’uomo loro signore (…) assumendo almeno implicitamente le esigenze di un naturalismo immanentista”, come si può constatare in Caravaggio e Vermeer, Bruno e Spinoza, ma anche nella Virginia Woolf di Gita al faro, là dove avverte chegli “estatici momenti d’essere non devono in alcun modo separarsi dal mondo comune delle cose naturali” e gli stessi esseri umani devono diventare “parte della natura delle cose”.
E qui rientra in campo la figura del melanconico, perché è proprio lui, tendenzialmente contemplativo, a dar prova della “possibilità di un modo di vivere alternativo all’attivismo borghese dominante, al punto da contribuire alla prefigurazione di una società estatica”: questa l’espressione usata da Musil per definire la sua utopia, come ogni vera utopia connotata da valenze critiche e dunque di significati politici, per la verità ignorati “in ragione di un disincantato realismo o di un pregiudizio storicista e progressista”, mentre – tiene a sottolineare Godani – “l’apparente fantasticheria mistica della società estatica non è che il principio, forse l’unico possibile, di una forma di vita collettiva non governata dalla logica del capitalismo”. Anche se – avverte, come a prevenire ovvie riserve – “non ha senso immaginare un individuo e una società puramente appetitivi [portatori della logica dominante, appropriativa e strumentale] (…) né ha senso prospettare un essere umano e una società puramente contemplativi”, ma il fatto è che “la formazione sociale dominante prevede la tendenziale sparizione di ogni istanza non-appetitiva, in favore della ‘formazione’ di un buon homo oeconomicus liberato da ogni aspirazione contemplativa. È per questo che l’idea di una società estatica ha un’effettiva portata conflittuale”, anche se quella che può ispirare è “una lotta paradossale, essendo condotta in nome di un principio, quello non-appetitivo, che ricusa la struggle for life”. Paradossale eppure ben ferma nel definire i principi che la orientano: “il privilegio della contemplazione sull’azione”, “il rifiuto dell’antropocentrismo” e, non ultimo, “un panteismo in cui tutte le cose sono situate su un medesimo piano di univocità o di immanenza”, una concezione che rimanda quindi a culture del passato – come si diceva, illustrate dallo stesso Godani in Il corpo e il cosmo – o di popoli estranei alla tradizione occidentale, come quelli studiati per esempio da Philippe Descola (che della sua opera principale, Oltre natura e cultura ha offerto una sintesi in Un’ecologia delle relazioni. L’uomo e il suo ambiente, in queste note il 9 gennaio 2022). Ma nella stessa cultura occidentale si possono oggi rintracciare discorsi che vanno nello stesso senso, a partire dall’elaborazione filosofica di Emanuele Coccia (soprattutto in Metamorfosi. Siamo un’unica, sola vita, in queste note lo scorso 5 settembre) per arrivare alle riflessioni di Federico Luisetti in Essere pietra. Ecologia di un mondo minerale (in queste note il 21 giugno 2024) e a quelle, diversamente argomentate, di Jane Bennet, autrice di un saggio – Un’ecologia politica delle cose, in queste note lo scorso 26 settembre – nel quale si prospetta il superamento della barriera tra organico e inorganico, tra esseri viventi e inanimati.
Il cammino che ha portato il vissuto individuale della melanconia alla dimensione collettiva e alla prospettiva politica da essa aperta non deve comunque essere immaginato come un “cammino vittorioso” o una “conquista intellettuale”. La melanconia, insomma, non è in ogni caso riducibile a un residuo di cui disfarsi, neanche da parte di chi ne abbia compreso davvero la natura e le potenzialità: “può capitare che il melanconico abbia almeno una volta l’impressione non certo che le cose possano sistemarsi, ma che in fondo siano già da sempre al posto che spetta loro” e che dunque “il proprio malessere non derivi se non da un malinteso”, non sia quindi che una “turbolenza provocata dalla nostra inutile agitazione”; il melanconico “può sentire questa possibilità, può persino affidarsi a essa (…) per un breve momento può sperare che quell’impressione duri a lungo, ma immancabilmente ricade nel suo stato di prostrazione. L’unica chance che gli si presenta risiede nella ripetizione, nella riappropriazione più o meno forzata di quell’impressione dai contorni incerti”, nel cercare di “convincersi che il mondo degli altri non è necessariamente una farsa”, senza dimenticare mai, però, che “la liberazione dal dolore non è in alcun caso il risultato di un’impresa, di un’attività o di una pratica, ma è l’effetto di un’osservazione, [perché] il rovescio della melanconia si conquista solo nel momento in cui si iniziano a vedere le cose diversamente (…) [e] noi stessi come cosa tra le cose”, smettendo di “intervenire sugli eventi nella speranza di mutarne il corso globale e (…) di considerare l’ordine del mondo come se fosse un nostro prodotto”.
Lo diceva Spinoza: “Il rovescio della tristezza non è la gioia”, entrambe passioni dipendenti da cause esterne: è imparare a “conoscere le cose così come sono, a essere in sintonia con noi stessi e con il mondo che ci circonda” attraverso la “percezione della necessità di tutte le cose”. Un apprendimento che – diceva ancora il filosofo olandese – solo “un’assidua meditazione” può produrre. O, altrimenti detto, solo in una vita oziosa si può raggiungere, quella vita consapevole del fatto che il piacere di essere vivi è l’unico piacere vero, alla portata di chiunque, e perciò condanna sé stesso all’infelicità chi passa i suoi giorni inseguendone altri, sull’onda della bramosia o dell’ambizione. Senonché, ci ha spiegato lo stesso Godani, è proprio questo fondamentale piacere il piacere che manca…
In conclusione, la melanconia, occorre assumerlo come un dato acquisito, è il “fondo nascosto della nostra cultura umanistica” ed è proprio contro di esso che “il melanconico si ribella”, non si adegua, con il rischio di finire vittima della disperazione e delle derive reazionarie del nichilismo. Ma questa stessa postura può rovesciarsi: la percezione della generale mancanza di significato e il sentimento della caducità possono aprirsi alla percezione della “eguale consistenza di tutte le cose”, l’inibizione all’azione propria del melanconico può tradursi in “passione per la contemplazione”. Ma non solo: un altro aspetto della melanconia, l’assenza di desiderio, che appare un fenomeno che investe l’intera società – stando ad analisi come quelle di Massimo Recalcati (Ritratti del desiderio, Cortina 2018) o, ultimamente, di David Le Breton (Scomparsa del desiderio, Mimesis 2025) –, può riscattarsi nell’“estasi di vedere e considerare l’ordine del mondo, l’intreccio dei suo esseri”, e “lo sguardo vuoto, senza preferenze, non è che la condizione di possibilità di questa visione”.

Lungi dal risolversi nell’indicazione di una via tutta individuale e rinunciataria, la prospettiva delineata da Godani ribadisce che il “melanconico risanato” può rappresentare il soggetto capace di intravedere e promuovere un rinnovamento all’altezza dei problemi che viviamo, cioè “all’altezza del senso della fine che caratterizza il mondo contemporaneo”. Sempre che prenda “definitivo congedo” da “quella “melanconia di sinistra” che altri – come Enzo Traverso, in queste note il 22 gennaio 2017 – hanno scandagliato individuandovi una “tradizione nascosta” più che un’incapacità di elaborare il lutto della sconfitta storica maturata a partire dagli anni ’80: una dimensione insita in quella che – tenacemente – continuiamo a chiamare cultura di sinistra, spesso dimentica dell’ironico richiamo di Foucault (“non crediate che occorra essere tristi per essere militanti”).
Anche a questo riguardo, leggiamo alla fine di questo saggio, denso di rimandi e coraggioso negli esiti, “è necessaria un’educazione metafisica, percettiva, sentimentale. (…) Una nuova sensibilità per le cose del mondo, capace di ridare serenità a uno sguardo, il nostro, da troppo tempo affiso alla catastrofe”.
