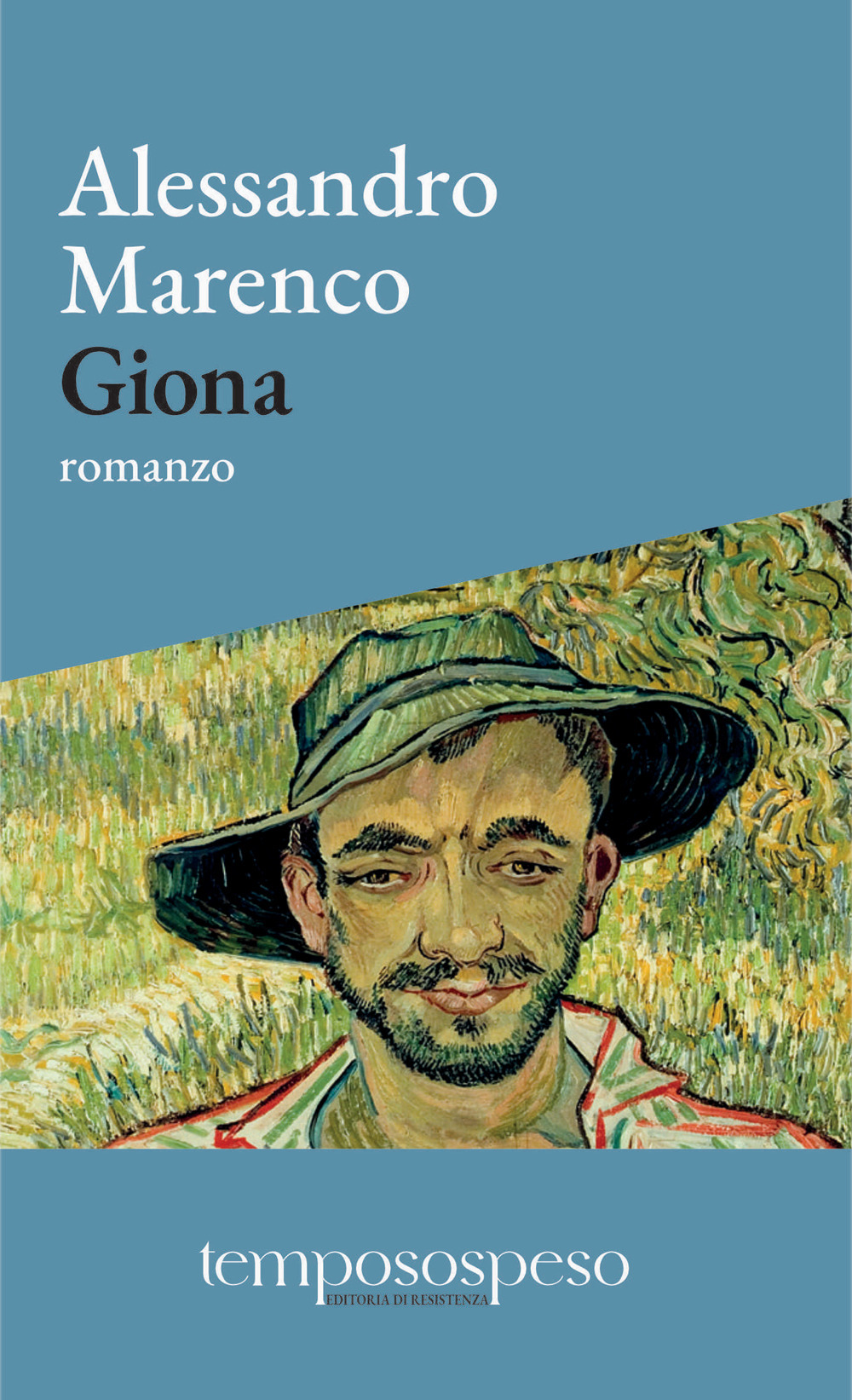
Alessandro Marenco, Giona, Temposospeso 2025 (pp. 245+XIII, euro 18)
La Liguria del XVIII secolo, i boschi dell’entroterra; un narratore che, ormai giunto all’ultima stagione della vita, mette per iscritto la storia del fratello maggiore la cui vita è stata segnata da un cambiamento repentino e irreversibile. Sin dalla prima pagina un’eco familiare si fa sentire, non fosse che i due ragazzi non sono rampolli di una famiglia aristocratica ma contadini, “padroni, piccoli, miseri, sì, ma padroni della terra e del bosco” da cui ricavano di che vivere.
Ma a segnare una differenza decisiva dal racconto cui è stato inevitabile pensare è soprattutto la sorte di Giona, che non scompare in alto, fra gli alberi, come Cosimo Piovasco di Rondò, ma precipita in una grotta restandovi prigioniero, “isolato per tutto, fuorché per la voce”. La sua monotona esistenza prenderà tuttavia una strada imprevedibile, suggerendogli riflessioni filosofiche (“ognuno è prigioniero in qualche modo, in questa vita”) e facendone un confidente consultato non solo dai compaesani ma anche da molti forestieri, al punto da conferirgli a un certo punto un ruolo che, si direbbe, sembra ironicamente avvicinarlo a uno psicanalista ante litteram: “chi viene a dirti le cose, e magari ti chiede consigli, non vuole consigli. Vuole solo che lo stai a sentire e che gli dai ragione. E io così mi regolo: taccio e gli do ragione”.
Quella che leggeremo, comunque, non sarà che marginalmente la sua storia, per forza di cose povera di eventi e alla lunga tale da provocare una sorta di assuefazione in chi pure non l’abbandona e continua a fargli visita e a nutrirlo, ma quella avventurosa del fratello minore, Giosuè. Una storia che si sviluppa secondo gli stilemi del romanzo di formazione, a partire dall’incontro con la cultura e i libri, fino allora considerati da un “uomo dei boschi” come lui niente più che “oggetti per i parroci o i signori”, ed è invece proprio un libro che finirà con lo scrivere – quello che appunto stiamo leggendo –, avvalendosi di un linguaggio, avverte preliminarmente, molto diverso da quello d’origine (“mio padre, mio fratello, io stesso, non eravamo in grado di parlare come in questa storia ho raccontato”). Ma non è solo della scrittura che Giosuè si impadronisce: è la cultura ad aprirglisi, la “scoperta (…) che c’era qualcosa dentro di me che riponeva da qualche parte quello che mi veniva insegnato (…) più ne sapevo, più avevo voglia di saperne”. E non sono solo nozioni quelle che il giovane acquisisce, ma anche la capacità di elaborare via via il continuo, inaggirabile confronto tra il suo destino e quello del fratello, sino a giungere a chiedersi “se sia meglio viver soli e liberi, ma reclusi, oppure condividere vita e ardori come tutti, faticare per trovare la strada e non avere scuse”. Va anche al di là del dato biografico, comunque, la riflessione di Giosuè: le riproduzioni botaniche di un erbario lo affascinano, ma al tempo stesso lo mettono in sospetto, perché nei disegni “non è rappresentata una pianta sradicata”, bensì “tutto il ciclo di vita di quella pianta, pietrificato in un unico atto come mai in natura sarebbe possibile vederlo. E questa era una piccola delusione. (…) Quel libro parlava della condizione delle piante, ma non erano rappresentate nell’atto e nel momento, quanto in un eterno tempo presente che li comprendeva tutti”: la concretezza, il rispetto della realtà tangibile, il primato della verosimiglianza, tratti propri della sua cultura d’origine, non hanno abbandonato il seminarista studioso, che dopo la quieta della biblioteca si troverà a vivere il disordine violento imposto dalle armi e a comprendere, per esperienza personale, che “la guerra è fatta per i soldati”, costretti a una vita grama in tempo di pace ma “nel tempo della battaglia (…) finalmente liberi di tornare belluini”. Perché “questo era ed è la guerra. Condurre gli uomini oltre loro stessi, portarli a compiere atti che da loro stessi mai e poi mai si direbbero capaci di compiere”. Gli uomini, si badi: diverso il modo di stare al mondo delle donne – constata Giosuè quando si imbatte in una comunità femminile del tutto autosufficiente –, che non bevono, non giocano d’azzardo e non si azzuffano per un nonnulla. E con la guerra non hanno a che fare, lontane dalla sua follia perché fanno di tutto per non ferire e non dare dolore, sapendo “chiedere scusa, dire grazie e lavorare senza astio”.
Non sarà questo l’unico incontro a risultare illuminante per il protagonista: il prigioniero “negro”, vittima del colonialismo, che deve scortare in un lungo viaggio, gli trasmetterà il nesso essenziale fra la cultura e la politica, il sapere e la vita civile.
Sarà ricco di tutte queste esperienze, Giosuè, quando tornerà a casa e, convinto ormai che “per vivere, a ognuno tocca avere una congettura che generi speranza, giacché non siamo muli alla macina, ma uomini”, troverà il modo di liberare il fratello. E qui, quell’eco che avevamo percepita all’inizio – e che siamo tornati a sentire in un fuggevole richiamo ai tempi in cui la luna era tanto vicina alla terra da potervi ogni tanto metter piede – si fa voce esplicita: Giona, proprio quando potrebbe tornare fra i suoi simili, scompare, del tutto questa volta, fuggendo per un anfratto forse scavato via via negli anni del suo forzato soggiorno nella grotta. Nessuno lo rivedrà più né avrà notizia della sua sorte, proprio come quel tale di cui si è sentito: vissuto tutta la vita sugli alberi, al momento di scenderne perché ormai vecchio e malaticcio, aveva preferito aggrapparsi alla fune pendente da una mongolfiera di passaggio e, in questo modo, sparire.

L’omaggio a Italo Calvino non è un vezzo letterario in questo romanzo, non è superficiale ammiccamento ad espedienti di intertestualità fine a sé stessi. È piuttosto il frutto della capacità di rapportarsi originalmente alla lezione dell’autore del Barone rampante.
Lo stesso che, in un’intervista del 1981, offriva una notazione da cui il romanzo di Marenco, con quel sottolineare il superamento da parte del fratello minore del proprio senso di inferiorità, e per certi versi di colpa, nei confronti dell’altro, potrebbe ricevere un ulteriore significato: “Quando scrissi il Barone rampante – confessava Calvino –, tra i due personaggi contrastanti forse credevo d’identificarmi di più col fratello che viveva sugli alberi e che era anche preso, tra l’altro, dalla politica; adesso magari mi trovo più vicino al personaggio che parlava in prima persona”.
