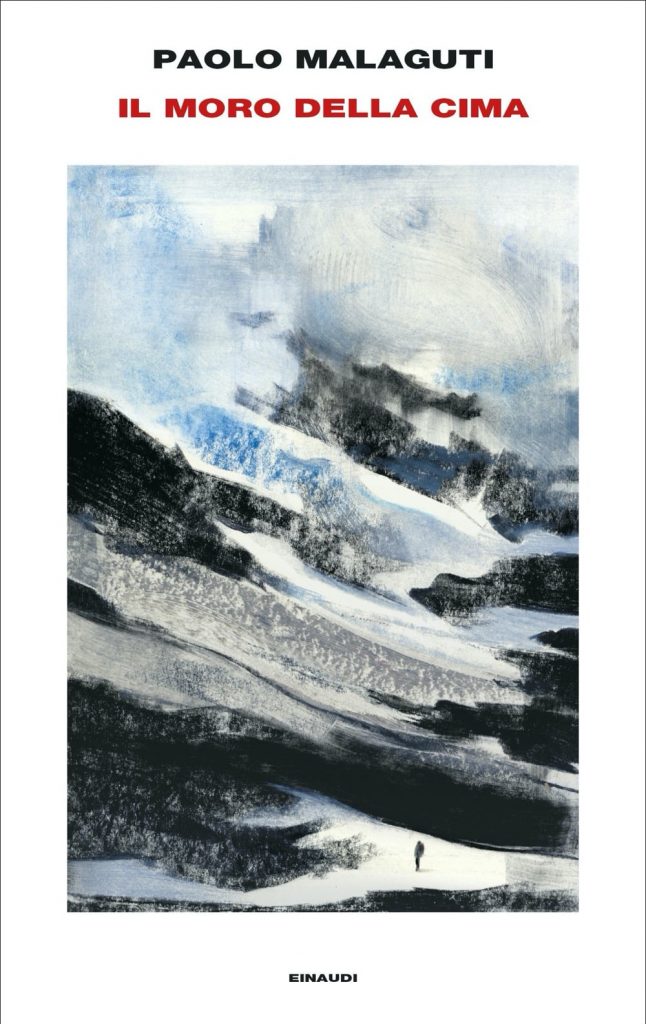
Paolo Malaguti, Il Moro della cima, Einaudi 2022 (pp. 280, euro 19,50)
“Mestieri, tasse, fèmane. E te mori prima di tirare el fià”. Il destino di chi ha lavorato, messo su famiglia e dato allo stato il dovuto, però, concede a volte di tirarlo il fiato, perché “passati gli ottanta non serve essere strolgadori per cogliere i segni e rassegnarsi che, se non la va a giorni, ben che vada la va a mesi”. Eppure, qualcosa di cui stupirsi il vecchio montanaro, ormai vicino alla fine, ce l’ha: “Le rare volte in cui aveva avuto tempo libero a sufficienza per pensare alla morte, il Moro non se l’era immaginata così banale. Con quello che aveva passato, con quanto gli era toccato vedere, mai avrebbe creduto di avere il lusso di crepare in casa”. Men che meno “di andarsene da questo mondo ridendo”.
Il perché di quella risata finale è racchiuso nella storia che leggiamo, un lungo flashback che dall’inizio degli anni ’50, al momento della morte del Moro, ci riporta a settant’anni prima, quando lui non aveva che diciassette anni, immergendoci in ambienti e atmosfere che ricordano Rigoni Stern, quello della Storia di Tönle soprattutto, non a caso citato in esergo. Anche qui sono le storie di chi andava a lavorare “nelle miniere dell’imperatore, lontane oltre la montagna” o quelle di chi è emigrato addirittura in Merica a tener banco nei filò delle lunghe serate in stalla.
Lui però non voleva andare così lontano. Fin da bambino era la montagna, quella alta, ad attirarlo. E c’era andato, a fare il bocia in malga, imparando subito che “Le vache l’è meglio dei omeni”, “bestie mansuete”, che “si facevano i fatti propri (…) senza ciacole, né proteste, né parole al vento”. Ottuse solo per il profano, in realtà curiose e intelligenti, e affettuose, “ognuna però coi suoi tempi, e sempre con un pudore rispettoso degli spazi altrui”. In poche settimane il bambino aveva avuto conferma di ciò che aveva fino allora solo immaginato: “fatica a parte, quello era un bel vivere”. Perché la montagna è il luogo dove lui, Agostino, sa essere felice. Una sensazione, una certezza che ci riporta a quelle del Fausto di Cognetti (La felicità del lupo, in queste note alla fine dello scorso anno).
Gli anni passano, il servizio militare, poi il matrimonio, il primo figlio: basta montagna, Agostino – ormai ribattezzato, come tutti i compaesani, con un soprannome: il Moro – dovrà restare al paese e fare il contadino come i fratelli. Ma non è il suo posto, la sua vita: appena ne ha l’occasione, torna a fare il malgaro. A richiamarlo lassù, però, più della malga e delle vacche è la montagna, che lui esplora senza uno scopo, agli occhi degli altri; per respirare il senso di libertà che ne riceve, agli occhi suoi. Ed è la Grapa, il Monte Grappa, la sua meta preferita. Da bislacco a matto addirittura diventa secondo gli altri, giù al paese, quando decide di fare la guida per gli escursionisti amanti della montagna. Guida e narratore che sa intrattenere i suoi clienti: “Un po’ alla volta capì che la storia più bella, se raccontata male non vale un’ostrega e l’aneddoto più insulso, se condito a dovere, rende più delle avventure di Bertoldo”. Da guida passerà poi a guardiano, e gestore, del nuovo rifugio che il Cai di Bassano costruisce sulla cima, lui che sulle prime aveva maledetto quella che “gli pareva un’offesa” alla montagna; una pensata dei “siori” di Bassano, più “caga-alto addirittura dei veneziani”. E di fatto ascolta insofferente i discorsi del giorno dell’inaugurazione, quando tra gli altri “una signora elegante” inneggia all’“era di imperitura pace tra le genti”, di cui il nuovo rifugio doveva essere simbolo. E invece, la guerra imperverserà proprio lì, sul Grappa.

Delle vicende tremende della vita, e della morte, dei soldati è fatta la seconda parte del romanzo, vicende che seguiamo attraverso uno sguardo che non sa rassegnarsi, lo sguardo del Moro, che diventa un personaggio leggendario, sempre lassù, anche in inverno, anche quando i colpi delle artiglierie gli fan giungere il loro “orrendo lamento gutturale, quasi che fossero le montagne stesse a rantolare, ferite a morte dalla valanga di ferro rovente”. La guerra passa, le offese alla montagna no. Dopo gli squarci delle trincee e delle cannonate, arriverà il sacrario e poi il cimitero monumentale, voluto dal duce: “Ora la Grapa semplicemente non c’era più. Avevano fatto quello che nemmeno la guerra era riuscita a fare”. Al di là delle trama, avvincente, e della tenacia del Moro, che commuove, sono i montanari come lui, malgari e contadini di montagna, operai addetti alla costruzione delle strade militari e fanti mandati a morire, i protagonisti di una storia che racconta di un’umanità altra, irriducibile e sconfitta, irripetibile e scomparsa, non diversa da quella dei barcari del Brenta che lo stesso autore ci aveva fatto incontrare nel suo romanzo precedente, Se l’acqua ride (in queste note nel novembre del 2020).
Questo testo compare anche nel sito della nuova libreria Rinascita di Brescia, alle cui attività culturali Carlo Simoni collabora.
