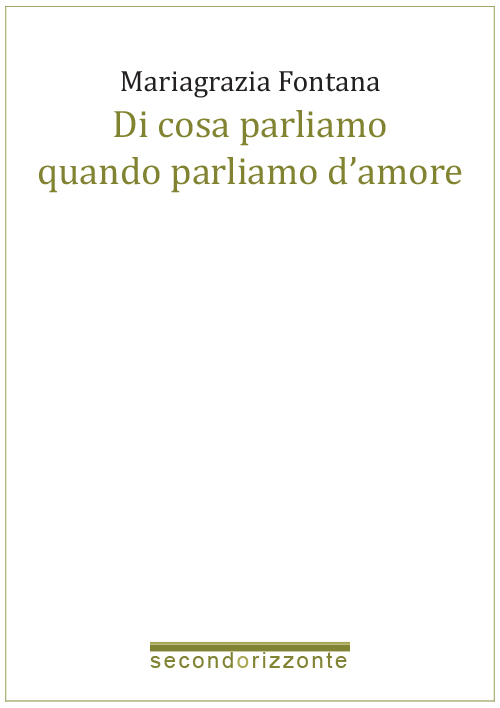
La soluzione alla mia vita mi venne in mente una sera mentre stiravo una camicia. Era semplice ma audace. Mi presentai in soggiorno dove mio marito stava guardano la televisione e dissi: c’è una cosa che volevo dirti da un po’.
Non fece neanche cenno di aver sentito, gli occhi calamitati dallo schermo dove ventidue giocatori si contendevano la palla sudando, dribblando, scartando.
Era così quando giocava l’Inter, la sua squadra del cuore o forse della pancia, perché era nelle sue viscere che tutte quelle scarpette chiodate correvano, poi retrocedevano, poi si passavano la palla, poi fingevano un’azione mettendone in atto in realtà un’altra. I primi anni di matrimonio questo istupidimento mi aveva fatta inorridire. Com’era possibile che un ragazzo intelligente e colto potesse farsi prendere per il naso da quattro calciatori, con tutto quello che succedeva nel mondo?
Sì, sì, ma il tifo è un’altra cosa, è un fatto a sé, tu non lo puoi capire – mi aveva risposto. E infatti io continuavo a non capire, a non spiegarmi tanto affanno, tanta sofferenza per una partita. Negli anni ci avevo anche provato a capire un derby, sia con mio padre che con mio marito, me l’avevano ben spiegata quella storia del fuori gioco, del contropiede e via discorrendo, ma mi restava attaccata per il tempo di una partita e poi, flop, si sgonfiava, così come la mia affezione per quei novanta minuti che mi parevano eterni e terribilmente noiosi.
E’ che il calcio a te non ti strizza le coronarie – mi diceva lui.
Infatti a me lo sport piaceva farlo, più che guardarlo: una volta corse nei campi, ora lunghe camminate lente.
Anche mio padre aveva lo stesso morbo di mio marito: si sedeva sul bordo del divano, mai abbandonato sui cuscini, ma rigido sullo spigolo, la radio accesa, lui in allerta, le pupille dilatate, le gambe pronte allo scatto, come se il goal competesse a lui.
Forse sarà l’espressione fenotipica dell’ipsilon, di quel secondo cromosoma sessuale maschile che si porta appresso il virus del pallone e che agli uomini fa rotolare il buon senso su un campo verde, verso una porta.
Forse il tifo è il loro modo per comunicare l’uno con l’altro, a suon di pacche sulle spalle, battute, scommesse, sfide da niente. Forse il tempo di una partita è ciò che un padre concede a un figlio maschio, una sorta di tregua, di sospensione delle ostilità fra i due galli nel pollaio. Sì, per mio marito l’Inter era un padre che scioglie gli ormeggi, che diluisce lo sguardo dell’imposizione e del controllo fino a scimmiottare amicizia.
Come sempre, dietro le cose semplici, c’è molto di difficile da capire.
Interrompere un derby, rovinargli una partita così importante, che responsabilità! Eppure era quello il momento, allora era affiorata l’urgenza di dire. È che quando le parole vengono su così, senza fatica, senza intenzione, quasi senza controllo non le si può cacciare giù. Erano così limpide quelle parole, che parevano pensate da un’altra, una con le idee ben più chiare delle mie, una che sapeva che cosa volere, una che non aveva paura di niente.
Sentivo che quell’ardire andava cavalcato, come fosse l’onda giusta, quella storica, per cui un surfista si sveglia all’alba da decenni a studiare il ritmo dei flutti: coppie di due, poi di tre, poi la risacca ed ecco la corrente perfetta, rimestata dalla luna crescente che alza quel muro d’acqua e ne fa un tunnel dentro il quale sciare, un piede davanti all’altro, le braccia spalancate, il tronco in leggera torsione, la tavola a volare sulla schiuma, gli occhi stupiti e increduli.
Non ti ho mai amato – gli avrei detto. Lo avrei detto a lui per dirlo anche a me stessa. Non che io non lo sapessi: il corpo, il sangue sapevano tutto. Ogni cellula aveva sempre saputo, sia nucleo che citoplasma, sia mitocondri che ribosomi. Ma dirlo era tutt’altra faccenda. Sono quelle verità che diventano vere solo a voce alta, per merito delle parole, come se solo le parole ne dovessero portare il peso. Mica male l’idea, traslocare la colpa della mancanza d’amore su un congiuntivo o su un condizionale: se fosse… se magari tu o io…
Provai a ripeterle a voce bassa, scandendo le parole ad una ad una, solo per me, per farci l’abitudine: Mario, io non ti ho mai amato. Quella sì che era una frase d’effetto, una dichiarazione secca, ruvida, di quelle che ti rimbombano nelle orecchie fino a gonfiarti i timpani come vele. Nessun preambolo, nessun panegirico, solo la verità, messa sul piatto tale e quale.
Che poi non si è colpevoli se non si ama, almeno l’amore non lo si programma, non ce lo si può imporre. Arriva quando è ora, spesso come uno schiaffo in pieno viso, come un colpo di vento, come un tremore irrefrenabile che cambia la prospettiva.
Io questo lo sapevo bene, così come sapevo che non era quello il sentimento che mi aveva tenuta insieme a mio marito. A lui volevo bene, molto bene. Condividevamo casa, figli, progetti, vacanze in buona armonia. Rari gli screzi e sempre di piccolo cabotaggio.
Perché Mario era un uomo come si deve, uno affidabile, un alpinista coi fiocchi, sincero, posato e, fino a prova contraria, fedele. Insomma un buon marito e un buon padre.
Provavo per lui un sentimento profondo ma tiepido, solido ma troppo liscio per aggrapparcisi.
Non che io fossi capace di abitare solo la superficie, la sicurezza. L’avevo ben sentita quella corrente impetuosa che sradica gli alberi, che demolisce i muri e spazza via le nubi. Ma era tanto, tanto tempo fa: cinquant’anni, forse più. Eppure a pensarci potevo lasciarmi riprendere da quel fremito, da quell’abbandonarsi, da quel conficcarsi i denti nella carne che ricordavo alla perfezione.
Poi Giorgio era partito per la guerra, una di quelle che dovevano durare poco e che non finiscono mai. Non aveva mai risposto alle mie lettere, addirittura si era pensato fosse morto al fronte. E tutto quell’amore era finito nel fosso della mia disperazione ed ero rimasta sola. Avevo aspettato, anno dopo anno, fino alla fine della guerra, sempre scrivendo, sempre sperando in una lettera, o almeno una cartolina. Nulla.
Alla fine era tornato, malconcio ma vivo. Vivo in apparenza, in realtà morto. Quello sguardo brillante e strafottente s’era mutato in occhi attoniti, vuoti. Gli erano state amputate due dita della mano destra per una mina, e quelle dita si erano portate via la sua anima. Vagava per il paese irriconoscibile, alto, ancora più magro, ingobbito. A giorni salutava con un cenno del capo, altri neppure quello, camminava per i campi perso in non si sa quali pensieri, o quali ricordi. Forse un attacco nemico, o un compagno che gli era morto fra le braccia. Nessuno seppe mai.
Poco alla volta ritrovò un lavoro. Lavorava, mangiava, dormiva, soprattutto camminava senza fine. Poi ancora lavorava, mangiava, dormiva e camminava, camminava a vuoto. Non s’era più affiatato con nessuno, neppure con gli amici d’infanzia che ci avevano anche provato a tirarlo fuori casa, ma niente da fare. Con me non ci aveva neanche parlato, come se nulla fosse successo fra noi, come se fossi un fantasma, o un sogno.
Certo, non aveva obblighi ufficiali, non eravamo fidanzati in casa, ma l’amore, quello che spacca le pietre più del sole d’agosto, quello c’era stato eccome. Eppure la guerra o sa Dio cosa era riuscito a frantumarlo.
Dopo anni anche Giorgio s’era sposato con una di un paese vicino. Forse con quella si sarebbe ripreso – s’erano detti gli amici. Invece nulla fiaccava quella malinconia.
Poi di botto, ad una festa di capodanno alla trattoria in piazza, Giorgio mi aveva invitata a ballare. Un valzer di Strauss.
Ballavamo bene che a guardarci era un piacere. Sarà stata la musica, o forse la danza, o il lambrusco ma a me era sembrato di riconoscere in quell’uomo smilzo, prosciugato dalla tristezza, un barlume, il riflesso di quel ragazzo che sapeva accarezzarmi, che mi parlava d’amore come nessuno, che mi stringeva a sé senza farmi respirare.
Era forse il tocco della sua mano robusta sulla vita, che mi avvinghiava, che mi riprendeva decisa senza parlare, senza dichiarare. O forse tutto era successo solo nella mia testa, nei miei desideri.
E invece no, l’avevo sentito sulla pelle proprio come allora.
Poi lo avevo incrociato nella bottega del panettiere e ancora quegli occhi parlanti che sapevano farmi sentire bella. Poi una domenica in chiesa mi aveva sfiorata leggero come per sbaglio, ma le sue dita erano calde, troppo calde per non avere intenzione. Quando Giorgio mi guardava mi ricordavo d’avere un viso, degli occhi, un corpo e dei sentimenti.
L’incanto era durato decenni. Decenni di sguardi, sorrisi appena accennati, qualche mazurca, mano nella mano.
Per tutti Giorgio era rimasto un libro chiuso, ma io, al tocco della sua mano, gli leggevo dentro e le sentivo le sue storie: lui che corre a perdifiato sul pendio e scavalca una staccionata, il suo occhio che punta nel mirino, sua madre che gli scalda il latte a colazione, le sue palpebre che vorrebbero serrarsi e non uccidere, lui che vince una partita di briscola, la sua divisa impigliata nel filo spinato, la mano ferita, il mondo intero che gronda sangue fra mitragliate e bombe. E lui che vorrebbe fuggire, scomparire, dissolversi nel fumo di una cannonata per tornare a casa e cancellare la guerra.
Ai balli sedevamo sempre lontani, ma anche così emanavamo la stessa luce e quel calore che annoda le viscere. Per anni ci eravamo amati così, un amore silenzioso, non detto, non consumato che bruciava la carne, riempiva il cuore e dava senso ai giorni. Nessun cedimento, nessuna infedeltà di giorno. Ma di notte, in sogno, che fragore di tempesta, che fulmini, che tuoni, che albe infuocate l’una nelle braccia dell’altro.
Ora che Giorgio se n’era andato, consumato da una di quelle malattie che non hanno pietà e non concedono speranze, anche i sogni s’erano spenti e lo sguardo non aveva dove posarsi.
Io gli parlavo tutto il giorno nella testa. Certi giorni mi spingevo fino al cimitero in collina per raccontargli di chi s’era sposato, di che se n’era andato all’estero, dei litigi, delle vendette da niente. Ma dovevo stare attenta per non insospettire la moglie, perché la vedova legittima non ero certo io.
È che poco alla volta anche dentro di me la vita si andava ritirando, non ci tenevo più a svegliarmi, lavarmi, cucinare, fare la spesa. Non c’era ragione per infilare un gesto dietro l’altro. Neanche mi sforzavo, andavo avanti per inerzia, giorno dopo giorno. Avevo ricominciato a camminare, così come da giovane, come camminava lui, chilometri e chilometri nei campi, in silenzio, senza neanche pensare, sgranavo passo dopo passo come chicchi di rosario.
Questa sera glielo avrei detto a Mario, perché era giusto, perché Mario se la meritava l’onestà. Non che avessi nulla da confessare, non era mai successo niente e secondo le regole dello Stato e della Chiesa io era pura e innocente come un lenzuolo appena lavato. Ma dentro che peso mi gravava sul cuore, che opacità nell’animo.
Dopo la confessione me ne sarei dovuta andare. Non sapevo dove e in realtà non mi importava affatto.
Ma che cosa ne sarebbe stato di Mario che non sapeva cuocersi neppure un uovo al tegamino? Sarebbe sopravvissuto a tutta quell’onestà? E le pastiglie della pressione chi gliele avrebbe date?
Sììììì, cavolo, finalmente: goal. Dimmi tu che cosa ci voleva. Non potevano mica farlo prima questo goal del cavolo che fra un po’ morivo d’infarto? Questa squadra di merda è fatta così, ti fa penare fino all’ultimo e poi ti consola.
Era balzato in piedi come un ragazzino, le braccia tese, i pugni stretti e un sorriso che pareva superare le orecchie, felice.
È che non posso non tifare per l’Inter, l’Inter è la mia squadra, la squadra dei perdenti. E la squadra e la moglie non si tradiscono – mi disse e quasi danzando mi indirizzò verso la cucina sempre con quel sorriso cristallino stampato in volto.
Moglie, non è mica ora di cena? Non si mangia stasera in questa casa? Mi chiese scherzando, come recitasse su un palcoscenico.
Era proprio un bell’uomo mio marito, un uomo dalla chioma imbiancata, un vecchio giovane che sapeva entusiasmarsi come un bambino. Lo guardavo gioire saltellando e ridevo mentre mi cingeva in un valzer senza musica. L’Inter aveva vinto, si doveva festeggiare.
Amavo quegli occhi limpidi che sapevano cogliere di me anche i cambiamenti molecolari, quel volto aperto, la sua stretta decisa, la sua passione per le cime. Sì, lo amavo, amavo anche lui, quasi a mia insaputa. Lui era la mia bussola nell’uragano, con lui avevo tenuto insieme l’ordito dei giorni.
Come avrei respirato senza di lui? Come avrei potuto svegliarmi, pensare, camminare senza Mario al mio fianco, senza l’Inter che perde spesso e vince di rado?
Magari l’Amore, quello grande e unico esiste solo nei romanzi, magari di amori ce n’è più d’uno. Magari a guardarlo al rovescio, un amore solo pensato non è che un sogno, un desiderio antico, un’onda che si infrange sulla battigia e di cui resta solo la schiuma. E la schiuma, si sa, non scalfisce la meccanica sacra di una vita.
Forse un amore tutto nella testa intorbida lo sguardo, e così, continuando a sognare, finisce che dormi, che t’intontisci e non vedi più quello che hai. Ti disorienti come una ragazzina.
È complicata questa faccenda dell’amore. Anche a provare a ragionarci non ci si capisce niente. A giorni sembra che la matassa si dipani, sembra di avere finalmente afferrato il capo del filo, che i pensieri si rischiarino, poi basta uno sguardo, un giro di valzer, un goal dell’Inter e tutto si capovolge di nuovo.
Lasciai che quest’amore quotidiano si tendesse dentro di me come una molla, che accorciasse le distanze, che capovolgesse inaspettatamente la prospettiva del sentire, che attecchisse.
Sempre danzando e sorridendo Mario mi condusse in cucina, io sollevai lo sguardo e, con la destrezza di un centravanti dell’Inter, lo baciai. Un bacio serio, di quelli da ragazzi: l’Inter aveva proprio vinto.
Poi mi infilai un grembiule e cominciai ad affettare una cipolla, mentre dietro le palpebre un pianto sereno rivendicava i suoi diritti.
