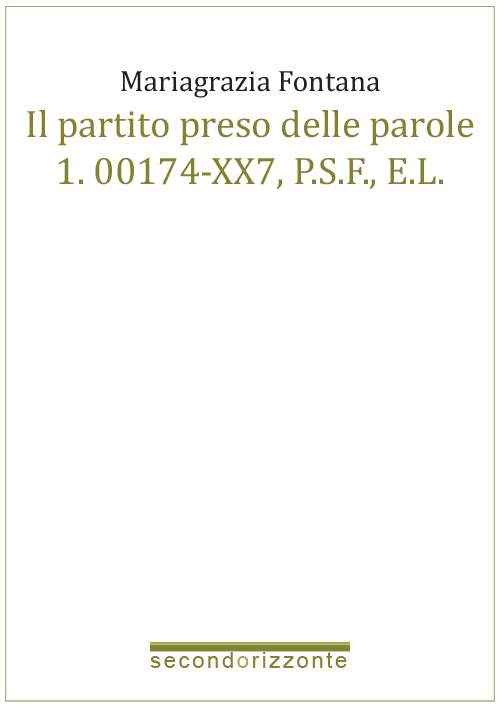
1. 00174-XX7, P.S.F., E.L.
Non entrava in quella casa da mesi, eppure nulla era cambiato: gli stessi mobili da quattro soldi, vecchi e consunti, congelati nella disposizione di sempre. Era sua madre che era fissata con i rinnovamenti. Certe mattine la trovava già sveglia all’alba a spostare poltrone, a ficcare stracci sotto i piedini della credenza per farla scivolare sul pavimento e posizionarla nella parete di fronte, così da fare sembrare la stanza diversa, visto che soldi per comprare mobili nuovi non ce n’erano mai.
Da quando lei era mancata, in quella casa non si muoveva foglia e, ovviamente, neppure mobili.
Di convivere con una badante suo padre non ne voleva sapere, aveva accettato solo l’aiuto di una vicina che, per quattro soldi, s’era offerta di pulire una volta ogni tanto. Non faceva un buon lavoro, una polvere vecchia di anni ricopriva i mille soprammobili che probabilmente lei neanche spostava e un odore di cibo stantio ristagnava nell’aria. Non si poteva pretendere, per quel poco che la pagava.
Suo padre era seduto in cucina, come sempre. Il divano e la poltrona non aveva l’abitudine di usarli, li teneva buoni per chissà quale occasione, in salotto, coperti da un involucro di plastica che ormai aveva quarant’anni ma che non s’era sbrecciato mai, perché nessuno mai s’era seduto su quel divano.
Parenti ne avevano pochi e abitavano lontano, di amici non se ne parlava proprio. Magari qualche vicino, gente di casa per cui una sedia in cucina e la tazzina del caffè di tutti i giorni erano perfette.
Era vecchio e trasandato, le sopracciglia lunghe e arricciate, gli occhi cisposi incapsulati in palpebre rugose che l’acqua non sfiorava da tempo. La fronte sembrava un campo arato di fresco e le guance flosce e cascanti con quelle due parentesi ai lati della bocca gli disegnavano un’espressione vacua, lontana da tutto, perfino dalla disperazione, assente.
Come te la cavi pa’? gli chiese accendendo la luce e appoggiandogli una mano sulla spalla per scuoterlo dal torpore, mentre sentiva che non riusciva proprio ad amarlo quel vecchio perso in non si sa quale altrove.
La bocca del padre si contorse come se non riuscisse a rispondere, come fosse imprigionato in un’eco interiore. Forse era diventato ancora più sordo, forse la sua testa vagava in un altro mondo, un mondo in cui sua moglie ancora si occupava di lui e lui era un operaio che timbrava il cartellino, non un vecchio scalcagnato, prostrato dalla rassegnazione e da quell’agonia diluita.
Faticava a vederlo così e forse per questo non si curava di lui. Meno lo vedeva e meno ci pensava, a lui e a quella storia balorda di invecchiare e poi morire. Che tanto ognuno ha il suo destino e le sue grane. E a Franco le grane non mancavano di certo.
Anche la sua stanza da ragazzo era rimasta immutata, tale e quale: mobili al risparmio, ACDC e Metallica alle pareti, i libri di scuola. Del suo fucile nessuna traccia.
L’ho messo insieme ai miei nell’armadio chiuso a chiave, con tutti i negri e i disgraziati che girano…
Suo padre di fucili ne aveva ben tre, tutti comprati con lo sconto alla fabbrica Beretta dove aveva lavorato, come la maggior parte degli uomini della valle che non volevano più fare i pastori o i contadini. E lui di fucili se ne intendeva.
Quando Franco era un ragazzino gliene aveva regalato uno leggero, con il calcio inciso a mano. In Val Trompia c’erano donne che praticavano ancora l’arte della bulinatura scolpendo scene di caccia sui calci delle armi. Il suo fucile d’infanzia era impreziosito dall’immagine di una piccola lepre in fuga.
Come sparare a un leprotto? – s’era chiesto lui undicenne quando, fucile in spalla, era uscito con suo padre per la prima battuta di caccia. Per cacciare bisogna essere pronti ad uccidere, non solo a sparare– gli aveva detto papà. Uccidere è l’istinto dell’uomo e delle bestie. E’ così, è la natura. Se vuoi diventare uomo devi uccidere. Uccellini certo, non cristiani, che se no ti si aprono le porte della galera. Anche se a certi cristiani una pallottola in fronte gli starebbe proprio bene, che qui se non ci si difende da soli, a noi non ci pensa mica nessuno. Prima te lo ficchi in testa e meglio è. Pensa per te e per la tua famiglia, pensaci tu, non stare a sperare in quelli della politica. Comandano i rossi o comandano i neri, i poveri diavoli restano poveri diavoli, credimi.
Gli piaceva uscire con suo padre, non tanto per la caccia ma per stare ad ascoltarlo, per camminare con lui nel verde, per l’attenzione ai rumori, perché ogni fruscio poteva essere un passero.
Il capanno non ce l’avevano, suo padre aveva le sue idee, preferiva vagare calpestando l’erba, gli archetti li odiava, erano una roba da figli di puttana. Per non dire degli uccelli di richiamo, una vera bastardata. E’ nel tiro a volo che sta la bravura di un vero cacciatore – gli diceva sempre.
Bella forza uccidere un uccellino indifeso, avrebbe detto a Franco sua moglie, vent’anni dopo. Che gusto ci provavi a interrompere una vita che non ti aveva offeso, che si faceva il suo volo senza pretendere nulla? Non mi vorrai far credere che la caccia è uno sport? Uccidere per sport?
Ma le donne, si sa, di caccia e di sport non ci hanno mai capito un accidente.
E poi in valle gli uomini erano tutti cacciatori, era tradizione. Lavoravano alla fabbrica Beretta e cacciavano, uccelli consentiti e specie protette, perché chi ce l’ha il diritto di stabilire questo sì e quello no? Dov’è finita la libertà? E che cos’era quella storia di proteggere gli animali, c’erano la selezione naturale e subito dopo la caccia: chi ce la fa bene, e gli altri a pascolare nei cieli di Dio. Perché per un cristiano è forse diverso?
Franco non aveva mai beccato un granché, non aveva una buona mira e poi a volte chiudeva gli occhi all’ultimo minuto, come per non volerne sapere niente, per non essere lui quello che premeva il grilletto. Che premere il grilletto non è una cosa da poco. E poi ci si deve subito preparare al rinculo.
Suo padre gli aveva raccomandato di tenere il calcio inchiodato stretto alla spalla per sentire meno dolore nel contraccolpo, di impugnare l’arma con fermezza ma delicatamente, di allineare l’occhio al mirino e poi, superata la soglia della paura, sparare sicuro.
In realtà, quello che gli piaceva era la corsa che veniva dopo, con i cani davanti, in mezzo all’erba, il sangue a pulsargli nelle tempie. I cani abbaiavano e lui urlava come un pazzo, preda di una frenesia, del piacere di averlo premuto quel grilletto, di essere un uomo a tutti gli effetti, non un moccioso.
Il suo fucile c’era ancora, ma a tenerlo in mano sembrava leggero, le canne troppo corte, il calcio stretto per la sua spalla di uomo. Suo padre gliene propose uno dei suoi, non uno qualunque, il più bello.
Tienila bene, mi raccomando, trattala come se fosse sempre caria. Questa sì che è un’arma, un’arma da uomo.
Franco provò a mettersi in posizione, la guancia appoggiata all’arma, il peso sul piede sinistro spostato in avanti, il calcagno del piede destro di poco sollevato, proprio come gli aveva insegnato suo padre che non sbagliava un colpo, puntava il bersaglio con una faccia inespressiva e, come se avesse un computer in testa, colpiva il fagiano che si afflosciava in volo e cadeva a testa in giù.
Era perfetta, una gran bella carabina, completa di cannocchiale. Portava cesellato sul calcio un cervo con uno splendido palco di corna, pronto al balzo.
E’ una carabina da caccia grossa, calibro 308, ci puoi uccidere un cervo o un cinghiale. Se miri con il cannocchiale da puntamento la preda te la vedi lì, come se fosse a due passi. E poi guarda bene sul fusto e sulla canna, osserva la matricola, il catalogo e soprattutto il punzone del banco.
00174-XX7, P.S.F., E.L. mostravano le incisioni. Il primo è il numero di matricola, cioè la targa del fucile e il numero progressivo di produzione, XX7 è il certificato di nascita, vuol dire che è stato costruito nel 1971 e P.S.F. indica le prove di sparo fatte dal banco. E.L. sta per extra lusso, mica un fucile basico – chiariva il padre gonfio di orgoglio, gli occhi rianimati forse dal ricordo del volo di una quaglia o del ritmo della catena di montaggio della fabbrica Beretta, o del bicchiere di bianco con l’oliva del fine turno, seduti all’osteria, le gambe accavallate, a tirare il fiato parlando di calcio, donne e politica.
Ricordati di pulirla come si deve prima e dopo l’uso, ben oliata, come ti ho insegnato. Un’arma come quella è un gioiello. E poi sono contento che vai a caccia, è un po’ come se ci andassi ancora anch’io che adesso ci vedo poco. Dovrei decidermi per quell’intervento delle cataratte. Ma poi che cosa mi importa, non è che ho gran che da vedere. Anzi alla mia età, meno si vede e meglio è.
Franco teneva la carabina sotto il sedile dell’auto: un’arma a portata di mano ti dà sicurezza, pensava. L’aveva pulita per bene, godendosi in mano il freddo delle canne, accarezzandolo come fosse un bambino. Se ne sentiva la responsabilità, era una “signora carabina”. Non che avesse deciso che farsene, ma stava meglio a sentirla vicino, gli faceva compagnia, gli apriva possibilità nuove.
Da quando il giudice lo aveva cacciato di casa con un decreto di allontanamento, lui viveva in due stanze ammobiliate in un quartiere popolare degradato, pieno di neri e magrebini. Ma non si poteva permettere altro, perché c’era da pagare il mutuo di casa, anzi dell’ex casa, gli alimenti per il figlio ancora piccino, l’affitto di due stanze fetide e poi doveva vivere lui. Niente sfarzi, con il suo stipendio ci stava dentro al pelo. Niente cene fuori.E poi con chi? Di amici non gliene erano rimasti, si erano schierati tutti con lei, cioè contro di lui. Dicevano che era un violento, ma non era vero. Lui non aveva mai spaccato la faccia a nessuno. E certo le occasioni non gli erano mancate Aveva un brutto carattere, si accendeva con niente, sputava fuori parole roventi, si alterava, la minacciava,ma solo con la voce.
Magari l’aveva spintonata, qualche volta un ceffone. Sì, anche davanti al bambino, non è che lo scegli quando dare fuori di matto, non è che l’ira la puoi rimandare, quando arriva arriva e chi c’è c’è.
E di ira in quelle due stanze anonime, che continuava a considerare provvisorie, ne masticava parecchia.
Si sforzava di non guastarsi l’animo rimpiangendo i tempi andati, di andare avanti, di farsi riprendere dalle fesserie della speranza, dal filo appiccicoso della vita, ma vivere insieme alla feccia, ai pakistani con i loro capelli unti, ai negri che ballano e mangiano a tutte le ore, ai nordafricani con il coltello facile non era mica uno scherzo.
Le liti nel suo stabile erano all’ordine del giorno e della notte. Lui cercava di starne fuori, di non mischiarsi a quella gentaglia che, se fosse stato per lui, avrebbe rispedito a casa loro.
Ma, come sempre, lui non contava un cazzo.
A volte la mattina si svegliava agitato, come se avesse dormito in casa d’altri, arrotolato in lenzuola sudate e stropicciate, comprate a buon mercato, e sentiva i mugugni di quelli di sopra, o di quelli delle stanze accanto, in una lingua che non si poteva capire e pensava che una casa vera ce l’aveva e che la stava ancora pagando. Una villetta a schiera nella parte sud della città. Niente di lussuoso, ma lui, che con le mani se la cavava e sapeva fare un po’ di tutto, l’aveva sistemata bene. Aveva immaschiato le assi del parquet di rovere nella zona giorno e incollato la moquette nelle camere. La tappezzeria se l’era risparmiata, grazie a Dio non era più di moda, altrimenti lei, che era grande nella testa, avrebbe preteso pure quella.
In realtà si era divertito a fare quei lavori, ne era orgoglioso.
Ora però gli prudevano le mani all’idea che quella casa non fosse più sua, che non potesse più ciabattarci la sera, bersi una birra con i piedi sul tavolo a fine turno, insegnare a stare al mondo a suo figlio. E sa Dio quanto quel bambino ne avesse bisogno, che più lo si lasciava in mano a lei più si faceva pauroso, da sembrare malato, quasi una checca.
Lui si era impegnato per quel che poteva a raddrizzarlo, a cementargli la spina dorsale. Ma il calcio non gli interessava, la box non parliamone, non la reggeva neanche in tv. La caccia non poteva neanche nominarla senza farlo impallidire. Era un bambino fragile, piccolo e magro per la sua età, gli occhi perennemente cerchiati di nero. A scuola se la cavava bene, anche se le maestre dicevano che soffriva d’ansia, che non reggeva lo stress delle interrogazioni, che aveva attacchi di panico.
Certo a trattarlo come una femminuccia come faceva lei, che cosa volevi che ne saltasse fuori? Se glielo avesse lasciato in mano, che so per un annetto, lui lo avrebbe aiutato a farsi uomo, a tirar fuori le palle, perché era figlio suo e le palle ce le aveva di certo da qualche parte.
Quella sera non c’era verso di stare tranquilli a cena. Si era comprato un pranzo precotto al supermercato, non cucinava mai, non si cucina per uno solo, si mangia freddo o al massimo si riscalda al microonde. E poi quei vassoietti costavano poco.
I giargia del piano di sopra facevano un fracasso d’inferno, parlavano in tanti, tutti insieme, forse litigavano con i loro vocioni spessi. E mica c’era da incazzarsi con quei bestioni, che magari ti portavi a casa un sacco di mazzate.
Aveva acceso la macchina e aveva cominciato a girare nella città buia, incazzato con quei negri, con quella vita grama che gli era toccata, con i soldi che non c’erano, con le speranze andate in fumo, con lei che l’aveva cacciato, con suo figlio che cresceva storto e anche per quello sembrava fosse colpa sua.
La macchina come d’incanto aveva imboccato la strada di casa, della sua ex casa. Aveva parcheggiato sul marciapiede di fronte, i fari spenti, così senza motivo e se ne stava lì senza sapere che fare, il cuore vuoto.
Le luci da basso erano accese, le tende tirate, non si vedeva niente di dentro, però si poteva immaginare. A quell’ora lei aveva finito di cucinare e stavano mangiando. Televisore spento, lei diceva che faceva male mentre si mangia. Inspirò a fondo, forse per annusare i profumi e scoprire che cosa avevano nel piatto. Odore di casa. Che idiota, da questa distanza, finestrini chiusi, che cosa vuoi sentire?
Gli sfuggì l’occhio verso il garage. Era chiuso, lei parcheggiava sempre dentro per paura dei vandali, anche se lì in quel quartiere non succedeva mai nulla. Avrebbe dovuto provare a vivere dove abitava lui adesso, in mezzo a quella feccia senza nulla da perdere, immerso in quel puzzo di curry, di aglio e di olio fritto.
Fuori dal garage, in fondo al vialetto, proprio davanti alla basculante, era parcheggiata un’auto grigia metallizzata sconosciuta, una bmw.
Suo suocero non guidava più, e poi una bmw non se l’era mai neanche sognata, sua suocera non aveva mai guidato, amiche con l’auto di quella tinta e di quella cilindrata non se ne ricordava.
E se fosse di un uomo? E se lei avesse un uomo?
Quella possibilità non l’aveva mai sfiorato, lei diceva sempre che con gli uomini non voleva più avere nulla a che fare, che gliene era bastato uno. Ma magari aveva cambiato idea. Magari ne aveva incontrato uno di quelli tutte moine, fiori, cioccolatini e compagnia cantando, un uomo che ci sa fare con le donne.
Quel pensiero gli imperlò la fronte di sudore e la mano, inconsapevolmente, scivolò sotto il sedile, ad accarezzare la carabina Beretta, la testa come imprigionata in una bolla.
No, non era geloso, è che lui era un uomo, uno di quelli che sa difendere il suo, che non si fa soffiare moglie e figlio da un damerino con auto grigia metallizzata che certo non abita in due stanze puzzolenti ammobiliate, fianco a fianco agli immigrati.
Decise di aspettare, di calmarsi, di riflettere. Forse fantasticava e stava costruendo castelli in aria, forse ci ricamava sopra e poi quell’auto magari era di una collega di sua moglie.
Ma quella era un’auto da uomo, ne era certo. Non che ci sia una regola: a destra le auto da uomo, a sinistra quelle da donna. E’ che le donne le berline non le amano, così lunghe poi, non le sceglierebbero mai. Poi come le parcheggiano? Loro, le femmine, comprano auto compatte, meglio se piccole e poi rigano anche quelle.
Pensava e intanto accarezzava la carabina. Non era lì per caso quell’arma, nulla succede per caso.
E se quell’uomo fosse anche ricco? E se fosse istruito? Lei di fronte a una poesia avrebbe calato le difese e anche le mutande, ne era sicuro. Le donne sono tutte così, non capiscono un cazzo. Non lo sanno che con le parole non ti riempi lo stomaco. Uno suda in fabbrica una vita, incastra le assi del parquet, tinteggia le pareti, taglia l’erba e poi arriva un sapientino qualunque che, senza una goccia di fatica, con due parole messe in fila per bene riesce a imbambolarle.
Al solo pensiero sentiva la rabbia scorrergli a fiotti dagli occhi iniettati di sangue.
Era sangue quello che bramava, fiumi di sangue per lavare l’onta di essersi lasciato soffiare moglie, figlio e casa, di vivere in un quartiere di merda, di mangiare cibo di merda, di fare un lavoro di merda, di essere solo come una merda.
Era quello che gli bruciava di più, quella parola solo che gli apriva una voragine davanti. Sarebbe sempre stato solo. Sì, magari una sgallettata se la sarebbe portata a casa, giusto per il servizio notturno, ma solo sarebbe stato comunque. Perché non è che di famiglie ne metti in piedi cento, che immaschi migliaia d’assi di parquet, posi chilometri di moquette, tagli quintali d’erba. La cazzata la fai una volta e poi, per il resto della vita ci frigni sopra, bevi birra, rutti in santa pace e ti senti morire.
Si era aperta la porta d’ingresso e il respiro gli si era inchiodato. Alto, brizzolato, più vecchio di lui, ma ben più elegante, un principio di calvizie che lo fece gioire, sbarbato di fresco.
D’istinto si portò una mano alla guancia ruvida, la sua rasatura non era recente.
Se ne stava andando. Allora non dormiva da lei, non erano ancora a quel punto. Bisognava intervenire subito, prima che succedesse, perché poi quando si crea quell’intimità fra maschio e femmina è dura. Perché lei non era una facile, una da una botta e via. Lei se con uno ci andava a letto, poi ci parlava e lo seccava con i ricordi, con quella menata dell’infanzia, e poi con i progetti, poi i sogni e via discorrendo.
Suo malgrado, ricordò quanto gli piacesse il sesso con lei, come potesse essere stupendo anche per quel dopo, per quel perdersi in fantasticherie che lo aveva ammaliato, per quel fare tutto semplice che lo teneva attaccato al lato buono della vita.
La guardò intensamente, come per accarezzarle il viso con gli occhi.
Tirò su la carabina e se la pose sulle cosce, così era pronto. Non aveva ancora deciso per cosa, ma era pronto. Bisogna essere pronti nella vita, altrimenti ti scavalcano tutti, ti rubano i soldi, la macchina e perfino la moglie. E tu te ne resti lì come un coglione, con l’indecisione in mano.
Ancora parlavano, fuori dalla porta. Chissà cos’avevano da dirsi? Lei ce l’aveva questa fissa delle parole, diceva che lui non parlava abbastanza, che non raccontava mai niente di sé, che era come aver sposato un muro.
Io non sono capace di entrare nel tuo silenzio, gli aveva detto un giorno.
Ma lui delle parole diffidava. Hanno un’aria da niente le parole, ma poi d’improvviso scatenano emozioni forti e ti ci trovi attaccato via come a un cappio. E ti tocca tremare per il resto della vita per il terremoto che hanno innescato, che mai avresti detto fosse possibile smuovere solo con i sentimenti. Le parole hanno così tante facce che non c’è da dargli credito, certe sono capaci di rigirarti le cose da non capirci più niente.
Però, a giorni, gli sarebbe piaciuto avere qualcosa dentro da dirle, ma le sillabe gli si impastavano sulla lingua, le parole erano grevi come se dovessero farsi strada attraverso qualche sostanza densa, e lui restava lì esitante come un allocco ad ascoltare tutto il silenzio che si sentiva dentro.
E poi che cosa raccontare di giornate di lavoro in cui, a parte che lavorare, non succedeva niente. E che dire dell’infanzia, chi se la ricordava?
Certo, a ben vedere non le aveva mai raccontato del fucile e della caccia, della sua paura, del sangue che gli pulsava alle tempie, dell’angoscia che lo prendeva di notte quando sapeva che il padre l’avrebbe svegliato presto per portarlo a sparare, del sudore della mano che teneva gli uccellini morti per le zampe, della speranza inconfessabile di sbagliare mira, di fare cilecca. Mica voleva fare la figura dello sfigato. Che poi la paura se l’era fatta passare e si era fatto uomo.
Non aveva più sparato da allora, ma non era una cosa difficile. Un conto è colpire un uccellino in volo, un altro un uomo fermo davanti a una porta, davanti alla porta di casa tua, che fa il cascamorto con tua moglie e che magari chiacchiera anche con tuo figlio.
Abbassò il finestrino e il suo fiatò si condensò nell’aria quasi gelida. Imbracciò la carabina Extra Lusso, la faccia chiusa in una smorfia e tolse la sicura sentendo un click. L’arma era fredda e lui le stava attaccato come l’edera al muro. L’avrebbe scaldato lui quel fucile, con un colpo secco, di quelli che mettono le cose al loro posto. Pesava, era una carabina da uomo. Girò l’anello della messa a fuoco e di colpo l’avversario comparve al centro del mirino, vicino. Il suo dito si tese sul grilletto, era pronto.
La sua bocca era asciutta, le labbra serrate, le narici tese, il cuore sembrava percuotergli il petto lento, sotto la luce fredda della luna, la testa vuota di pensieri.
Non era così vecchio come aveva creduto, i tratti del viso erano distesi, quasi dolci, il naso leggermente storto come di chi qualche grana l’ha incrociata.
Lui, l’altro, neanche si immaginava di comparire nitido al centro del mirino di una carabina Beretta di quelle buone. Magari un’arma non l’aveva mai impugnata e per quello aveva quell’aspetto inamidato, come di uno che ha le ossa fragili e non ha capito niente della vita. Magari l’avevano bastonato pure lui e, invece di farsi forte, s’era immalinconito.
Ma era tardi per rifletterci, per cominciare a costruirci sopra, che se t’infittisci la testa di pensieri poi non fai più niente. Non si sarebbe tirato indietro questa volta, non avrebbe chiuso gli occhi, avrebbe fatto ciò che andava fatto, avrebbe difeso la sua vita, quell’unico pezzo di vita per cui valeva la pena di battersi. Ora avrebbe contato fino a tre e poi bang.
Non sudava, non tremava, sedeva con il tronco in leggera torsione, fermo come una statua, risoluto, le mani di pietra, gli occhi aguzzi a punteruolo. L’angoscia era rimasta a presidiare le sue due stanze ammobiliate.
Un respiro e poi: uno, due…
Ma, fermi tutti, che cos’è quella roba che corre?
Dick, Dick sei tu? Urlò trasalendo.
Aprì la portiera d’istinto e fu investito dal suo cane, un meticcio, cioè un bastardo, giovane e bello come il sole.
Il cane era così felice di vederlo che saltava come un matto e sembrava rimbalzare come una palla. Lo abbracciò e se lo strinse al petto forte, mentre Dick gli leccava il viso uggiolando, si beveva le sue lacrime salate e lui lo accarezzava. Sbavava Dick la sua sorpresa, il muso imbrattato di gioia. E intanto spiccava balzi da non credere, come se anche le zampe volessero confermare alla terra tutta la sua irrefrenabile contentezza. Bava e lacrime, umori mescolati, lo stesso stupore, la stessa speranza.
Franco, con una folle ilarità negli occhi, si inginocchiò sul marciapiede e presero a rotolare, uomo e cane avvinghiati sull’asfalto, vicino ai bidoni dell’immondizia, a ridere, a dirsi dolcezze, a scambiarsi baci e leccate a non finire.
Dick gli voleva bene.
La carabina Beretta 00174-XX7 Extra Lusso, con il colpo ancora in canna, era scivolata a terra. Dal calcio di legno un cervo li osservava stupito in silenzio, piegava di poco il capo regale, palco di corna incluso e, con un balzo, scattava via.
