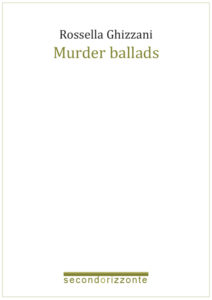
Non è una giornata qualsiasi.
Fa molto freddo. L’aria è gelida, di quella qualità speciale che risente della vicinanza della neve.
Al contatto con la pelle sembra indurirsi, restituisce la sensazione di piccole spore acuminate che trafiggono gli occhi e rivestono di cristalli i tratti del volto, ormai tutti arrossati.
Acqua silenziosa e costante.
Piovono gocce gelate. Come in un disegno a matita, si dispongono in file ordinate che non vengono assorbite dall’asfalto. Del cielo non c’è traccia, tutto è avvolto dal colore liquido che sgorga da questa precipitazione monotona.
Sulle strade si sparge un luccichio diffuso come un pianto.
Immote, le facciate delle case ristagnano nell’atmosfera diluita che non cambia tonalità con il trascorrere delle ore. La luce, asincrona al passare del tempo, rimane invariata.
Sono felice, oggi ho buon tempo. Questa pioggia riesce a ripulire e contenere ogni cosa.
Rende deserta la Darsena, silenziosa, tanto solitaria che mi è possibile fermare lo sguardo sull’acqua, cristallina e trasparente, e ascoltarne la corrente sciabordare intorno ai parapetti.
Attutisce il frastuono del traffico, che sfila composto, discreto, senza inciampi, avvolto nel fruscìo che esso stesso produce strofinando sul catrame bagnato. Giunge alle mie orecchie come fosse distante, addirittura lontanissimo.
Mi ha sempre affascinato questa città, oggi come la prima volta che l’ho incontrata.
Questo vapore umido si adagia su ogni cosa, compatto, come la superficie di una lavagna su cui si delineano sofisticati fotogrammi in bianco e nero che oggi fanno somigliare Milano a come la immaginavo quando ero piccola, così remota e grande da credere che contenesse il mondo.
Sulla Ripa di Porta Ticinese, al riparo dal freddo e dalla pioggia, guardo fuori dalla vetrina del negozio di dischi in cui mi attardo, seduta comodamente fra le numerose casse di legno ricolme di long playing.
Avvolta dal suono delle ballate evocative e struggenti di Nick Cave, posso essere spettatrice di scorci di vita che mi scorrono davanti. E’ la musica a guidarmi, mi lascia intuire, mi dona una sensazione di conoscenza rapida e chiara e mi permette di indagare e comprendere dettagli sfuggiti alle paratie offerte dalle tende e alla vigile sorveglianza dei vetri chiusi delle finestre.
Osservo con attenzione minuziosa, e non vedo solo con gli occhi.
Su questa cornice monocromatica risaltano vividi i contorni dei passanti. Riesco ad isolare le sagome dei singoli corpi, figure di primo piano che campeggiano sullo sfondo.
Ognuno si staglia netto.
La ragazza cammina così lentamente da farmi pensare che ignori la meta del suo avanzare.
E’ così giovane e talmente rallentato il suo passo, che pare aver adeguato il ritmo del suo incedere a quello di una persona molto più vecchia di lei, una compagna che io non posso vedere e che pure le sta a fianco. Poggia l’ombrello sulla spalla destra e sostiene appena con le dita l’impugnatura dell’asta.
I suoi capelli e il resto del corpo risultano immobili. Tanto cautamente accompagna un piede accanto all’altro e tanto silente è il suo passaggio che sembra trasportata.
Tutto il corpo della ragazza è trattenuto, rivolto al proprio interno, anche la pioggia le passa vicino senza sfiorarla.
Procede piano, cercando a tentoni cosa incontrerà più avanti, attenta – come prescrive la vecchiaia – alle asperità del cammino, intenta ad evitare gli inciampi sempre pronti a tradire i suoi passi. Assorta, concede che mi scorra davanti solo questo suo appassito deambulare.
I suoi pensieri non sono per me.
Ora uomini giovani, frettolosi, scuri in volto e seri, a gruppi piccoli di due o di tre, affrontano il freddo con abiti leggeri.
Hanno capelli inumiditi dalla pioggia, mani intrappolate nelle tasche strette dei pantaloni affusolati e spalle aperte, esposte al freddo e alla strada. Ciascuno guarda davanti a sé, come sapesse dove arrivare. Ad unirli solo il silenzio che li avvolge e la marcia che conducono all’unisono.
Devono avere bisogno di molto coraggio, se hanno deciso di fronteggiare con quell’aria di sfida una giornata così.
Si spostano guardinghi fra postazioni da trincea, gravati da una minaccia, incuranti del pericolo, uomini infradiciati da chissà quale guerra, si portano dietro una fatica fangosa che celano dietro quelle spalle spalancate al massimo.
Come fossero ali.
Altri uomini, tre, più grandi d’età, una squadra in abiti da lavoro tutti uguali. La stoffa dei loro indumenti, la pelle del volto e delle mani appaiono impolverate dalla mattinata di fatica. E’ ora di posare gli attrezzi e trovare riparo, almeno per un po’. Un pasto caldo, magari un goccio di vino. Devono fare incetta di tepore, la giornata non è ancora terminata. Anche adesso che stanno riponendo gli arnesi, si muovono a tempo, non sbagliano un gesto. Insieme sembrano formare un meccanismo ben funzionante di barre e ruote dentate che con precisione si muove veloce.
Si capisce che sono abituati, ciascuno per la sua parte, a concorrere a un fine determinato e a coordinare i movimenti per far fruttare al meglio il comune impiego di energia.
Nel condurre quella danza ritmata, mi appaiono sicuri abbastanza da poter ingannare lo scorrere del tempo. Non perdono nel vento neanche un minuto; ogni secondo appartiene ad uno scatto preciso dell’ingranaggio. Tac.
Poi, sul lato apposto del Naviglio, un portone spalanca un pertugio. Eccola, ne esce lei. Giovane non lo è più, cammina veloce, il busto proteso in avanti denuncia la fretta di chi deve fare ancora molte cose prima di potersi riposare. Stringe l’ombrello come se ci fosse vento forte, l’asta inclinata davanti a sé, a spingere la massa d’aria che la separa dalla prossima tappa.
Non può certo far tardi. Muove passi rapidi, una corsa trattenuta, solo di quando in quando sfogata in una serie minima di saltelli. La seguono i capelli ingrigiti, lunghi; le battono fuori tempo il ritmo sulle spalle.
Seduta come sono in prima fila, riesco a vedere l’idea che ha di sé, ancora non abituata a dosare le forze e legata a catena a quelle che non ha più. Qualche anno prima sarebbe certamente volata davanti a questa vetrina.
Quando esce di scena, davanti a me sfreccia correndo la sua ombra.
La vedo avanzare sull’asfalto lucido. Elegante, le spalle erette, in equilibrio perfetto sul proprio asse, le braccia piegate, appena accostate ai fianchi, avanza rapidamente distendendo per intero l’ampiezza della sua falcata. I capelli scuri raccolti in una coda sulla sommità del cranio oscillano con la precisione del pendolo sul metronomo.
Ora, davanti alla vetrina che mi ripara, compare una donna. Piccola di statura, così discreta da confondersi con i colori che le stanno intorno. Cammina tranquilla, la noto perché la blocca lo squillo del suo telefono, e per rispondere si sofferma proprio davanti a me.
Le parole accolte nella sua coclea provocano una detonazione dentro di lei, non riesce a contenerle. Alza il volto verso il cielo, impaurita. E’ evidente che sta ricevendo una notizia che trascende l’ordinario.
Chi le parla la sta mettendo al corrente di un fatto sconcertante che la terrorizza.
Sta ferma, rivolta alla vetrina. Ha abbandonato per terra l’ombrello. Le serve quel braccio libero per poterlo agitare: batte la mano sul fianco e così facendo sembra voler applicare un’interpunzione al racconto che le viene fatto. Le serve per rendere più chiaro il senso, individuare pause e inflessioni nella voce che le parla, dar rilievo alle singole parti: non può recepire d’un fiato l’affanno di che le ha telefonato.
Quando ripone il telefono nella tasca non sa bene che fare. Raccoglie l’ombrello. Non ricorda più dove stava andando, tenta un avvio, prova a ripartire. Si aggiusta i capelli, passa una mano aperta sul volto, si liscia la stoffa del cappotto. Cerca in ogni modo di riprendere la rotta che stava seguendo. Ma il colpo di vento deve aver generato in lei un’onda gigantesca, troppo difficile da cavalcare. Non ce la fa, barcolla. Alla fine, torna sui suoi passi ed esce di scena.
Questa donna mi lascia la sensazione di aver assistito al compiersi di un avvenimento oscuro. Richiama alla mia mente la parola mistero, la getta senza volere fra i miei pensieri, provocando reazioni a catena che mi condannano a sondare l’esperienza e la memoria alla ricerca di analogie, segni, significati.
La confronto con l’espressione determinata di controllo che scorgo sui volti in rapido passaggio davanti a me. Nel negozio di cui sono ospite risuonano lente le note malinconiche di Nick Cave; qui la musica è liberata dai fatti di ogni giorno e consente l’illusione di poter davvero dominare l’accadere degli eventi.
Mi è facile pensare ad un significato quasi domestico di questa parola così imponente e dal richiamo religioso. Mistero, verità nascosta, segreto, ma anche disconosciuto sapore del normale succedersi del reale.
Non è forse questo che ho cercato di carpire ai volti delle persone finora osservate?
Ognuno proteso ad aspettare quel che in cuor suo attende, quello che la mente ha programmato, i soliti impegni di sempre.
Eppure nessuno sa dove davvero lo condurrà la giornata che sta attraversando.
Continuo a guardare. Dietro i vetri di una delle grandi finestre della casa che ho di fronte, una tenda pesante viene sollevata appena, poi ricade giù. Qualcuno ne ha afferrato i lembi dal basso. Una bambina penso, così piccola da non riuscire a sbirciare oltre il davanzale. Percepisco i polpastrelli di quelle dita piccole che saggiano la consistenza della fibra, ricavandone sensazioni che, intuisco, contribuiranno nel futuro a richiamare alla memoria il ricordo vago di quella stanza e di questo pomeriggio di pioggia. Osservo il movimento del tessuto che me lo restituisce spesso, liscio. Gli viene impresso un moto oscillatorio cui la stoffa si adatta morbida, accondiscendente. Immagino che alla piccina invisibile servano entrambe le mani per muovere il tendaggio da un lato all’altro nello spazio di luce. Si gingilla e manda in qua e in là la sua campana di velluto, e così facendo concorre a diffondere sulla strada il suono ritmato dei rintocchi – così intonato alla musica intorno a me – che adesso attira la mia attenzione.
Sul lato opposto dell’alzaia del Naviglio Grande, è il campanile della chiesa di Santa Maria delle Grazie che suona a morto. Di fronte all’entrata principale sosta un carro funebre. Si intravede appena, circondato com’è da una piccola adunata di ombrelli, cupole policrome che ne impediscono la vista. E’ la brillante cromia delle stoffe a far risaltare l’agguato di quel fondo scuro che compone dentro di me la parola funebre.
Dal portone della chiesa, soli o a piccoli gruppi, si riversano sul sagrato stretto donne e uomini. Appena giungono all’aperto, si soffermano il tempo necessario per aprire ciascuno il proprio ombrello e raggiungere il corteo minuto che via via si va componendo. La luce inerte delle prime ore di questo pomeriggio piovoso vibra ogni volta che nell’aria fiorisce la semisfera colorata di un ombrello, cambia, trattiene l’eco della sonorità prodotta dallo scatto metallico e la pioggia riverbera ogni tonalità. Ciascuna risalta sul fondale fluido aggregandosi alla cornice frastagliata che circonda il passaggio della bara. Come se si unisse al coro che armonicamente si va formando per accompagnare il feretro fin dove potrà.
Un funerale.
Quel piccolo assembramento di persone si dissolve in una fila ordinata che pure rimane a parte, separata da quel che avviene sulla via. Adesso infatti i passanti paiono protetti da un’armatura che li rende impenetrabili a ciò che sta avvenendo. Non fa parte della loro giornata la cerimonia funebre, accade altrove, in un luogo distante dove non ci sono più cose da fare, parole da dire, tempo da domare. Dentro di me sento un’asperità che mi impedisce di calare a picco dentro la parola morte, una roccia acuminata che graffia la pelle e rende inaccessibile il passaggio.
E’ l’attaccamento alle persone, alle cose. E invece separazione, equilibri da ricostruire, l’abbandono definitivo della sepoltura: il dolore, la vita che continua in difetto di uno, lasciato là.
Provo a immaginare il primo giorno in cui la luce del mattino non mi troverà.
Mi metto sulle tracce del senso di vuoto che provo al pensiero della giornata che non vedrò finire e di quella che inizierà in mia assenza. Per farlo ritrovo il dolore delle morti che ho vissuto.
Vado a scovare gli effetti della deflagrazione: l’ho imparato, lo so, è la mia pelle a restituirmene il bruciore, irrompe nell’ordinario scorrere del tempo lanciando il poco dopo ad una distanza incalcolabile dall’appena prima, e in quel volo dissennato, dalla durata minima, accade che la vita di chi resta muti. Un refolo d’aria, l’ultimo, da cui sgorga un cambiamento irreversibile, che durerà per sempre.
Si aprono i vetri di una finestra. Qualcuno si affaccia, getta furtivo verso il corteo uno sguardo in tralice, l’avanzo freddo del disagio provato all’inatteso palesarsi della morte.
S’intona alla musica che ascolto e a ciò che vedo, l’aggettivo funebre. Sospendo lo sguardo, che rivolgo all’interno. Appoggio la schiena al mio sedile di fortuna e mi lascio trasportare dalla melodia. Permetto a questa parolina di guidarmi, la lascio fare, che girovaghi pure dietro le mie palpebre chiuse. Intende forse sottrarsi alla morte, penso. Sottovoce lascio che le labbra soffino fuori le spirali della prima sillaba fu, come un sospiro lieve, e poi precipitosamente le rincorro, nebre sussurro, e sento il volto oscurarsi di luce notturna.
Piano piano, anche qui sta arrivando la sera.
Funebre, bisbiglio. Antro verde di muffa, caverna profonda, sconosciuta e insondabile.
Dietro la vetrina, l’oscurità si trasforma nello schermo nero di un monitor su cui vibrano macchie colorate.
Funebre.
Cappelli di feltro grigi spazzati via dall’onda del vento.
Funebre.
Sì, è vero. Fu. Ma poi consola, ci regala il fresco serale delle tenebre, l’umidità della nebbia, la forza possente della breccia e il calore dell’abbraccio, sia pur breve.
Fu, ma nella sua breve vita quante nuvole contò? E pecorelle, prima di addormentarsi?
Funebre.
E quel ne ci sospinge verso il nuovo di neonato e di neofita, mentre il brivido del bre ancora un poco ci raggela.
Funebre. Parola sdrucciola, addomesticabile, buona per intonare il canto del ringraziamento per tutto ciò che fu.
Ho buon tempo. Posso occuparmi di questo mistero.
Penso alla luce che oggi ha pervaso questa città, e poi stringo il campo, setaccio, e ancora sfrondo. Le strade percorse, il freddo avvertito, questo riparo, i volti che ho guardato.
Dal pertugio stretto che ancora resta di questo giorno ormai alla fine, sguscia la parola morte.
Scavo, quello che trovo è potenza. Quella di una scelta determinata dalla convinzione che niente sia più possibile pensare, fare, dire. Certezza assoluta che nulla si possa confermare, rinnovare, modificare. L’energia del ragionamento al servizio della propria estinzione.
Altrove l’inevitabile traguardo, la speranza di un percorso naturale, un ponte posto a colmare uno iato sconvolgente: il tempo minimo e illimitato di un respiro, l’ultimo, che sarà senza fine.
Fiduciosa confido nella consolazione della gratitudine e del rimpianto per ciò che è stato vissuto. Ritrovo tutti. Quelli che ho perso strada facendo, alcuni così vicini da essere parte di me, altri accomunati da una diversa prossimità. Come compiendo un rito, dentro di me stringo forte e riannodo il laccio che ad ognuno ancora mi lega. Il buio si insinua fra le luci diafane, quasi livide, che speranzose si impigliano ai lampioni delle strade, mentre il loro riflesso, ripetuto all’infinito dal passaggio – ora sostenuto – dei fari delle auto, si scioglie sull’asfalto ormai fradicio trascinato via dal transito delle ruote.
E’ ora di andare. Anche il disco è giunto ormai alla fine.
Mentre mi avvio, sulla soglia della porta socchiusa distinguo poche parole sfumate sull’ultima traccia del vinile.
Just remember that death is not the end … ricordati solo che la morte non è la fine.
Aprile 2017