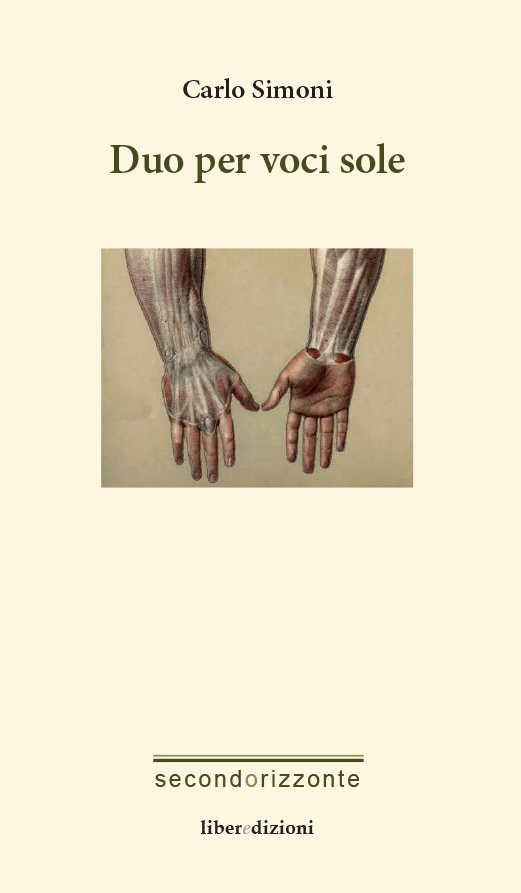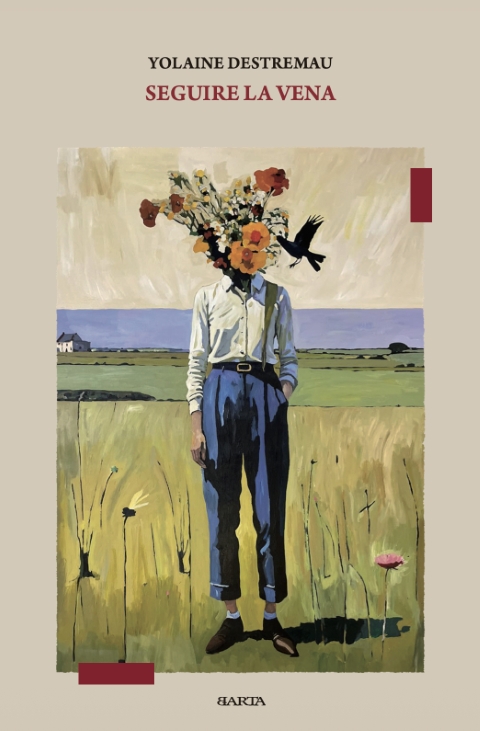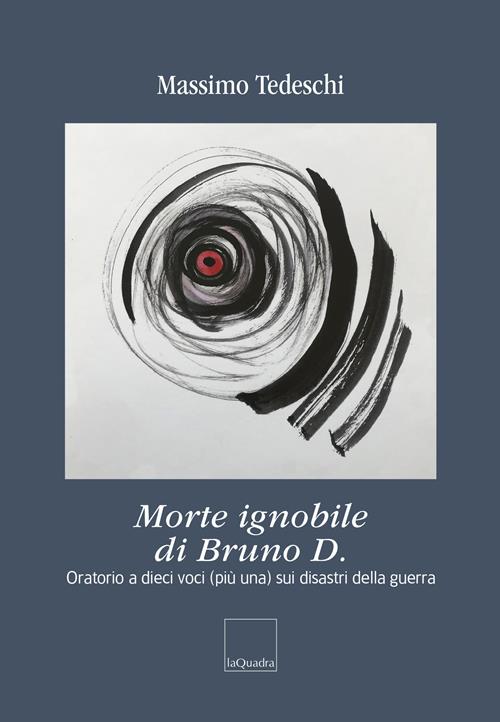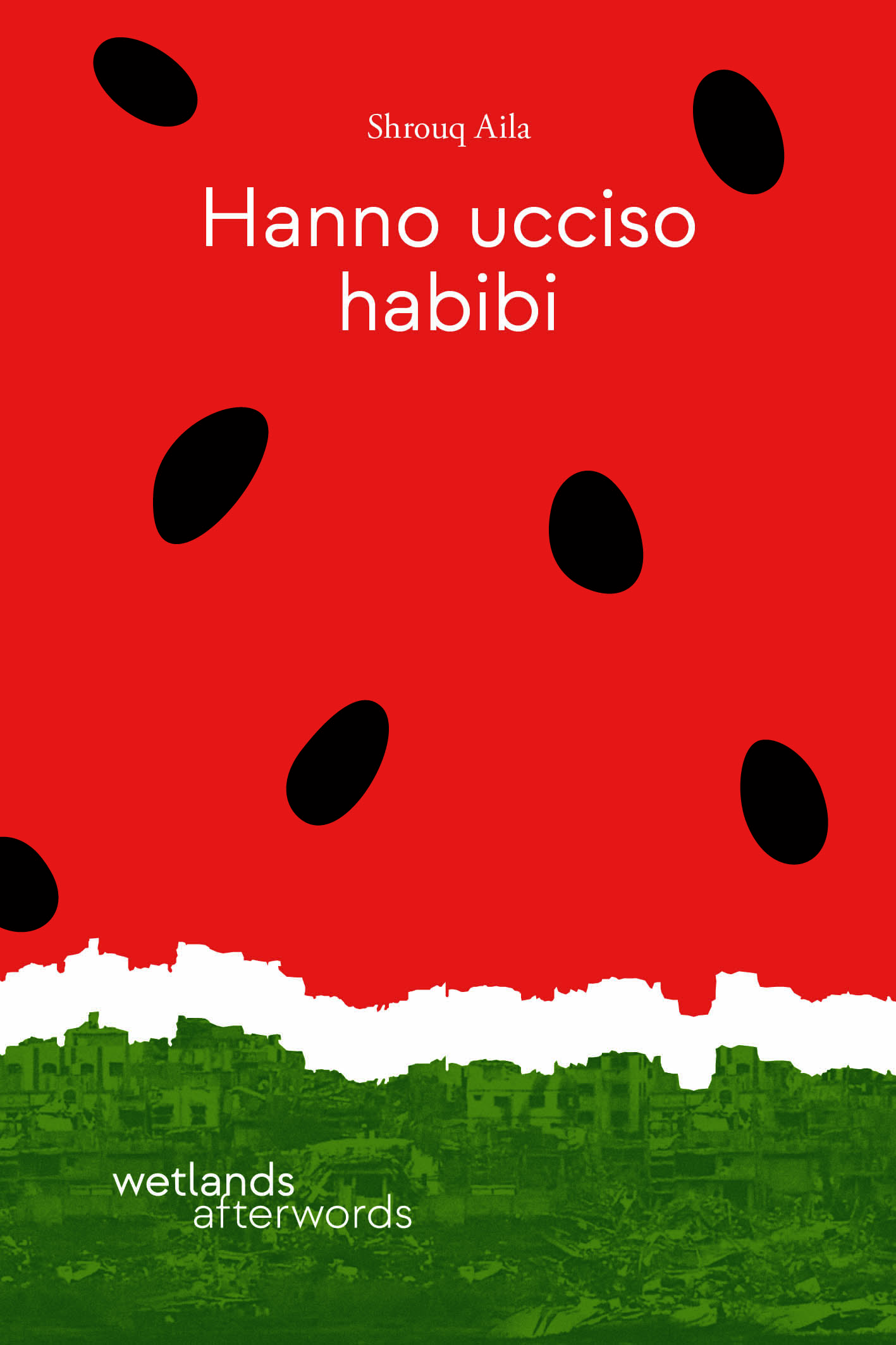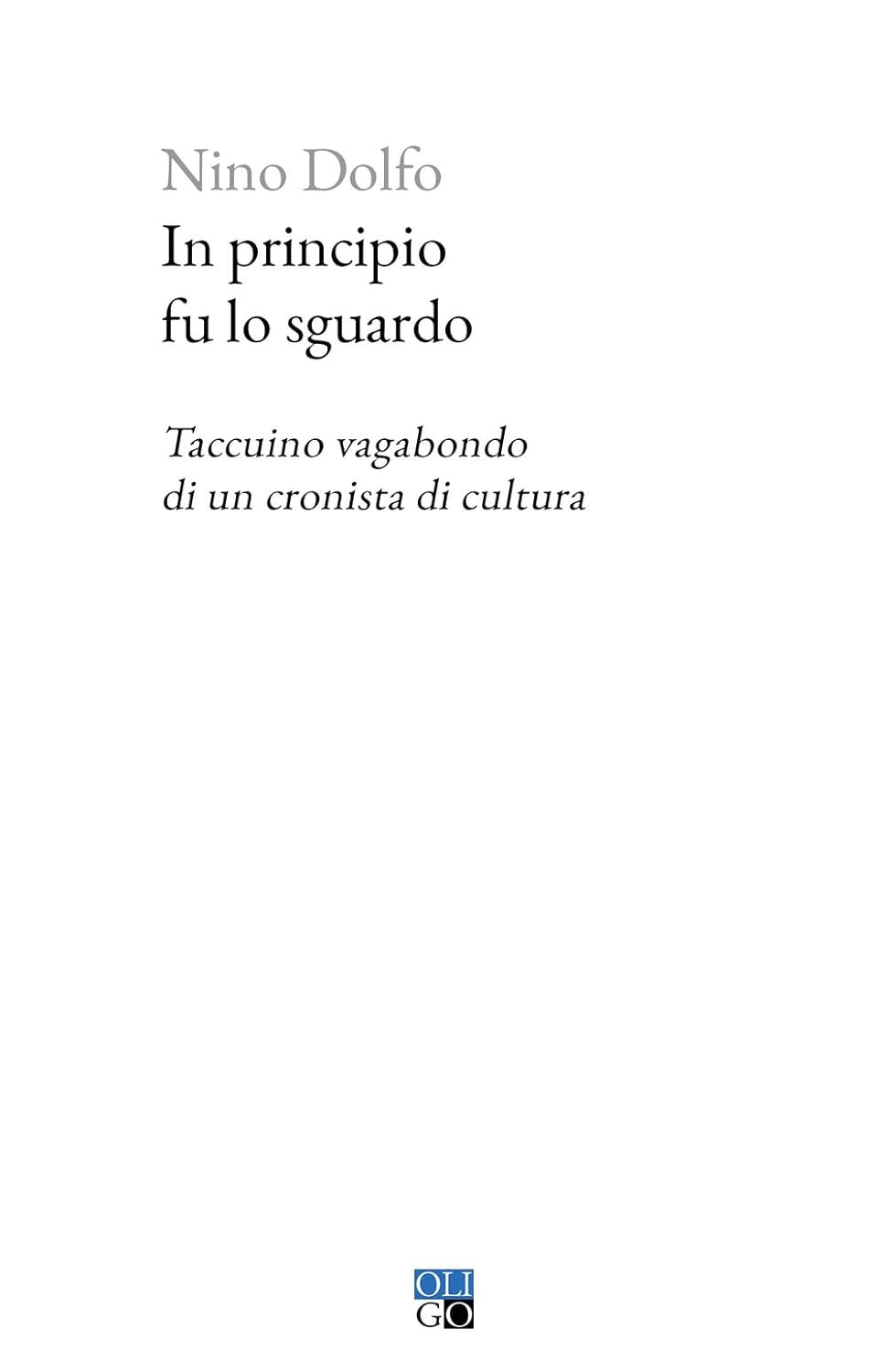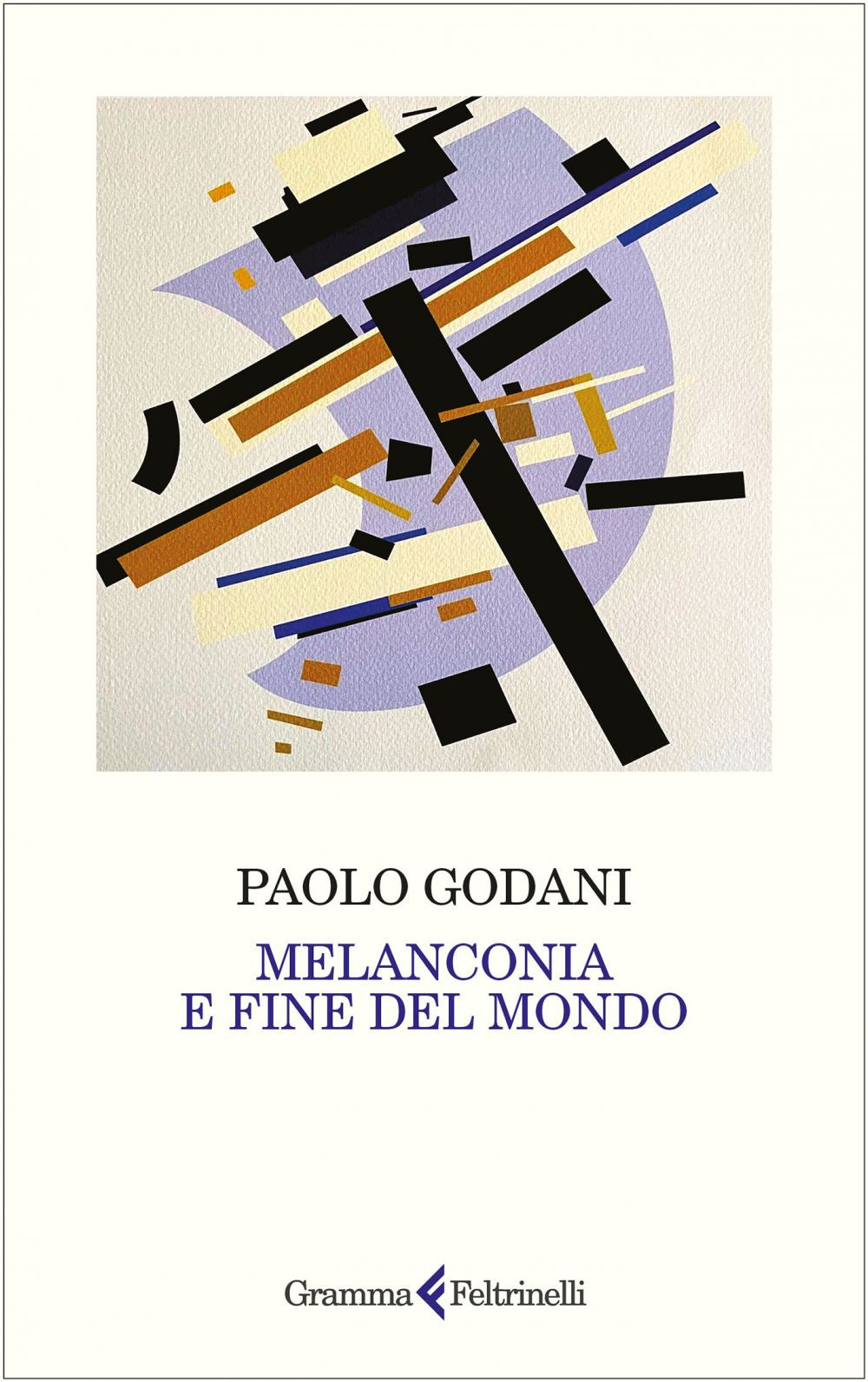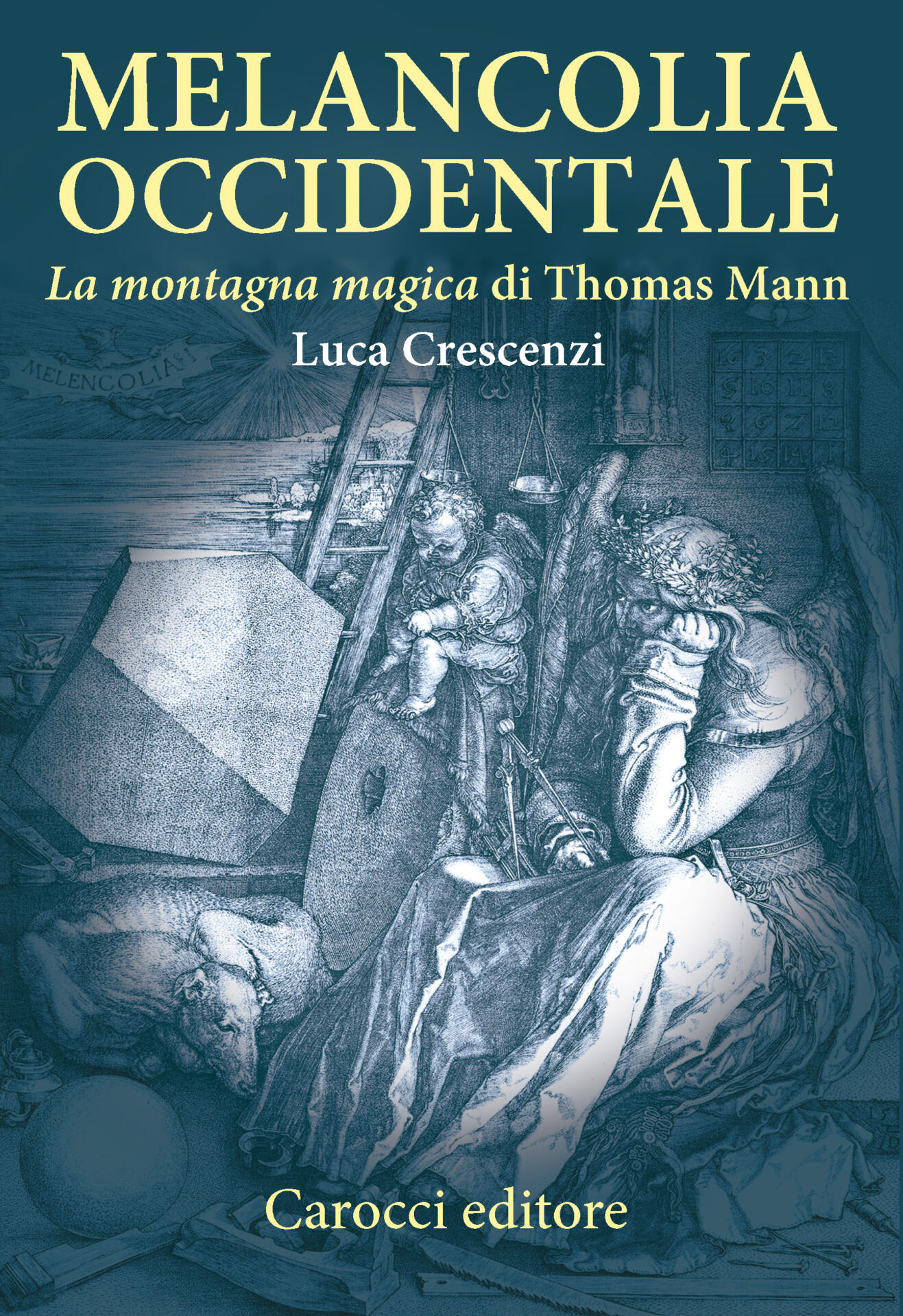Paolo Godani, Melanconia e fine del mondo, Feltrinelli 2025; Il corpo e il cosmo. Per un’archeologia della persona, Neri Pozza 2021; Sul piacere che manca. Etica del desiderio e spirito del capitalismo, DeriveApprodi 2019
Ernesto De Martino, La fine del mondo. Contributo all’analisi delle apocalissi culturali (Einaudi 2029)
Luca Crescenzi, Melanconia occidentale. La montagna magica di Thomas Mann, Carocci 2011
Sigmund Freud, Caducità (edizioni varie contenenti altre opere; pdf scaricabile da siti come https://www.psychiatryonline.it/psicoterapie/caducita-verganglichkeit-1915-traduzione-di-antonello-sciacchitano/)
Robert Musil, L’uomo senza qualità, Einaudi 2014
Alain Ehremberg, La fatica di essere se stessi. Depressione e società, Einaudi 2010
Emanuele Coccia, Metamorfosi, Einaudi 2022, (pp. 196, euro 17)
Jane Bennett, Materia vibrante. Un’ecologia politica delle cose, Timeo 2023
La tesi di fondo Melanconia e fine del mondo di Paolo Godani – il libro attorno al quale si muove questo percorso di lettura – è che esiste “una forma radicale di melanconia (…) caratteristica del solo mondo moderno, se non del solo sec XX (…) connessa al sentimento di una completa perdita del senso del mondo” e che non si tratta di “un fenomeno di natura personale, ma sociale, culturale, storica e persino metafisica”.
Continua a leggere Il potere della melanconia. Un percorso di lettura