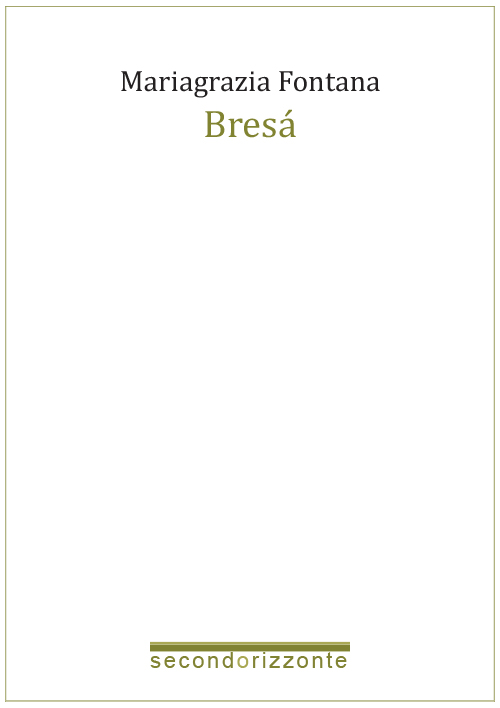
Fino a quel giorno non si era trattato che di una sagoma, il profilo di un uomo sotto la pensilina che conduce all’ingresso dell’ospedale. Non avrebbe saputo dire con precisione quando era comparso, c’era da un po’, con il sole e con la pioggia, appena fuori dall’uscita del parcheggio. Quella sera invece il sole era basso, lei camminava come trasognata, trasfigurata dalla stanchezza, il passo lento e strascicato. Nessuno a casa l’attendeva.
Fu forse per questo che ci mise un poco più d’attenzione, o forse era ora che lo guardasse, o è che prima o poi doveva succedere. Era sempre in piedi, anche se, per la verità, ora s’era affiancato una seggiolina pieghevole. Avrà avuto quasi settant’anni o forse meno, ma mal portati, capelli radi, occhiali, rughe. Vestiva dignitosamente, anche se in maniera dimessa. Un mozzicone di sigaretta spento gli pencolava da un angolo della bocca, nella mano sinistra una radiolina, nella destra un piattino proteso verso i passanti. Chiedeva l’elemosina. Questo se l’era immaginato, ma ciò che non aveva mai notato era il cartello che s’era appeso al collo con un giro di spago, un cartello sgangherato e scritto a mano che recitava: só mia ön giargia, me só ön bresá.
Da non crederci. Pensò di aver letto male, rallentò ulteriormente il passo diffidando dei suoi occhi miopi. Diceva proprio così, non s’era sbagliata. Si incamminò verso casa ribollendo dentro, con l’amaro in bocca, borbottando fra sé e sé, grugnendo e inveendo contro l’ignoranza crassa di chi si vanta di essere nato in un certo luogo, come se fosse un merito, come se l’avesse scelto, come se dall’alto dei cieli, ancora allo stato di puro spirito, si fosse prodotto in un’attenta analisi su dove era più conveniente planare per emettere il primo vagito. E che dire dell’appellativo giargia, del dispregiativo giargia, cioè negro, profittatore, lazzarone, mangia pane a tradimento? Le parole di quel cartello le si erano appiccicate addosso, una per una.
Si ripromise di affrontarlo, un giorno in cui non fosse stata di corsa. Non per litigare, solo per chiarire. Perché non si può sempre star zitti. La sera a letto non c’era verso di prendere sonno. Almanaccava, elencava le sue buone ragioni, le sistematizzava, si costruiva in testa l’architettura di un discorso. Semplice, niente paroloni o analisi approfondite, solo un sano buon senso. Provò a ripeterselo mentalmente, così solo per il gusto di farlo, perché il sonno tardava. Le parole si concatenavano disinvolte, efficaci, fluide. E poi contava sulla sua prontezza di spirito per improvvisare. Era sicura di essere in grado di metterlo a tacere
Il mattino successivo, ovviamente, era in ritardo, aveva dormito poco e male, la testa colma di sogni ingarbugliati. Non era il caso di fermarsi a discutere. Meglio fare le cose per bene.
Pochi metri più avanti un’altra mano tesa, una mano nera. Un ragazzo, il viso sporco di giovinezza, gli occhi smarriti, appoggiato a un pilone di sostegno della pensilina, la stessa sotto cui soggiornava il bresá. L’africano era magro, tutto denti bianchi e labbra distese in un sorriso. Automaticamente lei cominciò a rovistare nella borsa alla ricerca di una moneta. Non aveva il tempo per discutere, ma sicuramente il bresá l’avrebbe vista allungare il soldo al nero e avrebbe capito da che parte stava. Alle volte i gesti sono più loquaci delle parole.
Quel giorno, durante il lavoro, altre argomentazioni le si erano affollate in testa come un fiume in piena, pronte a mettere a tacere il leghista, sicuramente un valligiano. Visitava, ricuciva ferite, ma intanto il suo cervello schiumava rabbia e costernazione e inanellava frasi: non è certo un demerito lasciare il proprio paese perché si soffre la fame. E se fossi tu oggetto di persecuzione o solo disperato, non attraverseresti il mare alla ricerca di una vita migliore? Il mondo non è proprietà di nessuno e non c’è frontiera che tenga.
Insomma pensieri basici, argomentazioni da poco.
Anche i suoi colleghi l’avevano notato. Diego, che viveva a Lumezzane, lo conosceva e lo descriveva come un impresario edile caduto in disgrazia durante la crisi economica, che non era più riuscito a rimettersi in piedi. Magari per lui avevano lavorato anche i negri. Chissà se li aveva assicurati? O magari li assicurava per tre ore e li faceva lavorare dodici. Quanti ne capitavano in pronto soccorso con ferite sanguinanti, la tuta addosso, ma pronti a giurare di non essersi infortunati sul lavoro. Non che la storia dell’autoctono non fosse triste, ma perché prendersela con i neri invece che con i banchieri e con il mondo della finanza?
A fine turno il bresá era ancora al suo posto. Chiacchierava con una coppia della sua valle, dialetto con l’esse aspirata. Con tutti i soldi che gli danno agli immigrati, e invece a noi niente sussidi. E le case popolari le danno tutte a loro, a quella gentaglia, che sono tutti delinquenti – stava dicendo, battendosi una mano su un ginocchio. Lei aveva sussultato, come colta di sorpresa dai rinforzi che ingrossavano le fila del nemico. Finse di cercare qualcosa nello zaino per origliare meglio, per prestare più attenzione e poi intervenire e dire la sua, per mettere a posto quei tre leghisti. Era il momento buono per farsi sentire. Ma da dove cominciare? Quali motivazioni avrebbero potuto arginare tante balle, tanta prosopopea, tanta aggressività? Non trovava niente di appropriato da dire. Tutte le parole che aveva messo in fila la sera prima nella sua testa e che erano risultate così sensate, erano come evaporate. Ne percepiva solo un ritmo lontano, indecifrabile. Era come se una forza oscura tenesse schiacciata a terra con violenza la sua volontà.
Bisogna rimandarli a casa loro, che tanto quelli lì non imparano niente, che poi non pagano neanche il biglietto dell’autobus e le tasse toccano tutte a noi – diceva l’altro lumezzanese con un rancore, un odio che sembrava debordargli dagli occhi.
Il sangue le pulsava alle tempie, negli occhi la collera dardeggiava: invece che parlare, li avrebbe menati tutti quanti volentieri. Cercò di sforzarsi, perché non è l’ira che risolve, perché ci si può spiegare, si può convincere anche solo mostrando la realtà per quello che è.
Si schiarì la gola, ma le parole che le frullavano in testa erano nervose, tremolanti, fuori misura, come un vociare infantile. Si muovevano nella sua mente lente come granchi impigliati in una rete. Tentavano di mettersi in ordine come i vagoni di un treno, ma cigolavano, stridevano, avanzavano a stento, inappropriate e troppo, troppo incazzate. La sua volontà s’affannava, ma si infrangeva contro un ostacolo invalicabile. L’intenzione non sapeva trasformarsi in azione.
Era stupefatta, disgustata da se stessa, dalla sua immobilità, dal suo sapere senza saper spiegare, dal suo restare impantanata nella propria irritazione a rovinarsi il fegato.
Anche quella sera non disse nulla. Nessuno di quelli che passavano e sentivano diceva nulla. Un senso di impotenza, di inettitudine la accompagnava verso casa aggrappata al suo rancore, consapevole di quanto sia difficile dire cose semplici, alzare la testa, schierarsi.
Aveva finito per desistere, pur biasimandosi: tanto non è gente con cui si possa parlare – s’era detta giustificandosi. Ma aveva guardato l’ex padroncino in faccia, giorno per giorno, con ostile disapprovazione ed evidente disprezzo. Ogni mattina, faceva platealmente cadere un soldo nella mano del ragazzo nero e così lo sfidava.
Lui, il bresá, la guardava male, lei li sentiva i suoi occhi puntati sulla schiena come lame e fra sé se la rideva. Do i soldi ai negri, ma a un padroncino leghista e bilioso niente.
Anche quell’anno le toccava il turno di Natale. Si era alzata all’alba per godersi lo stupore dei ragazzi davanti ai doni sotto l’albero, poi un caffè e via, a braccetto con il rimpianto per non poter restare in famiglia.
Anche a Natale il bresá era al suo posto, la radio accesa, seduto sulla sua sedia pieghevole. Vedendola arrivare aveva teso il braccio sogghignando, come a sfidarla. Chissà che avesse cambiato pensiero. Lei gli passò davanti con le spalle dritte e con aria spavalda, un lampo risoluto negli occhi, dispiaciuta di aver mostrato la propria irritazione e pronta ad allungare un euro all’immigrato. Il ragazzo non c’era. Socchiuse gli occhi per vederci meglio, ma quella mattina niente da fare.
All’uscita invece, al sole freddo d’inverno, l’aveva intravvisto. Solita giacca a vento sbrindellata, cappuccio tirato sulla testa, jeans leggeri per la stagione. Sorrideva, in piedi come al solito, ma pericolosamente vicino al bresá. Lei gli allungò un euro sorridendo. Lui accennò un saluto con il capo e sussurrò un ringraziamento.
S’era ringalluzzita, sentiva attenuarsi quel disagio, quel disgusto per se stessa che l’accompagnava da tempo. Sì, oggi avrebbe parlato, forte del grazie e del sorriso dello straniero, oggi avrebbe smesso di rimuginare e avrebbe aggiunto il suo mattoncino alla lotta contro il razzismo e la stupidità. Mentre chiudeva il portafogli e organizzava le idee, vide il ragazzo abbassare il cappuccio, farsi ancora più vicino al bresá, infilare una mano in tasca per estrarne un pacchetto di Marlboro malconcio, lo sentì schiarirsi la voce e dire, in un italiano stentato: ehi amico vuoi una sigaretta? Buon Natale.
