“Tutti i dolori sono sopportabili se li si inserisce in una storia o si racconta una storia su di essi.”
(Karen Blixen)
“Tutti i dolori sono sopportabili se li si inserisce in una storia o si racconta una storia su di essi.”
(Karen Blixen)
Castelvecchi ha pubblicato quest’estate il saggio che Benjamin scrisse a Ibiza, nel 1933, e che costituisce un riferimento essenziale nel romanzo di Carlo Simoni, Il miserabile: “Era incredibile – dice la protagonista del romanzo – come la depressione che lo attanagliava non gli impedisse di lavorare. Scrisse in quei giorni Esperienza e povertà. Pagine che restano per me fra le sue più toccanti, e profonde, certamente anche perché un giorno ne volle discutere con me. Il venir meno della capacità di narrare non era che la spia di una crisi più generale e profonda, quella della possibilità di vivere accumulando davvero esperienza.”

Walter Benjamin, Esperienza e povertà, a cura di Massimo palma, Castelvecchi 2018)
Più citato che letto: lo si può dire di molti autori, ma certamente l’osservazione si attaglia in modo particolare a pensatori come Walter Benjamin, la cui opera, oltretutto, è spesso ridotta a un titolo, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, così come la sua fisionomia appare fissata nei ritratti fotografici di Gisèle Freund, nei quali il suo volto si fa icona del filosofo contemporaneo, tormentosamente concentrato, un po’ com’è avvenuto ad Einstein, nell’immagine che ne ritrae l’espressione bonaria e i capelli ribelli. Un analogo processo di riduzione sembra del resto aver pesato in molte delle biografie di Benjamin, nelle quali la sua vita sembra fatalmente precipitare, e riassumersi, nella fine tragica incontrata nel 1940 a Port Bou, il paese ai piedi dei Pirenei dal quale Benjamin contava di passare in Spagna e raggiungere il porto dal quale imbarcarsi per gli Stati Uniti.
Ebreo per stirpe, comunista a suo modo, intellettuale emarginato – dall’accademia nella quale aveva cercato invano di accreditarsi, dai giornali con i quali non disdegnò di collaborare –, esule per necessità, innanzitutto, e quindi “migrante economico” (secondo la calzante definizione di Massimo Palma, il curatore di questo libro): nel personaggio si sommano le condizioni ideali per la sua “santificazione”, la santificazione del genio incompreso prima e della vittima poi.
Libri come questo servono, riproponendo scritti poco frequentati o che meritano comunque di essere riletti, a mettere in guardia contro quella che – al di là delle intenzioni – per il tramite di una facile e tutto sommato comprensibile empatia si rivela per una neutralizzazione, di fatto, della carica critica e per alcuni aspetti provocatoria del pensiero di Benjamin.
La selezione che ci viene proposta assume, alla lettura, il significato di una sequenza ragionata, dallo scopo ben preciso: Il carattere distruttivo e Scavare e ricordare, rispettivamente risalenti al 1931 e all’anno successivo, risultano premessa in qualche modo necessaria a Esperienza e povertà, del 1933, che a sua volta suona come una sintetica prova di quello che si può considerare un classico, un’opera che torna a distanza di tempo, ad ogni rilettura, a dire cose sorprendentemente attuali: è inevitabile pensare alla proliferazione di messaggi determinata dal web e alle sue conseguenze leggendo Il narratore. Considerazioni sull’opera di Nikolaj Leskov, scritto tre anni dopo.
La perentorietà, il tono che potrebbe suonare vagamente superomistico del primo scritto, così come l’icasticità e la concisione del secondo, si sciolgono in una prosa colloquiale in Esperienza e povertà, non a caso assunto come titolo dell’intera raccolta: la riflessione sul destino dell’esperienza, della crescente difficoltà di farne anche nel mondo attuale, trova alimento nel confronto con la povertà, un confronto obbligato per l’autore nella seconda estate passata a Ibiza, dove appunto il saggio venne composto. Ma la povertà di cui Benjamin parla non è tanto quella materiale, quanto piuttosto la povertà di esperienza. È l’esperienza stessa, infatti, ad essere oggi “in ribasso”, e questa svalutazione, che è insieme perdita di una risorsa essenziale per la vita, ha preso le mosse dalla Grande Guerra, dai cui campi di battaglia “la gente (tornava) ammutolita”, “non più ricca, più povera di esperienza comunicabile”. L’“impetuoso dispiegamento della tecnica” nel corso dei combattimenti aveva avviato un processo irreversibile: “un’indigenza di nuova specie”, da quei giorni, “si è abbattuta sugli uomini”, perché la povertà di esperienza è solo un aspetto di una più sostanziale e pervasiva povertà, “non solo di esperienze private, ma di esperienze umane in genere.” Non ne mancano i sintomi rivelatori: il tramonto dell’arte di narrare, in primo luogo. È questo il nesso fra questo saggio e l’altro che segue, Il narratore, ma prima di passare a quello occorre considerare lo sviluppo che questa constatazione trova in Esperienza e povertà: la perdita della capacità di far davvero esperienza si rivela “una nuova forma di barbarie”. Sennonché – ecco il Benjamin che non si lascia costringere entro le formule della deprecazione dei tempi – è possibile “introdurre un nuovo, positivo concetto di barbarie” se si sa interpretare quella stessa perdita come opportunità di “cominciare daccapo”, di “cominciare dal nuovo”, come hanno fatto del resto i grandi creatori, animati da un carattere distruttivo senza il quale non avrebbero potuto divenire “costruttori”. Così Descartes, Klee; o Brecht e Loos, il cui “segno distintivo è la totale mancanza di illusioni sull’epoca e tuttavia una professione di fede priva di scrupoli a suo favore”.
C’è qualcosa di più, in affermazioni del genere, di quanto espresso nel pessimismo dell’intelligenza, ottimismo della volontà che Gramsci poco più di un decennio prima riprendeva da Romain Rolland. Quello che entra in gioco è il significato stesso della cultura, la sua funzione: gli uomini, poveri di esperienza come ormai sono, si sono stancati della “cultura”; “l’umanità si prepara a sopravvivere alla cultura, se così deve essere.” E non si tratta di una prospettiva apocalittica, perché “quel che è importante è che lo fa ridendo”.
È questo che stava avvenendo negli anni Trenta? E sta avvenendo ancora oggi? o è già avvenuto? Le parole che concludono il saggio suscitano domande di questo genere, inquietanti, e non facilmente eludibili. Si possono ravvedere corrispondenze in esperienze come quella del Sessantotto, che innegabilmente è stato animato, anche, dalla pulsione a “far piazza pulita” – per usare ancora un’espressione di Benjamin – di una cultura oppressiva e obsoleta? Ha senso cercare analogie con il “nichilismo attivo” che secondo Umberto Galimberti serpeggia fra i giovani di oggi? o fra alcuni di loro almeno, quelli che “cercano di trasformare la crisi del mondo vitale, nel quale siamo tutti immersi, in una nuova opportunità di ridisegnare i rapporti umani, rimettendo in discussione le mappe – fisiche, mentali e sociali – trasmesse dalle precedenti generazioni”?
È dopo aver attraversato riflessioni simili che leggiamo l’ultimo saggio, il più denso e insieme il più accessibile nella sua scrittura piana ed evocativa di sensazioni che ci appartengono: chi non ha sperimentato il fatto che “Diventa sempre più raro incontrare persone che possano raccontare davvero qualcosa”? Non chiacchierare, non intrattenere, non riempire ad ogni costo un silenzio altrimenti imbarazzante o avvertito addirittura come minaccioso, ma raccontare.
Non si tratta di una superficiale evoluzione dei costumi, è ben di più: “È come se una facoltà che ci sembrava inalienabile, la più sicura tra le cose sicure, ci venisse sottratta. La facoltà di scambiarsi esperienze”, venuta meno per una ragione sostanziale: “l’esperienza è deprezzata.” E sappiamo a partire da quale catastrofico evento. Fin qui, Il narratore riprende il saggio che abbiamo letto prima, ma per andare oltre: chi sapeva narrare – contadino, marinaio o artigiano che fosse – era “un uomo che dispensa(va) consigli all’ascoltatore”, e a suo modo diffondeva “saggezza”. Ora, “l’arte della narrazione tende al termine perché l’epica della verità, la saggezza, sta morendo”, e – si badi – “nulla sarebbe più fatuo di voler ravvisare [in questo processo] unicamente un fenomeno di decadenza”. Si tratta piuttosto di rintracciarne le cause: l’“emergere del romanzo all’inizio della modernità”, in primo luogo (Don Chisciotte è la personificazione del fatto che la saggezza ha disertato la grandezza d’animo); in secondo, il dominio dell’informazione, “inconciliabile con lo spirito della narrazione”: “Ogni mattina [l’apparto dell’informazione] ci aggiorna sulle novità del globo terrestre. Eppure siamo poveri di storie degne di nota.” Il che significa: poveri di narrazioni che, a differenza delle “notizie”, durino nel tempo, mantengano la loro efficacia senza consumarsi subito. Come accade ai comunicati dei giornali e dei mass media, appunto, che – volendo parafrasare un passaggio di Scavare e ricordare – ci trasmettano soprattutto o solamente “fatti”, incapaci di restituirci il senso della nostra volontà di sapere, inevitabilmente conculcata dall’ossessione di essere informati.
Ma c’è di più, molto di più in queste pagine. Conviene limitarsi, qui, a segnalare un passaggio nodale: la morte, il morire, un tempo evento che faceva parte della vita comune – non si spiegherebbero altrimenti le scritte che si leggono sotto le meridiane, come quell’“Ultima multis” visto a Ibiza – “nel corso della modernità (è stato) espulso dall’ambiente percettivo dei viventi”. Il fatto è che proprio nelle espressioni e negli sguardi del morente, rivelatori di una “vita vissuta”, il narratore traeva la propria autorità, condividendola con quella che anche “il più povero dei diavoli” possiede nel morire; perpetuandola poi nei suoi racconti e così coltivando un’“arte” utile alla vita (come le tante ciance sullo storytelling a loro modo – un modo distorto e ambiguo, spesso maldestro – forse stanno, nonostante tutto, a testimoniare).
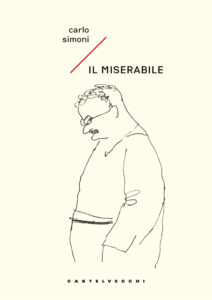
Carlo Simoni, Il miserabile, Castelvecchi 2018
“Il miserabile, “l’infelice”: così Walter Benjamin era chiamato a Ibiza nelle due estati trascorse sull’isola nei primi anni Trenta, alla vigilia del suo definitivo esilio a Parigi. Un Benjamin trasandato nell’aspetto fisico, ben lontano dall’immagine trasmessaci dalle fotografie di Gisèle Freund. Eppure, proprio in quei stessi giorni il pensatore tedesco è impegnato in letture approfondite e nell’elaborazione di scritti decisivi, mentre la sua vicenda umana, segnata da momenti di crisi profonda, si intreccia ad amicizie e ad amori incontrati nel corso del suo soggiorno. I fatti narrati in questo romanzo trovano riscontro in ricostruzioni biografiche e cronache (in particolare quella di Vicente Valero, Experiencia y pobreza) e traggono spunto dalle lettere, dai saggi e dai racconti composti da Benjamin durante i mesi trascorsi a Ibiza. I caratteri, i comportamenti e le relazioni reciproche dei personaggi, invece, sono frutto dell’immaginazione dell’autore.

Quelle che seguono sono alcune pagine tratte dal romanzo:
1.
“La stanza non ha tende alle due finestre che guardano sul porto.
Era la prima cosa che facevo una volta, in una casa nuova: cercare il tessuto, scegliere i colori, tagliare e cucire le tende, appenderle dietro i vetri. Come a stabilire un confine, fra il dentro e il fuori, fra noi e gli altri. Anche se sono sempre stata di quelli che non sanno rinunciare a guardare nelle finestre delle case, quando ci passano davanti. Dal treno soprattutto, quando è buio e rallenta o addirittura si ferma poco fuori dalle stazioni: ci si viene a trovare vicinissimi alle case, spesso, ma più in alto della strada. All’altezza del primo, o del secondo piano. All’improvviso, spettatori di fronte a piccoli palcoscenici illuminati dove donne sole aspettano, o stanno sedute col marito e i figli a tavola. Oppure spazi vuoti di persone che però si sa che sono lì, in un’altra stanza, come fossero dietro le quinte, e di lì a poco dovessero comparire sulla scena. Non si riesce a distogliere gli occhi da quelle finestre, presi come da una nostalgia improvvisa, da un rimpianto per qualcosa che ci sembra di non aver avuto, che abbiamo presentito, molto tempo fa, ma non abbiamo poi potuto vivere. Senza voler immaginare che qualcosa di straordinario possa avvenire dietro quei vetri, non vogliamo perdere un attimo del tempo che ci è concesso dalla sosta imprevista. Come se quel che vediamo stesse per rivelarci un segreto che è sempre stato a portata di mano. Una verità che ci riguarda. Vicina e pure indistinguibile.
(…) È la casualità, insieme alla relativa brevità, di quelle fermate, a farcele sentire come occasioni da non perdere, per godere a pieno quello che ci possono dare. (…) Se la sosta dura più di qualche minuto, come senza dircelo avevamo temuto, sentiamo balenare in noi, che fino a quel momento avevamo sperato si protraesse, il desiderio che il treno si rimetta in movimento: sentiamo che la compiutezza del racconto appena intravisto rischierebbe di slabbrarsi nella trama banale di un romanzo sconclusionato, alla fin fine insensato. Come la vita.”
2.
“Era uno sguardo diverso, il suo. Gli occhi ridotti a due fessure dietro le lenti spesse degli occhiali senza montatura. Azzurri e distanti, e pure luminosi, attentissimi.
Li avevo sentiti su di me la prima volta che ci eravamo seduti a uno dei tavolini che ho ritrovato tali e quali, sotto le mie finestre. Era l’unico caffè allora, sul porto.
Non li aveva distolti quando avevo ricambiato il suo sguardo, ma mi ero resa conto che non guardava esattamente me, o non solo me. Quel che avevo intorno piuttosto. Mi guardava, ma allo stesso tempo – intendo dire – sembrava vedesse qualcosa che non coincideva con il mio viso, il mio corpo, e neanche gli stava dietro. Non era uno di quegli sguardi che ti oltrepassano, che ti attraversano come fossi trasparente, il suo. Non era oltre me quello che aveva fermato i suoi occhi: era attorno a me…
Mi guardava come se, più che vedermi, mi ricordasse, anche se mai ci eravamo visti prima. Era come mi ricordasse, sì, è forse questo il modo migliore per dirlo.
Jean aveva seguito il mio sguardo e, inaspettatamente, aveva raggiunto quell’uomo che, alzandosi dalla sedia aveva fatto a mio marito un piccolo, curioso inchino. Mi era parso un modo, più che affettato, un po’ stravagante di salutare.
Quando vennero da me e Jean me lo presentò, quella luce si era già spenta.
I suoi occhi erano distanti mentre, un po’ goffamente, accennava un baciamano.
(…) Nella lentezza di quell’uomo, nella sua trasandatezza, nella gentilezza un po’ antiquata che si distingueva a mala pena dall’indecisione che rallentava ogni suo movimento, ebbi subito la sensazione che si nascondesse uno spirito del tutto diverso: quel brillio degli occhi, quello sguardo penetrante che mi era capitato di vedergli la prima volta che l’avevo incontrato mi facevano supporre in lui un pensiero sempre al lavoro, una risolutezza di idee che smentiva la sua timidezza con gli altri, una passione di capire che non restava confinata ai libri, ma lo accompagnava in ogni momento. E non poteva non intralciarlo nella vita d’ogni giorno, quando era fra la gente.”
3.
Ero incuriosita di sapere dove andasse con i due o tre libri che si portava sottobraccio, l’altra mano occupata da una coperta che si era svolta e strisciava con un lembo per terra. Lo vidi scomparire fra gli alberi, ma non mi fermai. Camminavo con circospezione, per il timore di calpestare qualche rametto e farmi sentire. Credevo d’averne perso le tracce quando mi affacciai su una minuscola radura: era lì, e leggeva, seduto sulla sua coperta, la schiena poggiata al tronco di un pino, due libri accanto, fra l’erba, e su quelli un quadernetto aperto. Lo vedevo di tre quarti, lui non aveva avvertito la mia presenza. Leggeva, assorto, colla mano a far visiera sopra l’occhio destro, e fumava la pipa, spegnendo accuratamente il fiammifero e mettendoselo poi nella tasca della giacca, ad evitare che la minima brace potesse propagare il fuoco nel bosco. Già, era in giacca camicia e cravatta anche lì, per quanto malandate.
Di tanto in tanto interrompeva la lettura e volgeva gli occhi verso l’alto, tra le chiome degli alberi. Restava così a lungo, come immaginasse – pensai io – di poter essere lassù, fra le fronde che ondeggiavano alla brezza, a guardare il mare. Si spostò a un certo punto e, stesa la coperta sull’erba, ci si sdraiò, restando immobile, con gli occhi aperti però – riuscivo a distinguerlo – sulle foglie dell’albero sotto il quale si era steso. Poi si alzò. Ripiegò la coperta e si rimise seduto prendendo a scrivere sul suo quaderno, interrompendosi tuttavia di tanto in tanto a guardare ancora in alto, come a verificare la giustezza di quel che andava scrivendo confrontandolo con quel che aveva visto e vedeva lassù, e che tuttora lo rapiva, si sarebbe detto, tanto che sembrava distogliersene a malincuore, per ricominciare a scrivere. Quel guardare in alto, fra gli alberi, quell’essersi immaginato lassù fra le fronde, a tu per tu con gli uccelli che vi sostavano, sembrava dargli nuova ispirazione. Tornò poi al libro e dopo qualche minuto di lettura scrisse qualcosa nei margini della pagina. Ripose quindi la stilografica nel taschino della giacca e si mise a scartabellare fra le pagine di un altro dei volumi che s’era portato.
Mi fu chiaro in quel momento da dove gli venisse la calma che avevo sentito in lui, nelle sue parole. Era in un luogo come quello, in quel modo di stare che trovava la quiete, una quiete laboriosa, meditativa, feconda, e lui se l’era costruita, a Ibiza come dovunque il suo ininterrotto peregrinare l’aveva e l’avrebbe portato: camere d’albergo, stanze in affitto, case d’amici, tavolini di caffè, scompartimenti di treni.”

Se vuoi leggere il libro nella sua interezza lo puoi acquistare alla nuova libreria Rinascita di Brescia (14 euro).
Via della Posta, 7 – 25121, Brescia
Tel. 0303755394
libri@nlr.plus
Vedi la scheda del libro sul sito dell’editore, cliccando qui.

Dal Giornale di Brescia del 29 settembre 2018.
Clicca sull’immagine per visualizzare l’articolo.

Da Bresciaoggi del 9 novembre 2018.
Clicca sull’immagine per visualizzare l’articolo.

Dal Corriere dell’8 novembre 2018.
Clicca sull’immagine per visualizzare l’articolo.

“Per ordinare e capire chi noi siamo dobbiamo raccontarci.”
(Antonio Tabucchi)

Paolo Giordano, Divorare il cielo, Einaudi 2018 (pp. 433, euro 22)
Storia di un amore che dura una vita, breve, perché di giovani si tratta: Teresa, Bern e gli altri ragazzi protagonisti del romanzo.
Un amore difficile, tragico alla fine, quello di Teresa, segnato fin dall’inizio da un’ombra, dall’inseparabilità della tristezza dall’affetto. Del resto, Bern – eroe solitario e introverso della storia – finirà per essere uno che “aveva creduto in tutto e smesso di credere in tutto”.
E di credere, di credere davvero in qualcosa questi ragazzi hanno un bisogno disperato, che si tratti d’una fede religiosa totalizzante che affratella gli spiriti, della fusione dei corpi nell’amore e nel sesso vissuti all’insegna della libertà più trasgressiva, della pacificazione con la natura perseguita attraverso un’“agricoltura del non fare” o con i mezzi dell’ecologismo più estremo.
In ogni caso, sentimenti ambivalenti, gelosie e rivalità attraversano la comune, e la vita non sembra rivelare il senso che si cercava: non si può non constatare che “sceglie senza scegliere – la vita –, germoglia in un posto piuttosto che altrove, a caso.” Forse, allora, tanto vale “smettere di pensare” e “affidarsi alla sequenza dei gesti”, per il resto della vita, ogni giorno…

Ci si affeziona ai personaggi di questa storia, alla loro verità, senza tuttavia essere abbandonati dalla sensazione che quella che si racconta sia una vicenda in qualche modo datata, che avremmo potuto leggere una ventina d’anni fa, e non aiuta il fatto che proceda faticosamente, a tratti, con ritorni e riprese di cui non sempre si coglie la logica, e la necessità…
Questo testo compare anche nel sito della nuova libreria Rinascita di Brescia, alle cui attività culturali Carlo Simoni collabora
“Per far qualcosa di buono, si deve esser giù di corda per un lungo periodo. Il che può prendere la forma della depressione o semplicemente del fatto che nulla succeda. La vita procede: si fa ogni mattina colazione, si lavora, non si ha nessun sogno interessante e il tutto è solo noia assoluta. Sterilità. Non accade nulla… Addirittura, tendo a diffidare di quello che scrivo quando non ho prima una depressione. So che è roba di poco valore, che non viene veramente, per così dire, dalla pancia.”
(Marie-Louise von Franz)

Bruno Latour, Tracciare la rotta. Come orientarsi in politica, Raffaello Cortina Editore 2018 (pp. 142, euro 13)
“Dopo gli anni Ottanta, le classi dirigenti non aspirano più a dirigere ma si mettono al riparo, al di fuori del mondo”: questo il primo dato di fatto.
Aspetto decisivo di quella “grande regressione” di cui voci diverse cercavano di definire i contorni in un libro di cui ci si è occupati lo scorso 10 settembre (La grande regressione. Quindici intellettuali da tutto il mondo spiegano la crisi del nostro tempo a cura di Heinrich Geiselberger, Feltrinelli 2017).
Secondo dato imprescindibile: “non si possono comprendere le posizioni politiche assunte da cinquant’anni a questa parte se non si assegna un posto centrale alla questione del clima e della sua negazione”. Esplosione delle diseguaglianze, deregulation, nazionalismi e populismi è di qui che prendono le mosse: il negazionismo della crisi ambientale da parte di coloro che potrebbero farne il perno di scelte politiche all’altezza dei tempi, così come la rimozione di essa, o lo stato di negazione in cui la maggioranza vive, sono il fulcro dell’attuale inedita involuzione. Lo stesso convincimento che abbiamo trovato in uno scrittore come Amitav Ghosh (La grande cecità. Il cambiamento climatico e l’impensabile, Neri Pozza 2017, segnalato lo scorso 17 settembre).
Trump non è un irresponsabile sfuggito di mano ai poteri forti: il suo ritiro dall’accordo sulla limitazione dei gas serra è la conseguenza di scelte precise e l’espressione di una cultura diffusa.
E vincente, a quanto pare. Destra e Sinistra, di fronte al “Nuovo Regime Climatico” – così lo definisce Latour a sottolinearne la portata epocale – hanno al fondo condiviso l’idea di un progresso che nella globalizzazione, al di là delle posizioni assunte nei suoi confronti, individuava il proprio orizzonte: “siamo tutti quietisti climatici dal momento che speriamo che, senza far nulla, tutto alla fine si aggiusterà”, ed evitiamo di interrogarci “quale sia l’effetto, sul nostro stato mentale, delle notizie relative alle condizioni del pianeta che ascoltiamo tutti i giorni.” Di fatto, e al di là delle intenzioni, mescolandoci a “coloro che si nascondono dietro Trump” e “hanno deciso di far sognare ancora qualche anno l’America ritardando l’impatto con il suolo – con la reale situazione del pianeta – e trascinando così gli altri paesi nel’abisso, forse definitivamente”.

Occorre aprire gli occhi: “il pianeta è troppo piccolo e limitato per il globo della globalizzazione; ed è troppo grande, troppo dinamico e complesso per essere contenuto nelle frontiere ristrette e limitate di qualsivoglia località”.
Come spesso accade in discorsi del genere, la pars destruens appare fatalmente più convincente della construens, cui l’autore si dedica soprattutto nella seconda parte del suo saggio (ricorrendo a formalizzazioni che non giovano alla chiarezza).
Quel che resta dalla lettura, comunque, è certamente un’indicazione sostanziale: inutile parlare di rifondazioni della sfera politica, della mentalità e dell’agire collettivi, restando entro i limiti angusti entro i quali la politica stessa – o quel che generalmente si intende con questo termine – si è ridotta.
Questo testo compare anche nel sito della nuova libreria Rinascita di Brescia, alle cui attività culturali Carlo Simoni collabora
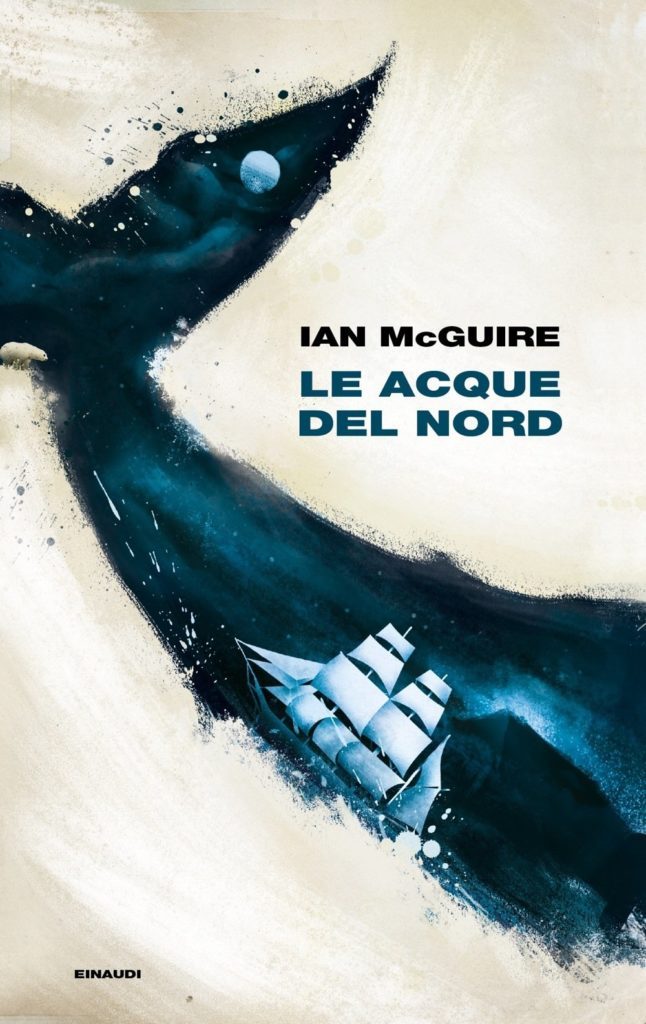
Ian McGuire, Le acque del Nord, Einaudi 2018 (pp. 278, euro 19,50)
“Azzanna il mondo come un cane morde l’osso. Niente gli è oscuro, niente è alieno ai suoi foschi e feroci appetiti”: è Henry Drax, il personaggio che irrompe nelle prime pagine di questo romanzo, che da subito attirano il lettore in un mondo dai colori lividi e dagli odori sgradevoli fino alla nausea.
Qualcuno ha evocato Dickens, Conrad, e naturalmente Melville (essendo quello della caccia alle balene l’ambiente in cui la storia si svolge): richiami pertinenti, a patto che ciascuno di questi autori sia rivisitato secondo un gusto pulp che sconfina spesso nell’horror. Eppure, la storia non è priva di elementi letterari e di riferimenti psicologici di spessore, così come la scrittura è precisa, efficace, ricca di immagini e capace di sintesi folgoranti. Anche perché a Drax, personificazione del Male e di una disumanità che non conosce sensi di colpa o tentennamenti dettati dalla compassione, subentra dal secondo capitolo e tiene a lungo la scena Patrick Sumner. Non il buono contrapposto al cattivo: anche in Sumner – medico con un passato in India che nell’imbarco su una baleniera diretta nel mare artico cerca di cancellare la sua vita precedente – si annidano ombre e s’è ormai radicato un pessimismo senza ritorno: “contano solo le azioni, solo gli eventi. (…) Pensare troppo è un grave errore. La vita non è decifrabile, non si può assoggettarla a forza di chiacchiere, occorre viverla, sopravviverle, in tutti i modi possibili”. Il che non toglie che lui tenga nella sua cuccetta una copia dell’Iliade, e – quando non è sotto l’effetto del laudano, al quale da oppiomane incallito è uso ricorrere – legga attentamente quel libro, lasciando credere agli altri di essere intento a pregare.
La navigazione si svolge in un ambiente via via più ostile, e gli avvistamenti sono rari. I tempi sono critici per i balenieri, soprattutto per quelli che non dispongono di una nave a vapore e lanciarpioni moderni, e del resto – siamo all’inizio della seconda metà dell’800 – “l’olio di balena non lo vuole più nessuno. Sono tutti pazzi per il petrolio e per il gas illuminante”. Questo non impedisce che la caccia si svolga, dando adito ad alcune fra le scene più feroci: dalla strage di foche, i cui piccoli vengono uccisi a bastonate, a quella di una balena che, morendo dopo una lunga lotta, crivellata dagli arpioni, “spruzza in aria un alto pennacchio di sangue cardiaco e poi si inclina su un fianco, la grande pinna sollevata come una bandiera di resa.”
A lungo mimetizzato fra i marinai dell’equipaggio, Drax riappare, e il suo ritorno coincide con la fine di un giovane mozzo, violentato, strangolato, cacciato a forza in fondo a un barile: uno Stevenson alla rovescia, in cui il ragazzo (viene alla mente il Jim dell’Isola del tesoro), non trova in quel nascondiglio l’occasione per smascherare gli ammutinati e divenir protagonista della storia, ma la propria tomba, misera e puzzolente. Proprio il dottore, Sumner, riesce a dimostrare che Drax e non altri è il perverso assassino del povero Joseph, ma a questo punto è l’imprigionamento della nave fra i ghiacci a balzare in primo piano, e qui il racconto sembra prendere a prestito più di un elemento da un altro romanzo, La scomparsa dell’ Erebus di Dan Simmons, del 2007, la cui vicenda ha guadagnato notorietà soprattutto grazie alla serie televisiva che ne è stata tratta e diffusa pochi mesi fa: The Terror.

E’ questo riferimento a rendere ancor più evidente come lo stile della narrazione sia assimilabile a quello di una sceneggiatura, condotta com’è sempre al presente, per frasi brevi, secondo un modulo descrittivo che richiama la distanza imperturbabile dell’occhio della cinepresa.
Un romanzo che si direbbe prefiguri la propria mise en scène, dunque; fedele alle regole della narrazione per immagini anche nel riproporne puntualmente di forti e coinvolgenti, fino alla fine, quando la storia sembrava ormai conclusa e trova invece un ulteriore imprevisto, intrigante sviluppo.
Questo testo compare anche nel sito della nuova libreria Rinascita di Brescia, alle cui attività culturali Carlo Simoni collabora
“(…) ogni autentico scrittore è splendidamente monotono, in quanto nelle sue pagine vige uno stampo ricorrente, una legge formale di fantasia che trasforma il più diverso materiale in figure e situazioni che sono sempre press’a poco le stesse.”
(Cesare Pavese)
“Noi autori dobbiamo ripeterci: questa è la verità. Abbiamo due o tre grandi esperienze commoventi nella vita: esperienze così grandi e commoventi che mentre le abbiamo ci pare che nessun altro sia mai stato prima di noi così inghiottito e colpito e sorpreso e sbalordito e sconfitto e distrutto e recuperato e illuminato e ricompensato e umiliato. Poi impariamo il nostro mestiere, bene o meno bene, e raccontiamo le nostre due o tre storie – ogni volta in un nuovo travestimento – forse dieci volte, forse cento, fino a quando la gente ci ascolta.”
(F. Scott Fitzgerald)
“(…) raccogli la gran parte della tua esperienza da bambino (…). E poi quando scrivi la trasferisci ad altre situazioni.”
(Flannery O’Connor)
“Si dice che chi scrive sia emulo dell’infelice Narciso. Ma, se scrive, ne ha superato la malattia: è capace con la mano di turbare l’immagine del proprio volto riflesso, senza più pena. Reinventandosi.”
(Duccio Demetrio)
“Ai tempi nostri il romanzo storico, o quello che per comodità si vuol chiamare così, non può essere che immerso in un tempo ritrovato: la presa di possesso d’un mondo interiore.”
(Marguerite Yourcenar)
“Essere scrittori significa prendere coscienza delle ferite segrete che portiamo dentro di noi, ferite così segrete che noi stessi ne siamo a malapena consapevoli, esplorarle pazientemente, studiarle, illuminarle e fare di queste ferite e di questi dolori una parte della nostra scrittura e della nostra identità.”
(Orhan Pamuk)
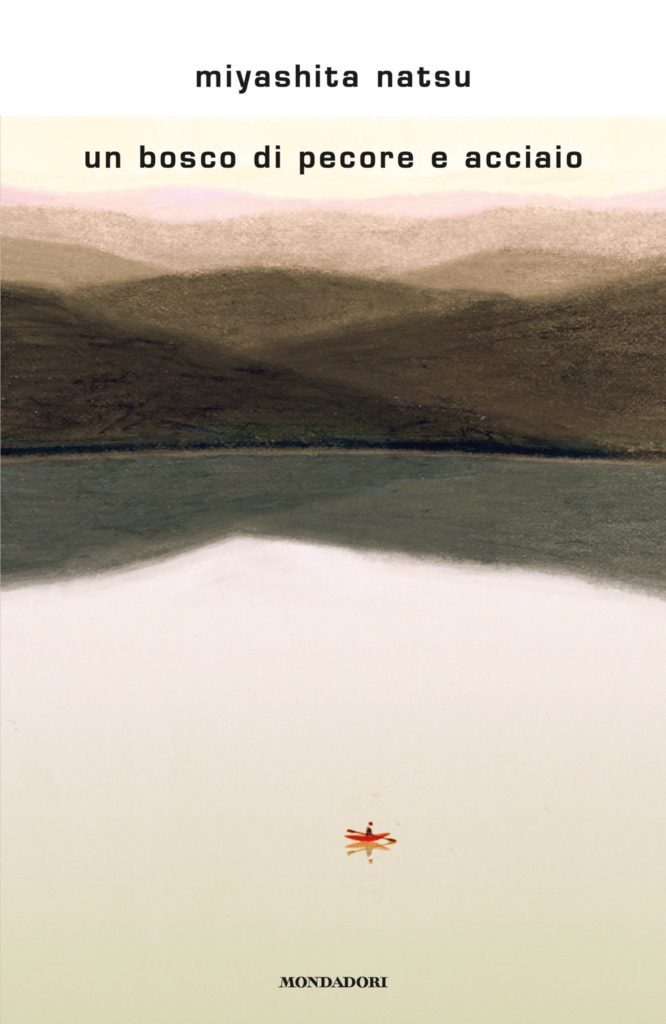
Miyashita Natsu, Un bosco di pecore e acciaio, Mondadori 2018 (pp. 209, euro 19,50)
E’ la storia di formazione di Tomura, giovane di montagna che scende alla città per studiare e poi trovar lavoro. Ma è un ragazzo particolare: sente l’odore a lui ben noto del bosco quando si avvicina a un pianoforte, ed è per questo che di pianoforti si occuperà diventando un accordatore.
Un mestiere che lo terrà a contatto con “l’oggetto prodigioso che riesce a scovare la bellezza diffusa nel creato e a darle una forma che giunga alle orecchie”: pur essendo “uno strumento indipendente, con una sua propria personalità” ogni pianoforte capta la musica che è diffusa nel mondo, a patto che sia passato per le mani di un accordatore provetto. Solo allora potrà emettere “un suono di una limpidità luminosa e quieta, carico di nostalgia”, “dolce, fino a un certo punto” ma anche “pieno di severità e profondità”, “bello come il sogno, ma certo come la realtà”. Il buon accordatore si accosta al pianoforte come a una creatura viva, e quindi unica, ma deve anche tener conto del carattere di chi lo suonerà.
Ecco il punto: non si tratta solo di tecnica. Che si tratti di fabbricare dolci o di accordare pianoforti conoscere i segreti del mestiere non è tutto: Natsu come Sukegawa, l’autore di cui in questi appunti si è parlato lo scorso aprile (Le ricette della signora Tokue). Al pasticcere occorre il “sentimento” che lo porta a considerare i fagioli che cucina uno ad uno, ad ascoltarli; non diversamente l’accordatore non può non sentire “respirare” lo strumento di cui si prende cura. Si tratta in ogni caso di una vicinanza, di una pietas per le cose inanimate che appare condizione di una compassione più vasta, di una capacità di stare nei panni degli altri e di comprenderli. Pianoforte, pianista e accordatore sono tutt’uno: chi prepara lo strumento cerca “il suono che più mette in risalto l’abilità del pianista.
Nessuno pensa all’abilità dell’accordatore. E va bene così”, perché “anche se è il pianista a ricevere gli elogi, non è nemmeno merito suo: il merito è della musica.”

Tomura osserva i suoi colleghi più esperti, si mette alla prova, apprensivo e appassionato. E capisce: che lo si suoni, il piano, o lo si accordi, occorre “sforzarsi ma senza sentire lo sforzo, con pazienza ma senza sentire di doverla esercitare. Quando si è consapevoli dello sforzo che si compie, esso finisce per essere solo un investimento che si vorrebbe veder ripagato.” Occorre andare oltre: “Se si riesce a non vedere lo sforzo come investimento, allora le possibilità aumentano oltre l’immaginabile.” E’ la sapienza che occorre a chi tira con l’arco, a chi medita, a chi semplicemente vuole vivere davvero la propria vita: “ L’uomo è un essere pensante, ma le sue grandi opere vengono compiute quando non calcola e non pensa”, diceva Eugen Herrigel (Lo zen e il tiro con l’arco, Adelphi 1987). Ma non è tutto: è necessario anche, perseguendo la perfezione, esser consapevoli che non la si raggiungerà, e dunque è “rassegnazione” che occorre, senso del limite.
Quando attraverso la sua esperienza Tomura capirà anche questo, potrà camminare sereno nel bosco di cui aveva sentito il profumo avvicinandosi a un pianoforte, bosco di pecore e acciaio, strumento che racchiude lana di pecora nella copertura dei suoi martelletti e acciaio nelle corde che attendono la mano dell’accordatore per raggiungere la giusta tensione e quella del pianista per connettersi alla musica che permea il mondo.
Questo testo compare anche nel sito della nuova libreria Rinascita di Brescia, alle cui attività culturali Carlo Simoni collabora
“Per pura coincidenza sono diventato un romanziere, non è che ho scoperto la vocazione,come dice chi è del ramo. Finché non ho scritto il primo romanzo non ce l’avevo proprio l’idea di saperlo fare.”
(Maurizio Maggiani)

Cristina Comencini, Da soli, Einaudi 2018 (pp. 168, euro 18)
Dopo una trentina d’anni di convivenza si separano: tra Laura e Piero ad andarsene è lui; tra Marta e Andrea è lei.
Niente di strano: “Il nostro mondo è fatto di separazioni, di individui liberi e soli. Lo sarà sempre di più.” Ma perché? Le voci dei quattro personaggi si alternano nei capitoli, e mentre raccontano, più o meno consapevolmente propongono una risposta.

Può essere la paura della morte a suscitare il desiderio di andarsene: “una storia dall’inizio alla fine è la morte”. Ma anche la solitudine può scatenare la stessa paura: “La nostra vita mi pareva una costruzione invincibile, e la fine della nostra vita individuale una cosa semplice e naturale. Ora invece ho paura di morire. E’ la mancanza di felicità che mi fa venire paura della morte.” E se si trattasse invece di paura di vivere? se fosse una sorta di precauzione quella che induce a “non legarsi, a non vivere emozioni troppo intense”?
O forse non si tratta né dell’una né dell’altra cosa: al fondo della crisi della coppia c’è la coppia stessa, anche se sembra che a minare la sua unione possa essere l’usura della vita a due, fino al suo svuotamento, o all’opposto l’eccesso di condivisione…

Sta di fatto che la singletudine sembra diffondersi come una “malattia contagiosa”: “le ditte ora fabbricano confezioni singole, uno di tutto”, gli arredatori studiano le condizioni che garantiranno il benessere a un singolo abitante della casa. Del resto, “la famiglia oggi è questo: genitori single con figli”. Ma, appunto, perché? che cosa ci è successo? Il fatto è che “forse non esiste proprio più la possibilità di essere un noi. C’è un io che incontra un altri io e restano sempre solo due io, punto e basta, anche se fanno figli e vivono un po’ insieme.” Poi… Poi ognuno per la sua strada, anche se, a ben vedere, non ci si lascia mai del tutto, mai davvero, e nessuno è vincitore, neanche quello che ha deciso lo strappo. Forse perché una donna lo sa, “si è la moglie di un solo uomo”. E lui, l’uomo? scoprirà di essere, anche lui, marito di una sola donna?
Domande che restano aperte, in un mondo nel quale “non c’è niente di più incongruo e antimoderno che amare una sola persona per tutta la vita”. E allora “L’essenziale è non avere una sola vita, non chiudere gli occhi con l’idea di una linea continua”…
Questo testo compare anche nel sito della nuova libreria Rinascita di Brescia, alle cui attività culturali Carlo Simoni collabora
“Per scrivere serve il silenzio fuori ma la vita dentro (…) ho scelto di stare sola, ma sento le voci della mia grande famiglia ora dispersa.”
(Cristina Comencini)

Maurizio Maggiani, Luigi Verdi, Sempre, Chiarelettere 2018 (pp. 176, euro 15)
Maurizio, lo scrittore non è credente (è un “anarco-mazziniano, se proprio deve darsi una definizione): “sono senza Dio – ribadisce -. Io non ce l’ho Dio. Ho due biciclette, non ho Dio”.
Ma fa lo stesso: “non sono cattolico, ma non per questo non ho diritto di accedere al sacro.” O ancora: “Io sono senza Dio, però sono cristiano”.
Luigi, il prete, è di quelli che non amano il catechismo: “non sopporto l’atteggiamento per cui a ogni domanda deve seguire una risposta. Sono convinto invece che in molte situazioni della vita sia importante abitare le domande, stare nella domanda”.
Aggiungi che lo scrittore, a detta del prete, “in quest’epoca di comunicazioni virtuali e frettolose, è un maestro del raccontare e l’incontro fra i due è assicurato. Di lì nasce un libro come questo, che “ha un precedente nella voce e nel racconto orale”. Un dialogo insomma. Il dialogo di due uomini che hanno fatto cammini diversi ma hanno una provenienza comune: la terra, le campagne e la loro miseria, ma anche l’attitudine che sapevano ispirare: la passione per la bellezza, la capacità di vederla ovunque, sempre. E sempre è la parola scritta su un muro che compare in copertina, a far da titolo al libro, perché “sempre è una culla, se ti metti lì dentro sei al sicuro. La parola scritta su quel muro rappresenta la materia dell’impossibile, la materia dall’assoluto, la materia dell’incommensurabile, la materia del sacro.” E’ così che procede questo libro, per illuminazioni, cui subentrano ragionamenti da cui germogliano altre illuminazioni, senza troppe preoccupazioni di coerenza: “Se hai fiducia in quello che dici, non è che devi spiegarlo troppo”, e dunque, “lettore, prendi tutto quello che abbiamo detto e dagli aria, fallo respirare, segui il suo respiro.” Segui i due amici come fossi seduto lì con loro – alla pieve di Romena, nel Casentino – convinto, come loro, che “un amico non ingabbia. Ti mette le ali”. Basta andargli dietro, e dire la tua: ne può venire un dialogo che è inventario delle parole che contano perché nominano le cose che contano, nella vita. Parole da trattare con rispetto, quale che sia il tuo mestiere: “Sarò sacrilego ma io quando la mattina mi metto al computer segno lo schermo [ci faccio il segno della croce] perché voglio avere coscienza che non sto scrivendo per me che magari ho l’ansia, io sto prendendo la parola che non è una mia proprietà. Io non sono padrone delle parole, sono ministro delle parole. Questa è la prima cosa. Un romanziere e un sacerdote devono segnarsi prima di cominciare la liturgia della parola, che sia un romanzo o che sia la lettura dei testi sacri.”

Non si può dar conto del divagare continuo di queste pagine. Solo pescare qualcuno dei passaggi che restano in mente a lettura conclusa: “Impara a lasciare le cose prima che le cose lascino te” (e viene in mente il Bianchi che abbiamo letto di recente, quello che parla di vecchiaia in La vita e i giorni, Il Mulino 2018). Oppure: “Preparare il cibo per offrirlo è un gesto da funzionario del sacro”, perché “il cibo è intimità, è qualcosa che diventa parte di te” e “Cristo – con l’Ultima cena – ha scelto proprio l’occasione migliore per chiudere.” L’Ultima cena, e tanti altri momenti del Vangelo: è anche una rilettura del Vangelo questo libro, una riappropriazione dei suo momenti, dei suoi significati più umani.
E la morte? Non poteva certo mancare questa nel catalogo delle parole di Maggiani, che naturalmente ne trae una specie di racconto: “I malvagi spariscono, si disintegrano, si annullano nella spazzatura. I giusti vivranno per sempre. Guarda, Gigi, è morta la mamma di mia moglie, donna di carattere che te la raccomando, però evidentemente era una giusta perché dopo la sua morte io ho visto che cos’è la vita eterna. Ho visto la figlia appropriarsi della madre, si mette gli stessi vestiti, la ricorda nelle frasi, e lo fa in un modo talmente familiare, in un modo talmente naturale che non è vero che non c’è più, c’è in mille cose, in mille occasioni della giornata.”
Non parlano, Maggiani e Verdi, di idee, ma di esperienze fatte. Esperienze vere però, perché occorre distinguere: “oggi in nome dell’esperienza hai mano libera per fare quello che vuoi. Sai, ho fatto un’esperienza del deserto, ho fatto un’esperienza con gli extracomunitari… tutta un’esperienza.” Come se la realtà fosse una “scena che attende il tuo ingresso”. Non è così: “tanto per cominciare chiedi permesso, prima di fare un’esperienza fermati un attimo e chiedi: permesso, posso?” Altrimenti “prendi e butti via, tocchi e non approfondisci mai niente…”.
Qualche mese fa Maggiani annunciava l’interruzione di Vivario, la sua rubrica sul Sole 24ore della domenica, dicendo che aveva da fare, doveva scrivere un libro: se è questo, ne valeva la pena.
Questo testo compare anche nel sito della nuova libreria Rinascita di Brescia, alle cui attività culturali Carlo Simoni collabora

Fratelli è il primo libro che ho scritto, nel 2007: solo uno dei racconti che lo compongono (L’esperienza) è stato pubblicato. Secondorizzonte – inaugurando la produzione di libri non solo nel formato cartaceo ma anche in quello elettronico – lo propone ora nella sua interezza nella forma del pdf e dell’epub, entrambi scaricabili gratuitamente.
Scrivere Fratelli ha significato per me vivere per la prima volta l’esperienza, sorprendente, di delineare personaggi e vederli acquisire poco a poco consistenza e autonomia: uomini e donne che si definiscono nella loro individualità e a un certo punto agiscono coerentemente con questa, quasi in forza di una necessità, come se chi ne scrive si facesse a tratti spettatore delle loro scelte.
Alla sorpresa è seguita l’affezione, e il desiderio che la loro storia non finisse con il racconto che li aveva visti protagonisti ma proseguisse, rimanesse in qualche modo aperta. Non solo: si è aggiunto anche il desiderio che non si disperdessero, e che, come questo libro li aveva riuniti, la narrazione potesse creare per loro anche un luogo nel quale fosse loro possibile conoscersi, consolarsi reciprocamente di quanto loro accaduto.
È così che, quando il lavoro di scrittura poteva sembrare concluso, sono nati il cortile e la casa che compaiono nelle prime pagine e nelle ultime. Non sappiamo come è nata la piccola comunità che ci vive, né se resterà unita. Quel che conta è che un’altra storia, Cortile, divisa com’è in due parti che racchiudono i cinque racconti, ci assicuri che la vicenda dei nostri personaggi è continuata e continuerà, mantenendo il segno che l’ha fin dall’inizio connotata: il segno che imprime nelle vite il rapporto coi fratelli. È questo il tema che unisce questi racconti: il rapporto tra fratelli, quella sorta di palestra della socialità a venire che si offre sin dalla prima infanzia alla maggior parte delle persone e lascia tracce spesso indelebili nel loro modo di instaurare in seguito le relazioni con gli altri, di individuarvi una fonte essenziale o invece un ostacolo perturbante sul cammino che costruire se stessi e la propria vita impone.
Il testo può essere scaricato gratuitamente, ma non modificato né riprodotto per usi diversi dalla diffusione entro una cerchia di lettori. Nel caso lo si voglia utilizzare per altri scopi si prega di contattare l’indirizzo info@secondorizzonte.it
Per scaricare il testo di Fratelli nel formato desiderato, clicca sull’icona:
Quelli che seguono sono brani tratti da alcuni dei racconti
Da Viaggio al Marocco
(…) lì, sulla terrazza, c’era la pecora. Anzi, un montone, adulto. Aveva le zampe legate, era disteso su un fianco.
Il vecchio l’ha sollevato tirandolo su con una corda che finiva con un uncino. L’ha messo a testa in giù.
Noi eravamo col cuore in gola a vedere quel montone che gridava i suoi belati e guardava per terra. Sulla terrazza, in pieno sole.
Zac. Un colpo solo. Aveva tirato fuori un coltello lungo, da una tasca dei pantaloni, larghi, stretti alle caviglie, e gli aveva dato un colpo di taglio alla gola, senza metterci forza, sembrava.
Un lungo sospiro. Invece dei belati un lungo sospiro. E gli occhi adesso guardavano il fiume di sangue che sgorgava e inondava il terrazzo, perché la canalina che girava intorno alla terrazza non bastava a raccoglierlo. Un rivolo è sceso addirittura per le scale.
Poi il vecchio, con lo stesso coltello ha cominciato a togliere la pelle all’animale.
(…) Insomma, non so come dirti: non mi sembrava una morte violenta, ci credi? (…) Il montone non si era disperato. Non aveva fatto a tempo, dici tu. Certo. Però non era solo questo. Era morto con dignità, senza avvilirsi. Ecco. Senza doversi avvilire. E disperare. Io la carne la mangerò sempre, mi sa… anche tu? Appunto, non è questione di essere vegetariani. Però vederlo l’animale, vedere come succede che diventa… carne. Hai capito?
Be’ insomma, il papà dei ragazzi e il montone a me non sembravano la vittima e il boia. Mi sembravano due vecchi, che sanno tutt’e due come va a finire.
—
Da Gli artisti
Il rumore delle barre incandescenti che escono dal forno, e come animali ancora vivi si lasciano guidare fino al treno di laminazione, e dopo non sono più la stessa cosa. Fredde, pesanti, rigide.
Adesso, da casa, qui in cima al paese, le sento, nel buio. La fabbrica è là in fondo. Non smette mai.
Io le ho viste. So che erano già morte anche quando si muovevano. Ero io a farle muovere. Schiacciavo il bottone che faceva girare i rulli, e loro obbedivano, lente, come animali che si trascinano perché li pungoli. Ma sono già andati.
Poi però sono venuto via dal laminatoio. Ero ancora vivo, io.
I suoni sono sempre quelli. Anche di giorno. Magari passano ore che ti sembra di non sentirli. Poi ti capita di sentirli di nuovo, improvvisamente, ma te ne dimentichi subito, di giorno. Invece la notte ti stanno addosso.
Succedeva così anche allora.
Tutto, qui, è rimasto come prima.
Anche se io sono stato via. Anni. Per anni sono andato e tornato.
In Arabia, nei pozzi di petrolio. A dormire con gente che non si capiva cosa diceva. Ubriachi. Che sognavano e gridavano nel sonno, e il giorno dopo gridavano ancora, anche da svegli, e non si capiva cosa dicevano.
E poi in Australia. A lavorare nelle vigne, come queste che ci sono intorno al paese. E le donne, che venivano da me e poi andavano, senza chiedere niente.
E intanto lui, Diego, era qui. Era rimasto qui, lui. L’artista, lo chiamavano tutti. Anche quelli di fuori: quando uno arrivava in paese chiedeva dove sta l’artista? L’artista? gli rispondevano: su, in cima al paese. E così anch’io adesso, e gli altri della famiglia, ci chiamano gli artisti. Anche se solo io faccio ancora delle cose, come faceva Diego.
Non capita più che chiedano dove sta l’artista. Però siamo gli artisti: tutte le famiglie hanno un soprannome qui. Questo dev’essere l’ultimo che è saltato fuori. continua a leggere
“Son tornato da una guerra. Ho avuto una buona moglie e bravi figli. Ho scritto libri. Ho fatto legna. Me basta e vanza. ’Desso posso morir in pase.”
(Mario Rigoni Stern)