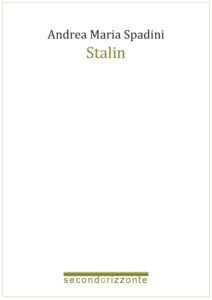
Mi è sempre piaciuto gironzolare tra gli scaffali delle librerie. Il più delle volte non ho un’intenzione precisa, quasi mai sono alla ricerca di un certo titolo o di un particolare autore. Preferisco guardarmi intorno, in cerca di ispirazione. Con metodo, però. Prima gli espositori delle novità, poi le mensole che reggono il peso dei classici. Quando la copertina di un libro attira la mia attenzione, variabile a seconda dell’umore del giorno, mi ci soffermo, guardo chi lo ha scritto, leggo il retro o la quarta di copertina. Se mi intriga lancio un’occhiata al prezzo, lo annoto mentalmente e proseguo nel mio sopraluogo. Di solito completo il tour prima di decidere cosa e se acquistare, ma è raro che io esca senza almeno un titolo sottobraccio. Quando mi capita di incrociare la nuova pubblicazione di uno dei miei autori preferiti, la scelta può rivelarsi più rapida, ma non è questa la norma e non sono molti gli scrittori a cui riconosco questo privilegio.
E poi ci sono i libri che fanno eccezione. Quelli che, per una ragione tutta loro, non vogliono stare alle regole, che quando mi arrivano tra le mani si rifiutano di abbandonarle, che reclamano il mio interesse e che pretendono di essere letti, se possibile d’un fiato. In quei casi, si va alla cassa e via.
Durante una di queste mie ricorrenti visite in libreria, un giorno non meglio precisato dei primi anni del nuovo millennio, mi sento improvvisamente attratto dalla copertina di un libricino esposto tra le novità. Poche copie, posizione marginale. Il disegno in bianco e nero riproduce la scena più nota di uno dei film che maggiormente ho amato da ragazzo, Il mucchio selvaggio, grandissimo western crepuscolare della fine degli anni ‘60. Il libro si intitola La banda Bellini.
“Il mucchio… ma dai… è parecchio che non lo rivedo… uno di questi giorni, magari… e poi, questo titolo… ma sarà proprio lui, il mitico Bellini del Casoretto? Quanti anni sono passati… Lo avevo quasi dimenticato.”
Mi coglie come una vertigine, un gigantesco vortice di ricordi mi risucchia, e io mi ci abbandono, aggrappato a quel libro come un naufrago ad un relitto in un mare in tempesta…
Estate del 1974. Avevo appena terminato il secondo anno di superiori. Da due anni facevo parte del Collettivo studenti medi di Lotta Continua, cui aderivano praticamente tutti i miei amici. Con loro condividevo la passione politica e la pratica dell’antifascismo militante, che ci aveva da poco condotto a costituire il primo nucleo del servizio d’ordine studenti medi di LC della nostra città. Nel farlo ci eravamo ispirati ai due modelli milanesi che consideravamo leggendari: i Katanga del Movimento Studentesco dell’Università Statale e il servizio d’ordine del Collettivo del Casoretto, nato nell’omonimo quartiere popolare, di cui Andrea Bellini era il leader indiscusso.
Con l’inizio delle vacanze scolastiche, anche l’attività politica aveva inevitabilmente subito un notevole rallentamento, perciò chi di noi aveva potuto, cioè i più grandi, si era ficcato uno zaino in spalla ed era partito per qualcuna delle numerose mete “alternative” che popolavano la geografia vacanziera della sinistra militante. Io no, i miei genitori pensavano che la mia età anagrafica non fosse ancora adeguata a consentirmi di andare in giro per l’Italia con la sola compagnia di qualche amico lungocrinito. Perciò ero rimasto a godermi il caldo cittadino, con l’unico refrigerio offerto dalle spiagge lungo il fiume e la consolazione di condividere il tedio con i pochi compagni rimasti.
Come ogni giorno, ci eravamo dati tacito convegno nel primo pomeriggio al Bar Orchidea, luogo di ritrovo prediletto della galassia extraparlamentare cittadina. Eravamo stravaccati lì davanti già da un po’, indecisi sulla piega da far prendere alla giornata, quando qualcuno se ne esce con:
“Al cinema Castello danno un film di qualche anno fa, si intitola Il mucchio selvaggio. E’ un western e ho sentito che non è affatto male. Visto che non abbiamo niente di meglio da fare, potremmo anche andare a vederlo… Oltretutto è qui vicino e il biglietto costa poco… Alura, anduma o no?”.
Buona parte di noi, me compreso, non ne aveva mai sentito parlare prima ma, considerata anche la completa assenza di proposte alternative, dopo breve discussione la mozione veniva approvata. Poco dopo, in una mezza dozzina ci dirigevamo verso il cinema Castello, spettacolo pomeridiano.
(canzone messicana malinconica di sottofondo)
Pike Bishop si alza e silenziosamente si riveste. Intanto osserva la giovane prostituta che si sta tamponando intorno ai seni, alla ricerca di un qualche sollievo dal caldo opprimente. Lei ricambia lo sguardo, con dolcezza. Dietro di lui, all’improvviso, il pianto di un neonato. Pike lo guarda, ma ciò che vede in realtà è solo la lunga sequenza degli errori e dei crimini che lo hanno condotto a quel sudicio villaggio messicano con i resti della sua banda, braccato da una muta di cacciatori di taglie al soldo della ferrovia. È stanco. Stanco di fuggire, di vivere alla giornata, di rapine e sparatorie, di compagni che tradiscono in cambio di una manciata di dollari o della promessa di impunità. Un pensiero improvviso gli attraversa la mente: e se quella donna e quel bambino rappresentassero la possibilità di un nuovo inizio? Ma è solo un attimo. È troppo tardi e Pike lo sa bene, perciò spazza via l’idea con una scrollata di spalle e un sorso di whisky.
Ma c’è ancora tempo per sistemare un’ultima questione.
Allaccia il cinturone ai fianchi, si infila la tracolla con la terza pistola, quella automatica, paga la ragazza lanciandole un’ultima occhiata di rimpianto ed entra nella stanza vicina. Lì si trovano due degli altri superstiti della banda, i fratelli Gorch, Lyle e Tector. Stanno sostenendo un’animata discussione con una puttana in merito al prezzo del servizio ricevuto. Quando entra Pike la disputa si interrompe bruscamente. Entrambi volgono lo sguardo verso di lui. Dopo un momento di silenzio, Pike dice: “Andiamo”. Niente altro. Solo “Andiamo”. I due si scambiano un impercettibile cenno di muto assenso e quindi Lyle, tornando a volgersi verso Pike, risponde: “Si, Andiamo”. Nessuna esitazione, nessuna domanda mentre riprendono le loro armi e lo seguono.
Ad attenderli, seduto sulla strada polverosa all’esterno della modesta capanna imbiancata a calce, Dutch Engstrom, l’unico dei suoi uomini di cui Pike si sia sempre fidato ciecamente. Era con lui quando tutto è iniziato, ormai molti anni prima, e su di lui ha sempre potuto contare. È quello con cui Pike condivide le decisioni difficili e da cui accetta consigli, anche quelli non richiesti. Non questa volta, però. Non serve. Tra i due nessuna parola. Basta un rapido scambio di occhiate e anche Dutch capisce esattamente quello che stanno per fare. Si alza e, con una risata, approva.
È ora di andare a riprendersi Angel.
Ma cosa li aveva portati a questo punto, come ci erano finiti ad Agua Verde? Era stato quasi per caso, dopo un fallito tentativo di rapina, in realtà una trappola tesa dagli sgherri della ferrovia, e la fuga precipitosa che ne era seguita. Al loro arrivo ci avevano trovato acquartierato l’esercito di Mapache, uno dei generali che in quella zona combatteva contro Pancho Villa e la rivoluzione zapatista. Resosi conto che i bandidos gringos erano completamente al verde, Mapache aveva proposto a Pike un affare: rapinare un carico d’armi dell’esercito americano che stava per transitare nei pressi del confine in cambio di 10.000 dollari. Il colpo era riuscito e le armi erano pronte per essergli consegnate. Quasi tutte. Mancava una cassa di fucili, che Angel aveva voluto al posto della sua quota di ricompensa. Quelle armi erano per il suo villaggio, sostenitore di Pancho Villa e fino a quel momento completamente inerme contro le scorrerie dell’esercito controrivoluzionario.
Chissà come, Mapache lo aveva saputo e, al momento della consegna, aveva fatto arrestare Angel. Dopo averlo legato, i suoi uomini lo avevano agganciato al paraurti della sua auto ed el general, completamente ubriaco, aveva preso a trascinarlo per le strade sterrate del villaggio, tra risate, sputi e percosse. Gli altri quattro membri della banda, circondati dall’intero esercito, lì ad osservare, impotenti. Durante una sosta, Pike proponeva al generale di ricomprare la libertà del compagno con l’intera somma appena ricevuta. Inutilmente. L’auto ripartiva con il suo osceno traino, Angel ormai ridotto ad un unico, informe grumo di polvere e sangue.
(canzone tradizionale messicana cantata da un gruppo di soldati ubriachi a cui si sovrappone, fino a sostituirla completamente, un marziale rullo di tamburi)
Si avvicinano ai cavalli e, metodicamente, senza fretta, sfilano i fucili dalle loro fodere e ne controllano il funzionamento. Poi prendono dalle bisacce le cartucciere e le indossano a tracolla. Le altre munizioni se le infilano nelle tasche. E così equipaggiati iniziano a camminare.
Sono uno di fianco all’altro e avanzano con passo deciso, ma non frettoloso. I soldati che incontrano sul loro cammino prima li osservano stupiti, poi si scostano velocemente, liberano il passaggio. C’è qualcosa di inesorabile nell’incedere di quei quattro che fa desiderare di non incrociare la loro strada, qualsiasi essa sia…
Si dirigono verso il quartier generale di Mapache, una corte in cui lui ed i suoi ufficiali sono riuniti a gozzovigliare.
“Ah, los gringos, otra vez…” li apostrofa con fastidio il generale al loro arrivo.
“Cosa volete?”
“Vogliamo Angel.” dice Pike. Questa volta non offre nulla in cambio. Non è una trattativa e il suo tono di voce lo rende inequivocabile.
Mapache scoppia in una risata: “Ci tenete tanto? Va bene, ho deciso di accontentarvi…” risponde chinandosi ad afferrare il moribondo.
“Vamos Angelito … estas libre…” gli dice sorridendo.
Lo solleva, impugna un coltello e gli libera le mani. Poi lo conduce verso Pike, ma quando gli arriva di fronte, in una sorta di ultimo insulto, con un rapido gesto gli taglia la gola e lo uccide.
La reazione di Pike e Dutch è istintiva e immediata. Svuotano i caricatori delle loro pistole sul generale, lasciandolo morto di fronte ai suoi uomini.
Nel silenzio che segue il tempo subisce una sospensione, si ferma. L’intero esercito è completamente disorientato dalla morte improvvisa del proprio capo e gli uomini reagiscono deponendo le armi ed alzando le mani. Gli stessi ufficiali sembrano pietrificati. Nessuno si muove, nessuno parla.
Pike ed i suoi tre compagni realizzano di avere la situazione in pugno. Potrebbero andarsene in quel momento e non incontrerebbero alcuna resistenza. Fino a pochi giorni prima lo avrebbero fatto senza alcun indugio. Ora no. Non dopo la morte di Angel. Eppure di morti ne avevano visti nel corso di quegli anni, anche dei loro… Angel però era diverso. Per la prima volta avevano visto morire un compagno in nome di una causa. Angel lo aveva fatto per il suo villaggio, per proteggere quei bambini, donne ed anziani che solo pochi giorni prima li avevano accolti con grande ospitalità, malgrado il rischio che sapevano di correre nascondendo dei bandidos gringos in fuga. Erano i compagni di Angel, e tanto bastava. Per la difesa di quei campesinos il loro compagno aveva rischiato, e perso, la vita. Ora sentivano che la sua morte li chiamava ad una scelta di campo, chiedeva di prendere posizione. A loro decidere se raccogliere quel testimone. Sì, proprio a loro, un branco di banditi che avevano passato la vita a rapinare, saccheggiare, uccidere e che, pur di intascarsi qualche dollaro da spendere in whisky e puttane erano sempre stati pronti a qualsiasi misfatto…
Pike guarda Lyle, Tector e, infine, Dutch, che scoppia in una fragorosa risata. Anche gli altri sorridono, poi si girano e iniziano a sparare.
Al termine del film non si sentiva volare una mosca. Nessuno di noi fiatava, forse per il groppo dell’emozione ancora in gola. Gli ultimi venti minuti poi ci avevano letteralmente tramortito. Quando finalmente abbiamo recuperato l’uso della parola, ci siamo resi conto di quanto tutti ci sentissimo galvanizzati. I commenti eccitati si accavallavano, le citazioni dei momenti più emozionanti rimbalzavano da una bocca all’altra in una sorta di gara a chi ne ricordava meglio i particolari ed i dettagli, e qualcuno già iniziava ad abbozzare l’inevitabile analisi storica e politica. La verità era che eravamo rimasti affascinati soprattutto dalle figure dei protagonisti, una banda di balordi senza speranza capaci di quel gesto di redenzione finale, così rivoluzionario e così bello…
Autunno/inverno del 1974. Il servizio d’ordine degli studenti medi viene convocato al gran completo per una riunione con il responsabile cittadino. Siamo tutti comprensibilmente eccitati, qualcosa bolle in pentola: “Voi ne sapete qualcosa? Dai, tu sei suo fratello, possibile che non ti abbia detto niente?”. Nel corso della riunione veniamo informati che LC sta organizzando una manifestazione per la liberazione di un compagno, tal Segantini, in quel momento detenuto presso le carceri della nostra città. A Pavia ci si conosce tutti, è una città piccola, ma questo nome non ci dice nulla, perciò qualcuno di noi domanda: “Ma chi sarebbe questo Segantini?”. Il capo allora ci fornisce qualche dettaglio in più: “E’ uno del Casoretto. Naturalmente ci saranno anche loro. Visto che molti arriveranno in treno, abbiamo previsto di organizzare il concentramento al Piazzale della Stazione. L’aria è pesante e non sappiamo ancora se la manifestazione sarà autorizzata dalla questura. Quando arrivano dobbiamo già essere lì. Noi conosciamo meglio di loro la città e gli sbirri della squadra politica. Dobbiamo vigilare per evitare infiltrazioni o provocazioni. Credo che il Casoretto pretenderà la testa del corteo. Ne stiamo ancora ragionando. In quel caso voi coprirete la coda. Domande? Mi raccomando, occhi aperti e nessuna cazzata. Ripeto: nessuna cazzata, intesi?”
Il pomeriggio della manifestazione, come concordato, siamo tra i primi ad arrivare al Piazzale della Stazione. Ci posizioniamo in un angolo da cui poter avere un buon colpo d’occhio su tutta la piazza. La situazione non è rosea. Nelle vie adiacenti si nota, folta, la presenza di polizia e carabinieri. L’unica strada al momento libera è quella che porta verso Piazza Minerva. “Si saranno piazzati all’altezza di Corso Cavour, per impedirci di raggiungere il Tribunale e le carceri…”, penso.
Nel frattempo ci raggiunge il nostro responsabile e ci informa che il corteo è stato autorizzato, ma con il tassativo divieto di attraversare le vie del centro. Ci fa capire che l’intenzione è di provarci comunque. Lo spezzone del Casoretto sarà in testa, è confermato. Toccherà a noi proteggere la coda, come già stabilito. Non sarà una giornata facile…
A noi medi si aggiungono alcuni “irregolari”, compagni che non sono studenti ma fanno parte del nostro giro. In tutto siamo una trentina. Ci avviciniamo al camioncino di LC per recuperare gli stalin, così come chiamiamo la nostra arma d’ordinanza. Si tratta in realtà di un robusto manico di piccone avvolto in uno striminzito drappo rosso, che gli conferisce le apparenti sembianze di bandiera dalle proporzioni assurdamente incongrue. Ci annodiamo quindi i fazzoletti intorno al collo e ci schieriamo come di consueto. Sarà che sono teso, ma mi sembra che faccia un freddo cane.
Intanto la piazza si sta riempiendo. La partecipazione dei compagni di Pavia si annuncia massiccia, ma ancora nessuna notizia dal Casoretto.
All’improvviso, come un tuono, una raffica di slogan scuote la stazione.
E’ come un sasso gettato in uno stagno: il concentramento si anima, le teste si girano, l’attenzione è tutta rivolta verso la porta della stazione.
Sono loro, sono quelli del Casoretto. Quando iniziano ad uscire, ci rendiamo conto che sono un gruppo numeroso, più o meno duecento, e che sono molto ben organizzati. Mentre continuano a lanciare slogan, in men che non si dica si schierano in file da dieci, compatti e ordinati. I primi cinque cordoni sono costituiti da compagni che indossano tutti uno spolverino doppiopetto verde militare. La cintura che lo stringe in vita evidenzia, qua e là, qualche gonfiore sospetto, che lascia intuire come gli stalin che impugnano non siano le uniche armi improprie in loro possesso. Al collo portano una mascherina bianca, quella tipo reparto verniciatura di una fabbrica metalmeccanica, sicuramente più efficace dei nostri fazzoletti rossi contro i lacrimogeni. E’ il loro servizio d’ordine, è la Banda Bellini.
Nelle file seguenti si notano molti tascapane. Sembrano gonfi e pesanti… Nel frastuono degli slogan che si susseguono senza soluzione di continuità, si distingue un vocione tonante. Proviene da un compagno posto ad un’estremità del loro primo cordone, un omone alto quasi una spanna più di chiunque altro, capelli lunghi e biondi, coppola calata sugli occhi. Ciò che si nota del viso, anche a distanza, sono soprattutto i baffi folti e spioventi. “Ragazzi, questi sì che fanno paura… Sono cazzutissimi… E avete visto il “comandante” Bellini? Guardate come prendono tutti ordini da lui…”. Il carisma che sprigiona quell’uomo è davvero straripante, lo si percepisce quasi fisicamente anche a quella distanza. Tutto il Casoretto si muove intorno a lui come un sol uomo.
Lo schieramento è impressionante. L’esibizione di questa potenza, a un tempo evidente e trattenuta, ci fa sentire all’improvviso disorientati, insicuri. La nostra abituale spavalderia vacilla e quei ranghi compatti sembrano trasformarsi in uno specchio che restituisce ad ognuno di noi il riflesso delle proprie più segrete fragilità ed inconfessabili paure. Ma è solo un momento. Il corteo parte e noi siamo richiamati al nostro compito. Serriamo i cordoni e attendiamo che la manifestazione ci sfili davanti per poi posizionarci, come stabilito, in coda. Quando passa lo spezzone del Casoretto cerchiamo di darci l’aria di quelli che la sanno lunga, tipo “Tranquilli, ci siamo noi a coprirvi…”. I nostri volti lividi raccontano però un’altra storia…
Direzione Piazza Minerva. Lì, secondo il percorso autorizzato, il corteo dovrebbe girare intorno allo spartitraffico e prendere a destra, su Viale della Libertà. In realtà, vediamo lo striscione di testa tirare dritto senza esitazione verso Corso Cavour e il centro città. Nel farlo il corteo lascia alla propria sinistra il bar Minerva, noto covo di fascisti. Le serrande sono abbassate. Oggi non è proprio aria per i fasci…
All’altezza dell’incrocio con via Palestro, dove Corso Cavour si restringe drasticamente, il percorso è bloccato da un massiccio schieramento di reparti della Celere. Sembra davvero difficile passare di lì. Eppure il corteo prosegue, neanche accenna a cambiare direzione. Quando lo striscione di testa arriva ad una cinquantina di metri dalla prima linea dei celerini, improvvisamente ci blocchiamo. Dalla coda non è che si capisca granché di ciò che sta succedendo, ma sappiamo di dover rimanere lì, perciò ci limitiamo ad allungare i colli e ad aguzzare occhi e orecchie. In quell’immobilità, intanto la tensione cresce, si sta facendo quasi insopportabile…
A un certo punto sentiamo il gracidio di un megafono. Non riusciamo a sentire bene da quella distanza, ma riconosciamo la voce di un dirigente della questura: ci sta intimando di scioglierci. In caso contrario partirà la prima carica. Ci prepariamo allo scontro, e intanto controlliamo le possibili vie di fuga verso cui indirizzare i partecipanti al corteo e verifichiamo la consistenza delle forze dell’ordine alle nostre spalle. Davvero strano: non c’è neanche uno sbirro…
Mentre stiamo ancora effettuando le nostre verifiche, dalla testa del corteo parte la più fitta sassaiola a cui ci sia mai capitato di assistere. Dura pochi istanti, e termina improvvisamente, così come era iniziata. Quasi simultaneamente vediamo levarsi, come in un solo gesto, una selva di chiavi inglesi. E’ allora che sentiamo il vocione di Andrea Bellini urlare con tutto il fiato che ha in gola: “Caricaaaa!!!”. “Cazzo, il Casoretto sta caricando la Celere!!! E noi siamo bloccati qui dietro a presidiare il deserto dei tartari!!!”.
Le urla e gli slogan che intanto si levano sono assordanti e in men che non si dica il corteo riparte, riparte di corsa!!! Verifichiamo un’ultima volta di non avere proprio nessun pulotto alle calcagna e ci mettiamo a correre come pazzi anche noi. Intanto però continuiamo a tenere d’occhio gli incroci che via via superiamo: niente, neanche un poliziotto, sono come evaporati…
Siamo finalmente in Piazza del Tribunale e gli slogan diventano un ruggito, lo stesso che si leverà poco più avanti, in via Romagnosi, all’altezza delle carceri. Siamo padroni della città e lo resteremo per tutto il resto del pomeriggio. Una volta ricomposti, i reparti della Celere si limiteranno a tenerci d’occhio a distanza di sicurezza. Profilo basso e morale sotto i tacchi, quasi ci dispiace per loro…
Dopo un po’ ci raggiunge un compagno che aveva assistito da vicino alla carica del Casoretto. Era ancora eccitatissimo: “Che storia, ragazzi… Quasi da non crederci… Già vedere il tempismo perfetto con cui hanno sguainato le chiavi inglesi è stato pazzesco… Quando Bellini ha ordinato la carica, i compagni hanno prima fatto una decina di metri al passo, ancora perfettamente allineati… Poi, quando sono partiti di corsa gridando come indemoniati, che hanno fatto i celerini?? Bè, i celerini sono scappati!!! Cazzo, come se la filavano… E avreste dovuto vedere le loro facce… Già la sassaiola li aveva scompaginati, ma con la carica se la sono proprio fatta sotto… Sono stati presi così alla sprovvista che non hanno tirato neanche un lacrimogeno… Ragazzi, che storia…”.
Mi ritrovo di nuovo in libreria, con quel librettino ancora stretto nelle mani e con lo sguardo che fatica a tornare al tempo presente. Era stata una giornata radiosa, anche se non era stato lo shakespeariano sole di York a illuminarla ma solo il cielo grigio e brumoso della bassa padana…
Non ne avremmo più vissute molte, di giornate così, nei mesi e negli anni seguenti. Già, perché poi arrivarono le sprangate alle femministe e tra compagni, le pistole prima solo sventolate e poi anche utilizzate nei cortei, la lotta armata, la repressione, l’eroina, il riflusso. Dopo un decennio di lotte, l’ordine fu infine ristabilito. E la generazione rivoluzionaria che aveva osato urlare che il sistema del capitale non si può riformare ma solo abbattere era stata sconfitta. Ma questa parte della storia oggi non ho voglia di ricordarla, non con questo libro in mano.
Guardo di nuovo la copertina, e all’immagine dei bandidos gringos del Mucchio Selvaggio vedo ora sovrapporsi quella della Banda Bellini, cinque file da dieci, volto coperto, stalin in mano e chiave inglese in tasca.
E nella mia testa risuona di nuovo quel vocione, mi sta gridando: “Mapache e tutti i bastardi come lui sono ancora lì, andiamo!”
Si, Andiamo.
In memoria di Andrea Bellini (1951 – 2016)
Complimenti Andrea, mi hai fatto tornare indietro di mezzo secolo, lo stesso tempo trascorso da quando ci siamo persi di vista. Mi ricordo di Roberta piccolina nella tua casa al quartiere Scala. Un abbraccio, Massimo Rocchini