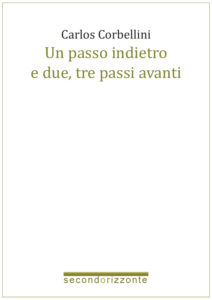
Il Gordo Madera non era un tipo agile. Saranno stati i suoi cinquant’anni e qualcosa o il doppio di quella cifra in chili o il suo passo lento, di sicuro non era un tipo reattivo il Gordo Madera. Alto, robusto, di umili origini, dall’aspetto non propriamente curato, aveva studiato un po’, ma era profondamente ricco di esperienze.
Noi più giovani lo ascoltavamo con attenzione, portava con sé una storia piena di lotte sindacali di altri tempi, conosceva la genesi dei più importanti partiti di sinistra e diversi aneddoti sui loro fondatori.
Ci mettevamo in cerchio intorno alla stufa a gas, sempre ardente nei gelidi corridoi di Rawson. Senza libri né diari né riviste, prendevamo tutto il sapere possibile dalle sue parole. Apprezzavamo le sue testimonianze intense, a volte ci pareva di distinguere il fumo delle sigarette delle riunioni di cui raccontava, i borbottii di fondo delle assemblee proletarie e persino la tensione prima della rappresaglia.
Perciò spesso non badavamo molto alla sua trasandatezza, né alla sua tendenza ad accumulare cose completamente inutili che conservava nel caso servissero.
Il Gordo era una miniera di storie da ascoltare, memorizzare e ripassare più tardi, nella solitudine della cella.
Peccato che non tutti apprezzassero alla stessa maniera i suoi racconti, il suo passo lento e riflessivo lungo i corridoi. Soprattutto le guardie, lente come lui, occupate nel faticoso lavoro di aprire e chiudere lucchetti o di gridare ordini senza senso, e invece sveglie e energiche nell’intervenire quando si trattava di castigare qualcuno dei detenuti.
Come un fuoco sadico che li animava all’improvviso, in modo primitivo, irrazionale, inumano sarebbe giusto dire, se non fosse che l’umano contiene anche la malignità.
Cosa guarda fuori dalla finestra? Non sa che il regolamento lo proibisce?
Ah, signor carceriere, ha notato il volo di quel gabbiano? Plana e sembra fermo…
Il volo dei grandi gabbiani del litorale atlantico della Patagonia era l’unico spettacolo degno di contemplazione in quel quadrato reticolato di cielo azzurro che si intravedeva dalla cella.
No, il signor carceriere non sapeva apprezzare la bellezza del volo libero di un gabbiano.
E al Gordo toccò trascinare le sue lente ossa verso uno spazio meno confortevole, la prigione del castigo, l’isolamento.
La decisione non lo sorprese, il Gordo Madera non era nuovo a quei luoghi inospitali.
Il meccanismo trasgressione-castigo-più castigo, il Gordo lo conosceva sin da Sierra Chica, in mezzo alla pianura pampeana, un altro luogo poco accogliente, come lo avrebbe definito con la sua solita parsimonia.
Là, da giugno del ’78 fino all’aprile del ’79, trascorse più tempo in isolamento che insieme a noi. La guardia esterna aveva scoperto delle denunce sulla la stampa estera, in occasione del Mundial ’78 che il Gordo aveva scritto di suo pugno, parola per parola. La guardia interna non ebbe dubbi nell’applicazione del braccio violento della legge carceraria.
Novantotto giorni dopo, provato dalle punizioni corporali e dalla scarsa alimentazione, tornò tra i suoi compagni.
Noi stavamo organizzando uno sciopero della ricreazione che sicuramente avrebbe provocato rappresaglie.
Non è il caso che partecipi, dato il tuo stato attuale, gli dicemmo.
Non se ne parla, non è facendo un passo indietro che si vincono le battaglie, sentenziò.
La sua punizione si prolungò per altri 123 giorni, fino a che il Controllo centrale decise di chiudere il carcere di Sierra Chica e smistare i detenuti in diverse prigioni.
Il Gordo fu mandato a Rawson. ebbe un momento di tregua finché, ammirando il volo dei gabbiani, ricominciò il suo calvario. Castigo, isolamento, punizione su punizione. Si sommavano i giorni, le settimane, i mesi, senza poter guardare il solito scorcio di cielo a scacchi.
Quando il Gordo tornò tra noi, appariva molto magro, debole, quasi senza voce.
Già nel 1981, una guardia lo pescò nei bagni che urinava poco più di un minuto oltre il tempo permesso. Allora, giovani come eravamo, non sapevamo dell’esistenza di quel minuscolo organo chiamato prostata. Nemmeno le guardie comprendevano motivazioni di tipo organico, quindi: ritorno alle segrete.
Cominciammo a preoccuparci seriamente per le sue condizioni di salute e qualcuno temeva per la sua lucidità mentale. Dei circa tremila giorni di detenzione, ne aveva accumulati 1.253 in cella d’isolamento, un trattamento riservato nemmeno ai capi guerriglieri.
In quei giorni, ricevemmo la notizia che il Gordo si stava rifiutando di consumare i pasti.
Da solo, imprigionato, senza contatti con l’esterno, nell’immensità della Patagonia, il Gordo Madera aveva iniziato uno sciopero della fame!
L’avvenimento provocò non poco sconcerto tra di noi. La sua decisione era stata spontanea, solitaria, senza alcun tipo di preavviso o di preparazione.
Non è possibile, non è in condizioni, affermavamo.
Passò un giorno, due, una settimana e lo sciopero della fame continuò.
Le notizie arrivavano frammentate. Trascorse così anche una seconda settimana e il Gordo non mollava, continuava a non mangiare. Inoltre, da due giorni si era persino rifutato di bere. Sciopero della fame e della sete!
La situazione si era fatta seria, grave.
In caso di debolezza estrema, era consuetudine portare il detenuto una settimana in infermeria per poi farlo tornare nelle celle gelide.
Ma come avrebbero fatto con un prigioniero che rifiutava d’ingerire cibo?
Avrebbero usato l’alimentazione forzata o l’avrebbero ignorato, lasciandolo morire, come aveva fatto la Thatcher con Bobby Sands?
Il quindicesimo giorno venimmo a sapere che il Gordo con altri tre detenuti era stato imbarcato su un aereo per Buenos Aires, diretto alla nuova prigione di Caseros.
Il Gordo Madera aveva vinto la sua battaglia e noi sospirammo di sollievo.
Quattro mesi dopo, lo stesso decreto del Potere esecutivo ci fece ritrovare insieme in una lista in cui ci concedevano la libertà vigilata.
Il destino volle che condividessi con lui, in una cella multipla col gabinetto in un angolo, le ultime ore di detenzione. Fu il preludio al tanto sospirato momento della scarcerazione.
Tutti noi ci eravamo liberati delle cose che possedevamo in prigione, cercando di uscire il più leggeri possibile. L’imprigionato non porta con sé nulla di materiale di ciò che aveva in prigione, sentenziavamo. Al massimo era concessa qualche lettera ritirata dalla Censura.
Al Gordo Madera venne consegnato un sacco colmo dei più svariati oggetti che si erano accumulati nelle sue varie peregrinazioni di cella in cella. Essendo quasi sempre in isolamento, le guardie accumulavano i suoi averi all’interno di sacchi della spazzatura, senza badare a selezionarli.
Il Gordo vide il sacco e iniziò a rovistare, pensando alla vita austera che lo aspettava al di là delle sbarre, a casa sua. Lungi dal buttare via quegli oggetti impregnati della sofferenza del confinamento e degli abusi, il Gordo si sedette e cominciò a sceglierli attentamente, uno per uno.
Una stufetta a cherosene? Mi serve, e la infilava nel sacco.
Una calza bucata? Non mi serve, e la abbandonava sul pavimento.
Un quaderno con metà delle pagine scarabocchiate? Strappò i fogli usati lasciandoli sul pavimento. Il quaderno? mi serve, nella borsa.
Una camicia stropicciata con un colletto logoro? Mia moglie aggiusterà il colletto, nel sacco.
Resti di tabacco, pacchetti di yerba a metà, magliette bucate, avanzi di salamini, vecchie zucche per il mate ammuffite, bottoni rotti, fogli con disegni che descrivevano il volo dei gabbiani, stracci di diverse dimensioni, penne scariche, pezzi di legno con incisioni lasciate a metà, fiammiferi usati, pezzetti di cartine per rollare le sigarette incollati insieme
Elementi che solo in una vita di reclusione e di assurde privazioni potrebbero accumularsi. Ora il Gordo li rifiutava, facendone un mucchio di quasi un metro di altezza, al centro della cella temporanea.
Chiuse il sacco con gli oggetti utili e si considerò pronto ad andarsene.
Quando la guardia vide il mucchio di rifiuti organici e inorganici che adornavano il centro della stanza, iniziò a urlare. Udimmo per l’ennesima volta una serie di insulti e minacce, addirittura peggio di quelli che sentivamo ogni volta che lo rinchiudevano nelle celle di isolamento.
Un brivido ci scosse.
La guardia, aumentò il volume delle sue urla, ordinandogli di raccogliere tutta quella merda. Il Gordo, dal canto suo, continuava a camminare con calma, assorbito da chissà quali pensieri. Mentre camminava piano, oltrepassò per un attimo la soglia della porta.
All’improvviso si fermò, guardò la guardia e disse:
Certo, devo proprio.
La guardia si calmò e lasciò passare il Gordo che, in quel momento, solo in quel preciso momento dei suoi 2.832 giorni di detenzione, per la prima volta, fece un passo indietro.
Il Gordo Madera tornò in cella, si sbottonò la patta dei pantaloni, lo tirò fuori, lo portò all’angolo della cella dove c’era il gabinetto, e iniziò una lunga, lenta pisciata, uno scroscio infinito, interminabile. Da quell’uretra usciva un torbido fiume di urina, un liquido dal colore scuro come le prigioni prive di finestre, dall’odore acre come quello dei succhi gastrici prodotti dalla fame, dal rumore secco come lo scricchiolio delle ossa sui letti di cemento. La guardia, guardava impotente.
Quando finalmente varcammo la soglia oltre quel recinto, il sole ci colpì in faccia con tutta la sua forza. Nel bagliore, vidi solo macchie gialle intorno a me, ma giuro di aver visto anche lui. Ho visto il Gordo uscire dalla prigione, accanto a me.
Lo vidi col suo zaino improvvisato sulla schiena. Lo vidi fare un passo e poi due passi.
Lo vidi fare il terzo passo e… come i maestosi gabbiani patagonici che ammirava dalla sua finestra, lo vidi spiccare il volo. Un volo deciso e sereno. Lo vidi volare e tornare da noi per salutarci e poi immergersi nel profondo blu del cielo. Il cielo, non più inquadrato dai reticoli, della sua libertà.
